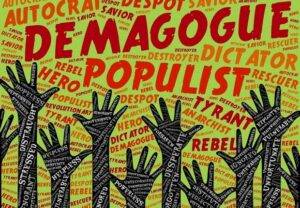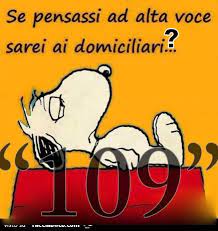Apri TikTok per un minuto e dopo mezz’ora sei ancora lì a guardare video senza senso. Un flusso infinito di contenuti brevissimi, ottimizzati per catturare lo sguardo e tenere l’utente agganciato all’amo.
Un ministro dice che l’acqua può uccidere e i giornali non parlano d’altro per giorni e giorni. Se cerco su Amazon “scarpe da running” l’ordine con il quale mi verranno presentate le diverse opzioni non sarà certo casuale. Così come non è casuale il modo in cui i prodotti vengono disposti sugli scaffali dei supermercati. Sono solo dei piccoli esempi di quanto l’attenzione sia da tempo diventata un bene economico raro, prezioso e contendibile.
Nella tradizionale definizione data da Lionel Robbins nel suo Essay on the Nature and Significance of Economic Science, l’economia è “quella scienza che studia la condotta umana nel momento in cui, data una graduatoria di obiettivi, si devono operare delle scelte su mezzi scarsi applicabili ad usi alternativi”. Dati gli obiettivi che ci vogliamo prefiggere, come dovremmo allocare le nostre risorse quando queste possono essere utilizzate per finalità differenti? Trovare risposte a questa domanda è ciò di cui l’economia si occupa. Pensiamo alla terra. Dovremmo costruirci sopra abitazioni, fabbriche, infrastrutture o dovremmo adibirla ad uso agricolo o per l’allevamento di bestiame? Tenendo conto che se facciamo una cosa, con la stessa terra non potremmo farne un’altra (fini alternativi) e che la terra non è infinita, ma scarsa. Pensiamo al lavoro. Se ci impegniamo in una certa attività, non potremmo dedicare quelle energie ad altro. Su cosa conviene concentrarsi, quindi, dati i nostri obiettivi? Che dire del capitale poi: ci serve di più un macchinario, un capannone, un ponte. E il capitale finanziario? Se scegliamo di investire in un certo progetto, con gli stessi fondi non potremmo finanziarne nessun altro.
Nel tempo, a fianco agli elementi di questa “classica trinità” – terra, lavoro, capitale – già centrale nel lavoro di Adam Smith, via via che la struttura della società e dell’economia stessa mutavano, se ne sono aggiunti molti altri. Nuove risorse sono diventate scarse e, quindi, sempre più importanti. Il tempo, per esempio, o l’informazione di qualità e la tecnologia sono tutti diventati temi centrali della riflessione economica.
Qual è oggi la più importante di queste risorse? Su cosa occorre concentrare i nostri sforzi di comprensione e di azione? Secondo George Loewenstein e Zachary Wojtowicz è certamente l’attenzione. Ce lo spiegano bene in un saggio intitolato appunto “The Economics of Attention” appena pubblicato sul prestigioso Journal of Economic Literature. “Incorporare l’attenzione nel discorso economico è naturale – scrivono Loewenstein e Wojtowicz, dato che possiede le stesse proprietà chiave che contraddistinguono le risorse produttive più consolidate; ad esempio, poiché l’attenzione è scarsa e può essere impiegata in una varietà di usi produttivi concorrenti, genera costi-opportunità.
Allo stesso tempo, considerare l’attenzione come un’autentica risorsa rappresenta un importante progresso concettuale perché estende la scienza economica allo studio esplicito della produzione mentale, piuttosto che solo fisica. Un’analisi dell’attenzione fornisce anche una comprensione più sfumata di altri fattori produttivi intangibili che sono diventati pilastri del pensiero economico, come il capitale umano, l’informazione e la tecnologia” (2025, p. 1039).
Le ragioni perché gli economisti debbano occuparsi del tema dell’attenzione non mancano, quindi nell’impostazione di Loewenstein e Wojtowicz. Si può aggiungere il fatto che l’attenzione interagisce sia con la produzione che con il consumo. Molte attività, infatti, sono in larga parte, consumi di attenzione: se non ti concentri non produci valore.
Se non ci noti, non compri i nostri prodotti. In un’economia in cui piattaforme e app vendono “engagement”, lo sforzo e il tempo mentale sono moneta. Ci sono poi tutta una serie di comportamenti apparentemente anomali, in ambito finanziario, per esempio, come reazioni esagerate alle notizie positive o negative, la sistematica sottovalutazione dei rischi sistemici, la procrastinazione e lo scarso peso che diamo alle scadenze, che possono essere compresi in maniera più accurata se pensiamo che l’informazione deve competere per ottenere quella risorsa scarsa che è la nostra attenzione.
C’è infine un altro tema particolarmente rilevante che riguarda le implicazioni che nascono dall’utilizzo sempre più massiccio degli strumenti di intelligenza artificiale. Molti di questi, infatti, sottraggono attenzione, altri la amplificano, altri ancora la redistribuiscono. Capire se l’IA sostituisce o integra l’attenzione umana è cruciale per prevedere come cambierà il lavoro e la distribuzione del reddito nel prossimo futuro.
Nel 2013 Daniel Goleman pubblica il suo libro intitolato Focus. Lo scrive “per il benessere delle generazioni a venire”. Come altri (ancora troppo pochi ahimè), Goleman si è reso conto che nell’era delle infinite soluzioni, degli innumerevoli stimoli e del sapere alla portata di tutti, una delle risorse che maggiormente scarseggiano è quella della nostra attenzione.
Ma cosa intendiamo esattamente quando parliamo di “attenzione”? Per l’American Psychological Association si tratta di “uno stato in cui le risorse cognitive sono focalizzate su alcuni aspetti dell’ambiente piuttosto che su altri”. Loewenstein e Wojtowicz, sintetizzando una grande quantità di studi, propongono di definirla attraverso quattro caratteristiche chiave. L’attenzione è, innanzitutto, “scarsa”, non ne abbiamo a una quantità infinita; è “rivale”, cioè, si consuma con l’uso; se ti concentri su un oggetto od un processo, non puoi farlo su altro; è “cognitiva”, vale a dire, è necessaria per ottenere e processare informazioni; Infine è almeno parzialmente “volizionale”, possiamo, cioè, entro certi limiti, decidere dove dirigerla, attraverso lo sguardo o il pensiero.
Si inizia a comprendere, forse, perché definita in questo modo non è strano pensare all’attenzione come a un fattore produttivo, alla stregua della terra o del capitale, con costi-opportunità e mercati che prendono forma attorno ad essa. Una risorsa soprattutto scarsa e paradossale. Già nel 1977 il premio Nobel per l’economia Herbert Simon aveva notato come una eccessiva ricchezza di informazioni potesse portare, paradossalmente appunto, ad una povertà di attenzione e come una buona teoria delle decisioni si dovesse occupare anche “dei processi di selezione degli aspetti dell’ambiente su cui concentrare l’attenzione, dei processi di generazione di alternative e dei processi di scelta tra le alternative. Nella progettazione di questi processi, la conservazione dell’attenzione e dello sforzo computazionale – scrive Simon – è una questione fondamentale” (Simon, H. A., & Blumenthal, M. Models of discovery: And other topics in the methods of science. Springer, 1986).
I tre motori dell’attenzione
Ma l’economia non si occupa solo di definire quali sono le “risorse” ma anche di discutere come queste vengono allocate. Per quanto riguarda l’attenzione, possiamo individuare tre processi allocativi fondamentali. Il primo è un processo che possiamo definire “bottom-up” o stimulus-driven: l’attenzione viene attivata e direzionata come risposta automatica ad elementi esterni, come luci, colori, movimento, ma anche stimoli sociali come lo sguardo degli altri o una voce che chiama il nostro nome. Il secondo processo può essere definito, al contrario, “top-down” o goal-driven: la volontà, le intenzioni, i progetti e le credenze ci fanno dirigere l’attenzione verso alcuni aspetti particolari e non altri. Cerchiamo informazioni utili per prendere una decisione, così leggiamo o ricerchiamo sul web ciò che ci serve; se vogliamo superare un esame ci concentriamo sui libri e resistiamo alla tentazione di scrollare le nostre pagine social. Il terzo processo è di natura “motivazionale”, è guidato dalle emozioni: stati emotivi viscerali come la noia e la curiosità che influenzano il controllo volontario dell’attenzione. Se ci annoiamo cambiamo canale o smettiamo di leggere, se qualcosa ci incuriosisce siamo spinti ad una maggiore concentrazione, se entriamo nel “flow”, poi, niente potrà distogliere la nostra attenzione da quello che stiamo facendo, scrivendo, ascoltando. Questo processo funziona come una sorta di “pilota automatico” che ci risparmia di dover deliberare ogni volta sulla scelta de ciò a cui dedicare la nostra attenzione.
Temi classici e vincoli attentivi
Cosa ci dice di nuovo l’economia dell’attenzione sui i grandi temi classici dell’economia. Partiamo dal consumo. In questo caso si capisce meglio come la “salienza” diriga le scelte. Ciò che è saliente, infatti, assume un peso preponderante nelle nostre valutazioni. Quando un prodotto presenta molte caratteristiche – prezzo, peso, qualità – il modo in cui queste vengono presentate cambia la distribuzione dell’attenzione e quindi le nostre scelte. Davanti a più elementi che possono influenzare le nostre decisioni noi non li consideriamo tutti, proprio perché la nostra attenzione è limitata, ma li campioniamo. Quando unop degli elementi è reso più saliente, allora la nostra attenzione viene dirottata su quello che diventa dominante nell’influenzare la scelta. È il caso della shrinkflation. Vediamo che quel pacco di pasta che prima pagavamo un euro e mezzo ora è pubblicizzato sullo scaffale del supermercato a solo un euro. Lo compriamo e solo dopo, forse, ci accorgiamo che di pasta in questo pacco ce n’è solo 400 grammi e non i 500 dei pacchi tradizionali. Il prezzo è una dimensione saliente, che cattura la nostra attenzione, la quantità invece no.
Stesso discorso vale per la relazione tra salienza e giudizi probabilistici. Perché la vividezza batte la statistica. Per cui i “rischi viscerali” legati ad eventi rari ma salienti – attacchi di squalo, incidenti aerei, crimini violenti – fanno si che tali eventi vengano sovrastimati rispetto a rischi statisticamente più letali ma meno impressionanti, come le malattie cardiovascolari o il diabete. Questo porta a politiche e consumi che non riflettono le probabilità reali ma le percezioni dei cittadini.
Questi fenomeni hanno anche una dimensione sociale che deriva dalla nostra interazione con gli altri perché molto spesso ciò che gli altri fanno cattura la nostra attenzione. Ciò che viene percepito come una norma sociale, perché vediamo che è ciò che gli altri generalmente fanno in una certa situazione, diventa automaticamente più saliente e influenza la nostra disponibilità a cooperare o genera conformismo. Il successo immediato e inatteso di certe mode, di certi prodotti, di certi locali, di artisti o di modi di dire sono tutte manifestazioni di un’attenzione collettiva che si focalizza su un oggetto piuttosto che un altro. Uno tra i molteplici equilibri su cui le scelte si sarebbero potute concentrare.
Un altro aspetto rilevante è il fatto che l’attenzione modella la memoria: ciò che cattura la mente è più probabile che venga memorizzato, e ciò che memorizzi alimenta scelte future. Per questa ragione l’attenzione limitata a volte genera reazioni esagerate mentre altre volte solo inerzia, il tutto s seconda della complessità dell’ambiente e di come l’informazione viene presentata e memorizzata.
In ambito educativo, ogni momento di attenzione persa è un po’ di capitale umano non generato. Un’ora di lezione persa o seguita male da uno studente che magari giochicchia tutto il tempo con il cellulare si traduce in competenze non acquisite e che probabilmente non verranno mai più recuperate. Le implicazioni sono chiare. Occorre investire nel modo in cui l’ambiente educativo viene progettato in modo che nel processo di apprendimento l’attenzione venga attivata e mantenuta nel tempo. Non basta per un insegnante dire le cose giuste se queste non vengono recepite dai suoi studenti
Anche per il funzionamento delle organizzazioni, considerare il ruolo dell’attenzione può fornire indicazioni interessanti. La letteratura sul cosiddetto “choking” mostra, per esempio, come incentivare troppo i lavoratori può far peggiorare la performance perché fa inceppare il meccanismo attentivo. Quando la posta in gioco è molto alta l’attenzione si sposta sulla ricompensa e sul rischio di perderla e viene sottratta al compito da svolgere che quindi ne risente. Così, aumentare i bonus non è sempre la soluzione migliore per promuovere la performance.
Nel Mind the Economy della prossima settimana cercheremo di esplorare le implicazioni operative che derivano dall’economia dell’attenzione. I rischi e le contromisure possibili.
Per ora ci lasciamo sottolineando come mentre un tempo l’economia si misurava essenzialmente in ettari di terra, tonnellate di carbone e acciaio e ore di lavoro, oggi sempre più si misura in istanti di concentrazione e in sguardi rapiti. L’attenzione è la valuta più importante dell’economia del futuro prossimo che è già qui. Invisibile, ma capace di determinare chi prospera e chi resta indietro. Ed è proprio da come sapremo governarla che dipenderà non solo lo sviluppo della nostra economia, ma la qualità della nostra vita democratica e sociale.
ilsole24ore.com/art/l-economia-dell-attenzione-cosi-sguardi-diventano-merce-AHGYLicC