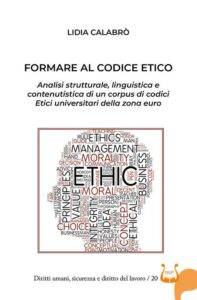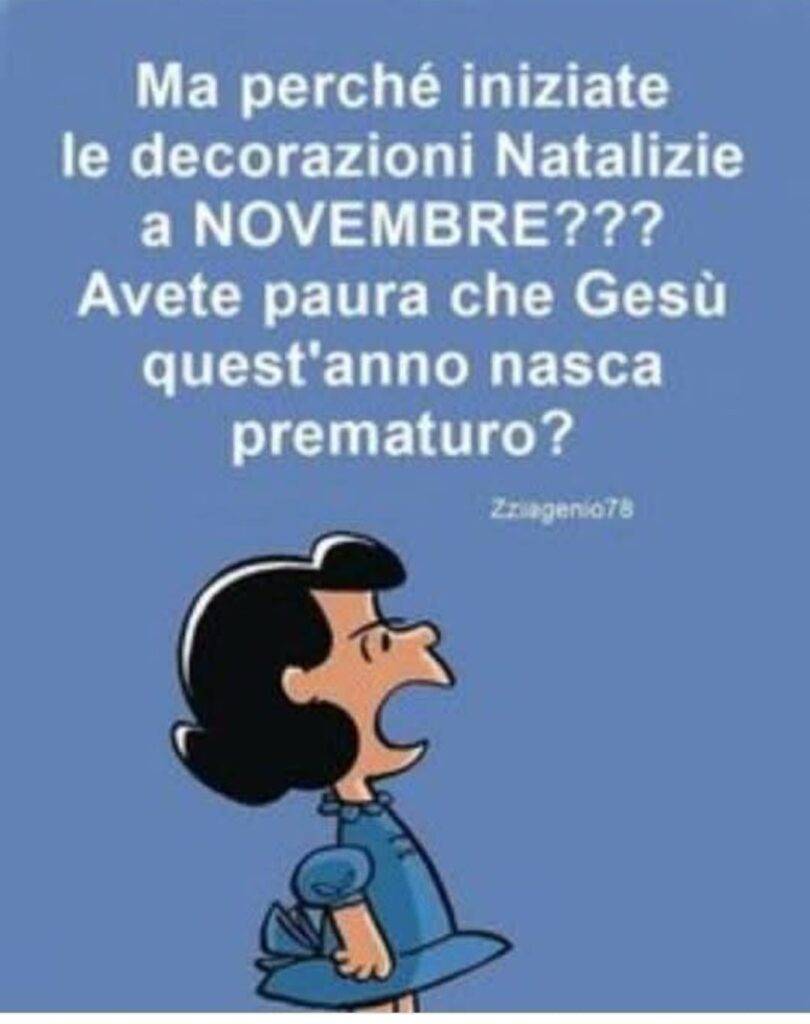Nel «giorno della liberazione» ci si chiede quanti saranno i prigionieri dei dazi di Donald Trump. Chi ne pagherà effettivamente il conto, quali le eccezioni. E poi, soprattutto, quanto impiegheranno molti cittadini americani a sentirsi, se mai accadrà, ugualmente prigionieri delle scelte della loro amministrazione. Da sempre i dazi, e peggio una guerra commerciale, rappresentano un circolo vizioso, un gioco a somma negativa. I risparmiatori statunitensi prediligono, più di tutti, i mercati azionari. Il loro tenore di vita, attuale e futuro, è tutto lì. Gli indici di Borsa non vengono interpretati a seconda del credo politico. Sono una sentenza inappellabile. Gli europei colpiti dai dazi sono poi nella scomoda posizione di sperare, da un lato, che i mercati puniscano Trump e, dall’altro, che ciò non avvenga visto che parte rilevante dei propri risparmi è investita in piazze e società americane. Nelle ultime settimane vi è stato un secco indebolimento delle «magnifiche sette» grandi multinazionali digitali. Da inizio anno l’indice S&P 500 ha perso il 4,4 per cento. Ma gli altri 493 titoli sono saliti. Il nervosismo domina gli scambi ma le piazze europee, da quando è stato eletto Trump, si sono apprezzate (più 8,5 per cento l’Euro Stoxx 600). La Banca centrale europea (Bce) stima un impatto negativo sulla crescita, con dazi al 25 per cento, dello 0,3 per cento (0,5 con i contro-dazi). Pesante, ma non la fine del mondo.
C’è del metodo nell’apparente follia di Trump? Ovviamente sì, se riuscisse a dimostrare di aver rilanciato la produzione e l’occupazione in tante filiere nazionali (dall’acciaio all’auto) indebolite da un interscambio poco favorevole. E di ridurre, come promesso, le tasse soprattutto alle imprese grazie anche ai proventi delle nuove barriere tariffarie. Il tempo, in questo caso, è una variabile decisiva. Fino a che punto la Casa Bianca può permettersi di veder scendere i listini azionari e indebolirsi il tasso di crescita al limite addirittura di una recessione? E, ancora, quanto risulterà tollerabile un rialzo dell’inflazione dopo aver vinto le elezioni proprio soffiando sui rincari del carrello della spesa di un cittadino medio? Se la Federal Reserve fosse poi costretta ad aumentare i tassi, un eventuale apprezzamento del dollaro vanificherebbe parte dell’effetto dei dazi. L’indice di fiducia dei consumatori americani è in discesa e, di conseguenza, i consumi.
Esposti al carattere volubile e imprevedibile di Trump, siamo stati tentati in questi mesi di non prendere troppo sul serio le sue minacce, confidando nel ripetersi dei ripensamenti. Già questo è tristemente significativo. Perché espone i Paesi occidentali a vivere una curiosa e inedita condizione storica. Siamo addirittura sollevati dal constatare l’incongruenza di un presidente americano la cui parola dovrebbe essere scolpita nella pietra. E tutto ciò si confronta, agli occhi delle opinioni pubbliche, con la temuta, e purtroppo anche stimata, risolutezza di autocrati come Putin e Xi. Chi è più serio? Il presidente della più grande democrazia o i leader di due potenti autocrazie? Anche questo doloroso paradosso contribuisce a indebolire gli stati di diritto e ad aumentare il fascino popolare dell’uso della forza: politica, economica e militare.
Trump promette che sarà gentile. Bontà sua. Soprattutto con chi si sottometterà più facilmente ai propri desiderata. I suoi (ex) alleati dovranno scegliere se ammiccare, accodandosi e accordandosi, oppure se tenere dignitosamente il punto, replicando i dazi, con il rischio di pagarne un prezzo più elevato. I dazi, storicamente, funzionano in un solo caso. Quando la vittima acconsente. E non sono solo un’arma negoziale che il presidente americano usa disinvoltamente per premere sui propri partner. Sono anche un veleno a lento rilascio di sfiducia nelle relazioni commerciali tra privati. Una sorta di clausola oscura disseminata nei contratti. Le parti, pur legate da reciproche obbligazioni, sono in realtà più distanti. Diffidano l’una dell’altra. Incomprensioni e sospetti si allargano a macchia d’olio a tante altre attività non commerciali. Ai rapporti tra comunità scientifiche e culturali, per esempio. Il dilagare della sfiducia reciproca è la cifra distintiva di questa stagione geopolitica così gravida di angosce e interrogativi. Ci si guarda in cagnesco. Anche tra alleati storici. E si sottovaluta pericolosamente che l’architettura finanziaria internazionale si regge — come ha sottolineato Larry Fink, il capo di BlackRock, il più grande fondo d’investimento al mondo — sulla fiducia nel dollaro come valuta di riserva, che potrebbe venire addirittura meno visto l’alto indebitamento americano. Un grande Paese, che drena liquidità internazionale per finanziare il proprio debito elevato, curiosamente, o spericolatamente, avrebbe bisogno di molta fiducia. I rapporti di forza la possono imporre, non c’è dubbio. Il costo però è sconosciuto, il rischio per tutti elevato.
corriere.it/opinioni/25_aprile_01/i-dazi-sono-un-veleno-per-tutti-a7882f62-7f9a-43f2-909d-bff5006caxlk.shtml?refresh_ce