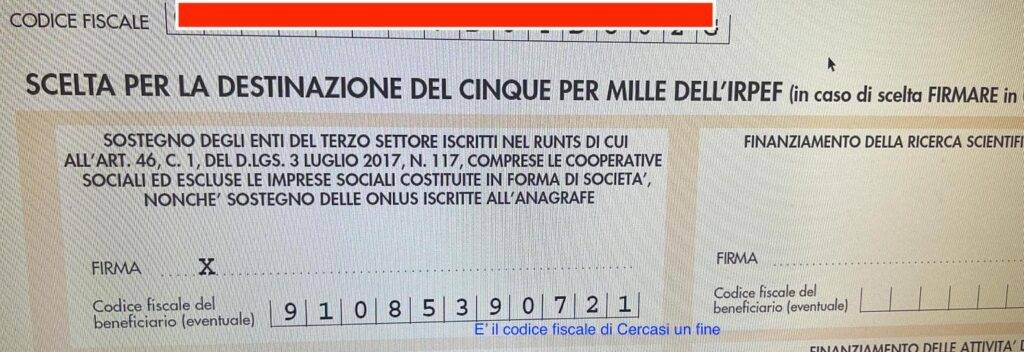Dal 2020 Raffaele Cantone guida la Procura della Repubblica di Perugia, per anni si è occupato di camorra a Napoli ed è stato il primo presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, istituita nel 2014. Oggi, che la corruzione sembra uscita dai radar del dibattito pubblico, al punto che pare averla più a cuore papa Francesco di quanto non la abbiano le autorità civili, ha deciso di dedicarle un libro: Corruzione, prevenire e reprimere per una cultura della legalità, appena uscito per i tipi Vita e Pensiero, in una collana che ha un titolo che sa di ottimismo della volontà: “Piccola biblioteca per un Paese normale”. Un’analisi documentata, ma piana e accessibile a lettori non addetti ai lavori.
Dottor Cantone, perché un libro sulla corruzione proprio adesso?
«Il tema è meno che in passato presente nell’incandescenza del dibattito pubblico e io, come procuratore della Repubblica, mi occupo ovviamente ancora di corruzione senza che sia più un impegno esclusivo come lo è stato ai tempi dell’Anac: questo insieme di circostanze mi consente di ragionarne, per così dire, a bocce ferme, spero più pacatamente di quanto si riesca a fare quando si accendono le divisioni tra tifosi di opposte fazioni».
Il fatto che le norme anticorruzione negli anni siano cambiate spesso è un problema per chi le deve applicare?
«È un problema enorme: cambiare continuamente le norme significa cambiare continuamente le prassi, creare disorientamento dal punto di vista degli interpreti: per esempio in materia penale, quando le norme si susseguono senza il tempo di trovare una stabilità – si pensi alla prescrizione – si trova grande difficoltà nello stabilire quale delle normative si deve applicare ai processi in corso iniziati con una legge e finiti con un’altra. Il continuo mutamento legislativo, tra l’altro, è una caratteristica tipica degli Stati in crisi, vuol dire che c’è un problema che si cerca di risolvere solo cambiando le leggi, cosa non è facile tanto più se non ci si preoccupa di implementare la legislazione».
Come definirebbe la corruzione per spiegarla a un comune cittadino?
«Direi, parafrasando il Codice penale, che è uno scambio in base al quale un soggetto pubblico mette in vendita la propria funzione a beneficio di qualcuno che ha interesse ad acquistarla».
Siamo passati dalla “maxitangente Enimont” alla corruzione pulviscolare. La prosecuzione dello stesso comportamento con altri mezzi o un’altra cosa?
«Premesso che come tutti i fenomeni umani anche la corruzione si evolve in relazione ai tempi, io credo che esistesse una corruzione pulviscolare anche ai tempi di Tangentopoli, la notavamo di meno perché emergevano le grandi tangenti che ora non vediamo più, ma la vera evoluzione sta nel fatto che la corruzione diventa sempre più un sistema. Vediamo organizzazioni nelle quali la corruzione è uno degli strumenti per l’arricchimento e nelle quali i funzionari pubblici sono presenti allo stesso modo degli imprenditori e dei corruttori. È meno definito il rapporto bilaterale classico dove c’è uno che vende uno che compra: “venditori” e “acquirenti” fanno parte della stessa struttura e spesso chi compra non acquista la singola attività ma una disponibilità. C’è chi parla a questo proposito di “reti di corruzione”: situazioni in cui si fa fatica persino a individuare i ruoli. Io nel libro la chiamo corruzione sistemica o organizzata».
A proposito dell’aggettivo organizzata: lei nomina in più occasioni il processo passato alla cronaca come “mafia capitale”. Quando la sentenza di primo grado disse non provata l’aggravante mafiosa ci fu una sorta di esultanza. Ma c’era di che esultare di una corruzione sistemica?
«Assolutamente no, c’era da deprimersi perché quello che emergeva, a prescindere dal carattere mafioso o meno, era l’esistenza di meccanismi di controllo illegale pesantissimi su uffici pubblici strategici: interi uffici del Comune di Roma completamente asserviti alle logiche di un gruppo criminale».
La criminalità mafiosa tende a preferire le strategie corruttive a quelle violente per poter passare inosservata. Questo utilizzo “mafioso” della corruzione rende più difficile distinguere?
«Direi di no, ma credo che l’analisi sia corretta: oggi certamente le mafie preferiscono avvicinare i funzionari che intimidirli, rende di più. Questo non vuol dire che corruzione e mafia siano la stessa cosa. La corruzione mafiosa è una delle modalità attraverso cui la corruzione si manifesta, ma non tutta la corruzione è mafiosa. Anche se ritengo opportuno che ci siano regole – per esempio in materia di intercettazioni – che permettono di utilizzare meccanismi di contrasto pensati per le mafie anche per la corruzione, perché vigono meccanismi di omertà analoghi. Corruzione e mafia restano, però, fenomeni distinti».
Se c’è burocrazia farraginosa aumentano le occasioni di corruzione, se non si mettono controlli la si lascia dilagare. Come se ne esce?
«Credo si tratti di trovare un giusto mezzo: eliminare i controlli non è la soluzione, aumenta a dismisura la corruzione. Si tratta di stabilire controlli il più efficaci possibile e soprattutto indipendenti. I lacci che paralizzano non sono i controlli in quanto tali, che ci devono essere, ma l’eccesso di burocrazia stupida e non utile in funzione di controllo. Viviamo dei paradossi: per le prossime olimpiadi il legislatore ha previsto che adoccuparsi degli appalti sia una fondazione di diritto privato quindi, secondo l’indicazione legislatore, ammesso che sia davvero questa l’interpretazione giusta, potrebbe fare appalti per centinaia di milioni senza gare pubbliche, mentre noi quando in un ufficio compriamo risme di carta per poche decine di euro dobbiamo prevedere mille verifiche».
Il timore della firma è un problema reale o una scusa?
«Ha un fondamento ma è anche un comodo alibi, nel nostro paese parliamo di “burocrazia difensiva”, un ossimoro che non ha eguali altrove: la burocrazia nasce per decidere non per difendersi. Si è presa a prestito la formula dalla medicina difensiva, ma sono cose diverse. Occorrerebbe semplificare i meccanismi bizantini che regolano, ostacolandola, l’attività amministrativa. Per esempio: bisognerebbe smettere di fare continuamente leggi; di farne di incomprensibili; di introdurre norme in leggi di 800 commi come si fa ogni anno con la finanziaria. È questo a rallentare il Paese, non l’abuso d’ufficio e i controlli contabili».
Il suo ufficio è competente per i reati che riguardano, come vittime o come indagati, i magistrati del distretto del Lazio. Come si vive da quella stanza il tema della corruzione del magistrato?
«L’anno scorso purtroppo abbiamo accertato un episodio grave, abbiamo dovuto anche procedere con custodia cautelare per interrompere una vicenda di corruzione in atti giudiziari. Casi allarmanti ma per fortuna rari, quello che mi preoccupa tantissimo è la situazione di sfiducia patologica nei confronti della Giustizia. Siamo subissati di denunce, quasi tutte prive di fondamento, in cui chi perde una causa invece di fare appello come sarebbe normale, fa un esposto contro il giudice nella convinzione che sia corrotto: una valanga di accuse campate in aria che distoglie l’attenzione dai casi davvero importanti. Mi chiedo quanto incida il clima che da tempo si respira: quando c’è una critica così profonda e continua da parte del potere politico nei confronti della magistratura anche il cittadino comune si ritiene in diritto di dire che il giudice che gli ha dato torto è un delinquente, un corrotto, un comunista, un fascista a seconda di quello che gli conviene. Ma questo non favorisce il buon funzionamento della giustizia. La sfiducia è un fenomeno mondiale ma in Italia è accentuato: non ci si chiede più se la sentenza sia giusta o sbagliata, se si abbia torto o ragione. Non si ammette più neppure che un giudice possa anche commettere un errore, senza essere per questo in malafede».
Nel libro lei afferma che il contrasto alla corruzione ha tre fattori: “Prevenzione, repressione, progresso culturale: a che punto stiamo nell’equilibrio tra i tre?
«Abbiamo buoni strumenti normativi sia dal lato della prevenzione che della repressione, ma è una normativa che andrebbe implementata non messa in discussione ogni giorno. La prevenzione che era di moda nel decennio scorso sembra passata nel dimenticatoio. La repressione passa dalla “spazzacorrotti” all’eliminazione dell’abuso d’ufficio: una schizofrenia legislativa che non aiuta, perché la norma per diventare costume ha bisogno di tempo e stabilità. Il problema culturale risente dell’interesse generale, in questo momento poco accentuato. Aderire idealmente alla lotta alla mafia è più semplice: evoca stragi, estorsioni. Corrotti e corruttori, come dice papa Francesco, sono invece persone apparentemente perbene e questo non aiuta la riprovazione sociale nei loro confronti. L’aspetto culturale risente anche del fatto che nella nostra cultura il rispetto della tutela dei beni pubblici è meno sentito che in altri Paesi. Tutto dipende da come si considera il bene pubblico: se lo si percepisce come di tutti o di nessuno».
Un Papa che parla di corruzione, citato nel libro, ha un significato almeno simbolico per chi fa il suo lavoro?
«Nella visione di Papa Francesco la corruzione è un concetto più ampio di quello che si trova nel codice penale, nel libro ho provato a ragionarci, sapendo di poter appena sfiorare il tema in assenza delle competenze teologiche necessarie, ma il fatto che un Papa parli anche del “pane sporco”, dunque di una corruzione più vicina al concetto che ne ha il diritto penale, è un grande aiuto dal punto di vista culturale: elimina un alibi. E io credo che questo sia fondamentale perché la Chiesa non è solo un riferimento per i credenti ma anche una importante agenzia educativa».
https://www.famigliacristiana.it/articolo/corruzione-raffaele-cantone-sono-i-bizantinismi-non-l-abuso-d-ufficio-a-fermare-il-paese.aspx