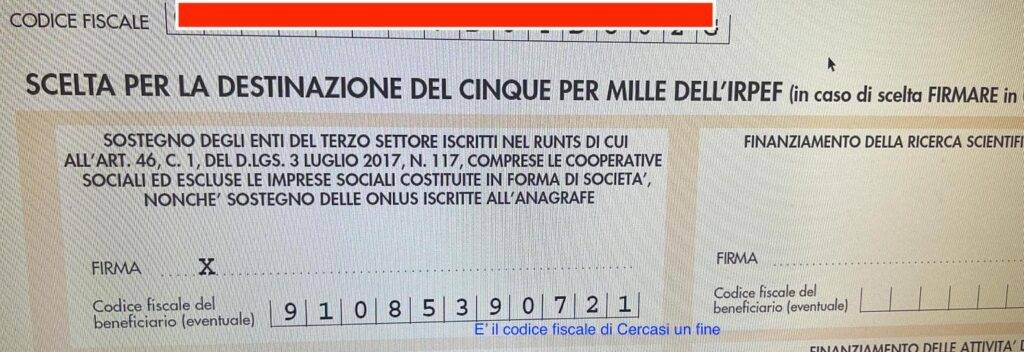A marzo la società svedese di tecnologie verdi Northvolt è fallita e la sua storia rimanda l’Europa alle scelte che oggi ha davanti. Ma non vale solo per le scelte sull’ambiente: vale ancora di più di fronte alla spartizione che l’America di Donald Trump sta perseguendo con la Russia a spese dell’ordine europeo consolidato dopo la guerra fredda. Northvolt, start up delle batterie di accumulo, era il campione continentale della transizione. Ha iniziato a morire trascurando un dettaglio: per il materiale di produzione delle batterie dipendeva da una società cinese, Wuxi Lead. Dopo qualche tempo Wuxi ha preso a spedire in Svezia attrezzatura difettosa, in seguito alcune funzioni dei macchinari sembravano addirittura sabotate. Alla fine Northvolt non riusciva più a rispettare le consegne, gli ordinativi pian piano sono venuti meno e l’azienda è saltata. Così la Cina si è disfatta di un concorrente e oggi controlla il 75% del mercato mondiale delle batterie.
Tutto questo non avrebbe niente a che fare con l’Ucraina e con il ruolo dell’Europa in questa guerra, non fosse che i droni con i quali il Paese resiste contengono esattamente lo stesso tipo di batterie. Le forniture all’Ucraina sono dosate a Pechino in modo da non creare troppi problemi alla Russia, secondo un rapporto del Royal United Services Institute di Londra. Ciò vale ancora di più per i magneti dei motori dei droni, perché essi contengono un elemento di terre rare — il neodimio — di cui la Cina genera il 90% della produzione mondiale.
In altri termini, dopo che l’Ucraina ha trasformato per sempre il concetto di difesa, combattere senza l’assenso di Xi Jinping è ormai impossibile. Almeno per il momento, è così. Negli Stati Uniti questo problema è chiaro e spiega in parte — la parte più presentabile — la collusione affaristica degli emissari di Trump con Mosca: gli americani vanno ovunque alla ricerca di accordi che spezzino la presa cinese sui materiali strategici; sono disposti a trovare nuovi equilibri anche con i russi, se questi possono aprire nuove esplorazioni e attività di raffinazione delle terre rare (come previsto dal documento in 28 punti degli emissari di Trump e Vladimir Putin).
L’Europa invece cosa fa? Qui l’inazione, l’ipocrisia e lo scaricabarile delle responsabilità sul Paese o sull’istituzione più vicina sono ormai la regola. Qualunque forma di leadership o pensiero strategico collettivo latitano, mentre le due principali potenze nucleari del pianeta si dividono le spoglie del continente senza di noi. La foto di ieri del Cremlino, con il socio in affari e il genero di Trump faccia a faccia con Putin — divisi dal lato corto del tavolo — non dovrebbe lasciare molti dubbi.
L’ultima sciarada europea va in scena sulle riserve congelate di Mosca, di cui in teoria dovremmo trasferire almeno 140 miliardi di euro all’Ucraina al più presto. Farlo darebbe a Putin il segnale che Kiev ha risorse per battersi almeno per altri due anni: già solo questa prospettiva può indurre il Cremlino a una minore intransigenza nei negoziati. Eppure dell’intera operazione sulle riserve si parla da un anno, mancano due settimane al vertice di Bruxelles che deve decidere, e tutto è in alto mare. Non è chiaro cosa accadrà e come. Da Bruxelles filtra che parte della colpa sarebbe della Banca centrale europea, la quale non garantirebbe la liquidità necessaria nel caso in cui l’operazione saltasse e si dovessero rimborsare in gran fretta i fondi a Mosca. La realtà ovviamente è più complessa di così. L’architettura del trasferimento delle riserve russe a Kiev non decolla perché tutti gli attori — Ursula von der Leyen, la Germania, la Francia, l’Italia, il Belgio (dove sono i fondi) — cercano solo di ridurre a zero i costi e i rischi per sé. E cercano di farlo a spese del vicino. Ma conciliare la totale avversione al rischio per tutti è semplicemente impossibile. Il Belgio vuole garanzie finanziarie di ferro dagli altri governi europei per non dover eventualmente rispondere da solo di fronte a Mosca. Ma Francia e Italia sono molto fredde. La Bce chiede una struttura finanziaria sulle riserve russe che preveda dei tassi d’interesse a carico della Commissione europea — per ragioni tecniche — ma Ursula von der Leyen e la Germania esitano perché non vogliono un precedente di qualcosa che somigli a un eurobond. Diventa un puzzle impossibile. Si direbbe che i leader europei stiano negoziando un accordo sulle quote latte (con tutto il rispetto), non la reazione a una guerra esistenziale.
Forse semplicemente l’Unione europea non ha in sé il software: non quando in gioco ci sono le invasioni di eserciti sul nostro continente, la vita e la morte, il tentativo degli avversari di distruggere il nostro sistema basato sul diritto, la tolleranza, l’apertura, la composizione pacifica e multilaterale dei problemi. Forse siamo disegnati per un mondo che non c’è più. Però non è vero che non avremmo gli strumenti per far provare ai rivali che anche l’Europa può muoversi da potenza. Nell’area euro (non in Cina) si trova la gran parte del debito pubblico statunitense detenuto all’estero. Permettiamo alle Big Tech americane di eludere le tasse su quote enormi dei loro utili attraverso l’Irlanda, in un modo che sostiene il loro valore di Borsa per centinaia di miliardi di dollari. Continuiamo a non imporre alla Cina di investire di più e meglio da noi, condividendo la sua proprietà intellettuale, se vuole avere l’accesso al mercato europeo di cui ha tanto bisogno.
Ovviamente tutte queste strade sono difficilissime, piene di trappole. Sono l’equivalente economico di un confronto atomico. Ma la sostanza della dissuasione nucleare non è nel lanciare la bomba; è nel saper instillare nell’avversario il dubbio che possiamo farlo. Esattamente ciò che questa generazione di leader europei è incapace di fare.
corriere.it/opinioni/25_dicembre_02/l-europa-tra-paure-e-paralisi-7f660349-8d6f-4e38-9194-e5dc7f15cxlk.shtml