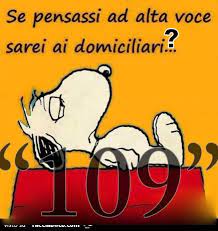Nella storia del capitalismo il potere politico e quello dell’impresa sono entrati spesso in conflitto. Uno scontro a volte salutare. Più preoccupante è quando il confronto non c’è. O se un potere prevale totalmente sull’altro. Il primo, la politica — che rappresenta gli interessi generali — ha sempre cercato, almeno in una visione liberal-democratica della società, di regolare lo spazio dell’impresa, soprattutto se privata, sia per promuoverne l’utilità sociale, sia per smussarne gli eccessi. La globalizzazione ha sottratto molte multinazionali, sul piano fiscale e normativo, dal dominio territoriale degli Stati. Tant’è vero che a lungo si è parlato del fenomeno delle stateless company, aziende così forti da non dipendere più da nessuna autorità statale. Le privatizzazioni sono sembrate, sul finire del secolo scorso, un fenomeno inarrestabile, specie per la prevalenza di una visione anglosassone dei mercati alla quale si è contrapposta la più prudente e mista cultura renana, francese e tedesca.
Liberismo dopo il Muro di Berlino
Il liberismo vincente ha indotto i Paesi occidentali a credere, dopo il crollo del muro di Berlino, che la sola apertura dei mercati fosse una garanzia di affermazione delle istituzioni democratiche persino in Russia. Errore tragico, visto ciò che abbiamo sotto gli occhi. Tra i perdenti occidentali della globalizzazione (il ceto medio e la classe operaia) è cresciuto un giustificato sentimento di rigetto nei confronti della grande finanza e delle multinazionali, vere vincitrici della gilded age del capitalismo di fine secolo scorso, non privo di conseguenze politiche. Con qualche distinguo. Se le Big Pharma sono generalmente il male (nonostante i successi nei vaccini o forse proprio per questi), al contrario le Big Tech, le multinazionali dell’alta tecnologia, godono di un apprezzamento pubblico largamente positivo. Eppure fanno incetta dei nostri dati personali, non pagano le tasse e inquinano il dibattito pubblico.
Miliardari nella stanza dei bottoni
Gli innovatori della Rete (a differenza di quelli della salute) sfruttano una costante presunzione tecnologica di innocenza. La loro indiscutibile forza economica, insieme a quella delle grandi istituzioni finanziarie, è diventata tale da soggiogare in molti casi la politica, comprandosela. Oppure ritenendo, come Peter Thiel o Curtis Yarvik, che la democrazia rappresentativa sia ormai un impaccio allo sviluppo della tecnologia. Un relitto barbarico. Nessuno si stupisce più del numero di miliardari chiamati a svolgere ruoli pubblici, specialmente negli Stati Uniti. Non per competenza bensì per ricchezza. Raramente le due qualità coincidono.
Ora assistiamo al ritorno, prepotente, dello Stato in economia. Sono sempre più numerosi i settori nei quali è sinceramente impensabile — e potenzialmente pericoloso — che si lasci via libera ai soli privati: dallo spazio all’intelligenza artificiale, ai sistemi d’arma, all’esplorazione degli oceani, fino alla gestione delle terre rare. È l’irruzione della geopolitica.
Il modello di Pechino
Nella competizione tra blocchi, in particolare con la Cina, le grandi imprese sono armi improprie. Sono parte insostituibile di un sistema di difesa. E se proprio devono vendere chip per l’intelligenza artificiale che versino allo Stato una percentuale dei profitti, come ha richiesto la Casa Bianca a Nvidia. Il colosso dei chip, che vale in Borsa quanto la somma del prodotto interno lordo di Italia e Spagna, ha accettato un compromesso che nel Novecento, nella patria del capitalismo di mercato, sarebbe equivalso a un’eresia. «Non solo — commenta Andrea Colli, ordinario di Storia economica all’Università Bocconi —. Il fatto che lo Stato acquisti il 10% di Intel, diventandone il primo azionista, non per salvare il gruppo dei semiconduttori bensì per dirigerlo, è ugualmente una novità che cambia la stessa morfologia del capitalismo americano. Assistiamo al tentativo di usare il potere di mercato di alcuni grandi gruppi industriali presenti in settori strategici ai fini della competizione geopolitica fra grandi aree».
Fattore geopolitica
Un articolo appena uscito su Foreign Affairs (The Real China Model di Dan Wang e Arthur Kroeber) è illuminante al riguardo. La Cina ha vinto. Ed è un modello da imitare. E anziché tentare di indebolirla (con i dazi per esempio) meglio copiarne le virtù e rafforzare le filiere industriali, anche con una partecipazione diretta dello Stato. Le forze di mercato non bastano più. La concorrenza è un limite. I monopoli una necessità strategica.
«L’altra grande conseguenza — prosegue Colli — è che le multinazionali di questi settori strategici non possono prescindere – verrebbero meno agli interessi dei propri azionisti – dall’utilizzare il più possibile la leva politica per mantenere o guadagnare quote di mercato e far fronte alla concorrenza soprattutto cinese. Normale, di conseguenza, accettare ogni richiesta del potere politico, specie se queste sono funzionali a far sì che in alcune aree, penso soprattutto all’Unione europea, vengano smantellate regole restrittive, giudicate penalizzanti per il business. Come scrisse Martin Wolf dobbiamo ormai rassegnarci al fatto che è la geopolitica che condiziona l’economia, non il contrario come nell’era iperliberista. Del resto la Storia insegna. Nella Prima guerra mondiale, la Germania combatté contro i suoi due principali partner commerciali: la Francia e l’Inghilterra».
Patrioti o cortigiani?
C’erano una volta le stateless company, le multinazionali che sembravano sfuggire a ogni logica di appartenenza nazionale. Rimangono aperti alcuni interrogativi. Fino a che punto il perseguimento degli interessi degli stakeholder fa strame di principi solennemente sollevati soltanto pochi anni fa? E manda all’aria alcuni valori liberal-democratici che forse non erano così radicati. Non solo nelle regole del mercato, nell’importanza della separazione dei poteri, nell’indispensabile presenza di autorità indipendenti.
Nel 2015 oltre 40 chief executive officer di grandi gruppi internazionali firmarono una lettera aperta ai leader mondiali sui temi del riscaldamento climatico. Tutto finito nel cestino delle buone intenzioni, come le annuali lettere di Larry Fink, gran capo di Blackrock, le strombazzate Net zero asset managers (Nzam), Net zero banking alliance (Nzba) e Climate Action 100+ (CA100+). Certo, la realtà è cambiata. Ma quelle idee erano veramente condivise o facevano parte delle mode del momento?
Sciogliere con sincerità questo interrogativo aiuterebbe a capire se oggi ci troviamo davanti a schiere di azionisti e manager accorti e responsabili, patrioti dell’Occidente o soltanto a miserevoli cortigiani interessati.
corriere.it/economia/opinioni/25_agosto_26/intel-nvidia-co-dove-va-il-nuovo-capitalismo-con-il-ritorno-dello-stato-1b2cfebd-1357-49b8-85ea-626af6847xlk.shtml?refresh_ce