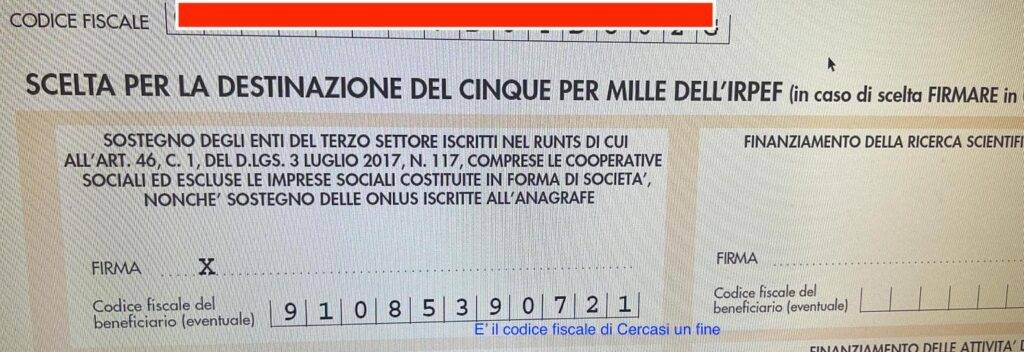L’equazione del mondo si sta rapidamente semplificando. E tra i fattori che rischiano di venire eliminati, insieme a quel che resta del diritto internazionale, c’è anche quel che resta dell’Unione europea. Trump le ha appena dichiarato guerra, con una sparata mortale sui dazi. L’inizio delle ostilità ha già una data, primo agosto, e il corredo di una lettera con minaccia alla presidente Ursula von der Leyen: se decideste come ritorsione di aumentare le vostre tariffe, qualsiasi percentuale sarà aggiunta al 30 per cento che applicheremo noi. Non esistono margini di trattativa e quindi arrendetevi.
Ovviamente si tratterà, si proverà a offrire una curva di genuflessione appena più dignitosa, si cercherà di convincere il nuovo re della piazza ad abbassare un pochino le sue pretese, che sono le più alte a parte Canada (35 per cento) e Brasile (50). Pretese che massacrerebbero proprio noi, alleati storici e di incrollabile fedeltà; con una ricaduta ferale su quell’Italia che con la premier Meloni e il vicepremier Salvini si è schierata anima e corpo con la nuova guida americana e si ritroverebbe «premiata» con una batosta economica e sociale (danni per oltre 150 miliardi, 180 mila posti di lavoro a rischio) molto problematica da gestire. E proprio qui, assiso nel palco di prima fila sulla linea del conflitto, si inserisce una figura, il presidente cinese Xi Jinping, che ha tutto da guadagnare dallo scenario che si prospetta.
Archiviato il «fattore K» insieme al comunismo che l’animava (termine inventato da Alberto Ronchey nel 1979), si allunga l’ombra del «fattore Xi», leader di un Paese che, a suo dire, nel 2049, centenario della Repubblica popolare, sarà il faro culturale del mondo e che sta sfruttando l’opportunità che l’America trumpiana gli offre per accorciare i tempi.
Mentre il padrone della Casa Bianca nella sua furia egotica manda in giro immagini di sé vestito da Papa, da Jedi o da Superman, il felpato padrone di Pechino lancia siluri che, al di là della pacatezza dei toni, suonano allarmanti almeno quanto quelli del sovreccitato The Donald. Al tradizionale forum sulla Governance globale tenuto nella capitale, l’ultimo figlio del Grande Padre Mao ha detto che la Storia è il più severo dei maestri e che gli imperi cadono quando dimenticano perché sono nati. E si è concesso qualche esempio, partendo da quello spagnolo che dominò per circa tre secoli (dal 1492 alla fine del Settecento) ma si dissolse terminate le conquiste e l’oro che le aveva ispirate. Stessa sorte per quello francese, due secoli e mezzo di impetuose invasioni e disastrose ritirate, e per il più longevo, l’impero britannico, dal 1583 al 1997, oltre quattro secoli, di cui resta giusto una memoria simbolica.
Ma il vero punto dove il viso immobile e la calma glaciale di Xi voleva andare a parare era l’avversario numero uno sulla strada del dominio globale, gli Stati Uniti, che sono stati la prima potenza dal 1945 «ma che in meno di un secolo già mostrano sintomi di affaticamento, instabilità interna, polarizzazione della politica, crisi della fiducia». Non un attacco frontale ma un sobrio necrologio.
A parte il massiccio tributo alla propaganda, dove il Timoniere contemporaneo descrive la Cina non come un impero ma come una civiltà capace di rigenerarsi, il cui scopo non è dominare ma durare, esportare infrastrutture e non ideologia, firmare accordi invece di imporre governi, a chi mirava il ragionamento è piuttosto esplicito. Se l’Occidente cerca stabilità, non è più l’Alleanza Atlantica che può garantirgliela. L’ America, caposaldo di quell’Alleanza, si agita tanto, e così maldestramente, perché sente vacillare il trono che pensava gli spettasse per diritti divino. Svegliati, Europa, gira verso l’Est l’ago della tua bussola, ripensa la strategia geopolitica dei tuoi partner prima che per te sia troppo tardi. Noi ci siamo, e in 5 mila anni abbiamo imparato a non avere fretta, sapendo che il tempo è dalla nostra parte.
L’offerta è molto più concreta di quel che sembra. Ne sanno qualcosa i Paesi che hanno scelto di accettarla, dall’Africa al Sud America e in tanta Asia. La Cina non promette democrazia, sconosciuta in casa. È insensibile ai diritti, trave portante (almeno sulla carta) delle nostre Costituzioni continentali. Non garantisce libertà ma ordine. Una volta che le vengono aperte le porte, usa entrare con una certa circospezione, salvo poi tutelare i propri interessi ed estenderli fino a ridurre ai minimi quelli dell’ospite.
E adesso nei suoi radar, complici le mattane di Washington, ci siamo finiti noi. Insieme alla lettera di fuoco della Casa Bianca, da Pechino arriva a Bruxelles questo messaggio in bottiglia, che non contiene ultimatum ma ha ugualmente una certa carica esplosiva, sia pure con un timer non a breve. Anche se brevi rischiano di essere i tempi per trovare un qualche tipo di accomodamento con l’uomo che per fare grande l’America mira a rimpicciolire i satelliti che le girano intorno, incurante dei danni che questa esibizione muscolare provocherà al suo stesso Paese. Ci aspettavamo dazi al 10 per cento, ce li ritroviamo triplicati. Assorbito il colpo, e in attesa della più che probabile risposta nefasta dei mercati, la linea che al momento sembra prevalere sarebbe quella di evitare uno scontro frontale con l’ex amico Trump. Che sia la strada migliore è da dimostrare: chi ha risposto con durezza alle sue provocazioni, l’ha convinto a più miti consigli (vedi la stessa Cina e la Gran Bretagna). Ma è capace di durezza, e quindi di compattezza, questa Europa?
Stretta nella morsa tra il Bullo e il Dragone, l’Unione non è mai stata in pericolo come adesso. Si prospettano crescite spaventose di inflazione e recessione. E se passa la linea del «si salvi chi può», alla fine, cioè molto presto, non si salverà nessuno. E retrocederemo a vassalli del signore di Washington o di quello di Pechino, chiunque sia domani o dopo l’augusto Timoniere della Cina.
corriere.it/opinioni/25_luglio_14/bulli-e-dragoni-97af6867-7975-4fdf-8afc-5b98d5654xlk.shtml?refresh_ce