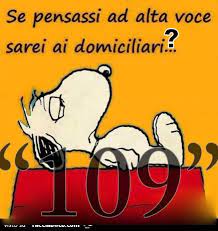L’intelligenza artificiale richiede non solo un’etica della tecnologia, ma una educazione della coscienza. È tempo di definire un peccato tecnologico per orientare l’uso responsabile e illuminare la virtù tecnologica.
L’Intuizione di papa Francesco
Il rapporto storico tra Chiesa e innovazione tecnologica è segnato da ritardi e recuperi. Dalla stampa di Gutenberg — che rivoluzionò la diffusione del sapere sfidando il monopolio ecclesiastico — alle recenti sfide ecologiche, l’istituzione ha spesso reagito con una postura inizialmente difensiva. Oggi, di fronte all’avanzata dell’intelligenza artificiale (IA) e delle tecnologie digitali, rischia di ripetersi lo stesso schema: timore, resistenza, e un recupero tardivo.
Papa Francesco è autore di un precedente illuminante. Affrontando la crisi climatica nell’enciclica Laudato si’, elaborò il concetto di peccato ecologico con cui trasformò una questione tecnico-scientifica in una categoria teologica e morale. In questa visione, il cambiamento climatico antropico non è più solo una sfida ambientale, ma una rottura del rapporto con il Creato e, attraverso esso, con Dio. Inquinamento e distruzione degli ecosistemi sono diventati atti che ledono simultaneamente la creazione divina e la dignità umana.
Questa intuizione ha permesso alla Chiesa di superare l’imbarazzo di apparire marginale, rivendicando una prospettiva teologica autentica. Il peccato ecologico non è un semplice reato contro la natura, ma una ferita alla relazione fondamentale tra uomo, creato e Dio — un peccato dalle dimensioni insieme personali, sociali e cosmiche. Questo modello è prezioso per affrontare la rivoluzione digitale.
Peccato tecnologico: definizione e urgenza
Infatti, l’intelligenza artificiale presenta sfide fondamentali: tocca l’essenza stessa dell’umano — pensare, decidere, creare — e sembra replicare le operazioni più specifiche della razionalità umana. Se la stampa mise in discussione il controllo dell’informazione, l’IA sfida il monopolio umano sull’intelligenza. La tecnologia contemporanea, infatti, non è mai neutra: ogni dispositivo, algoritmo, piattaforma porta con sé una visione implicita dell’uomo e della società.
Le risposte prevalenti si concentrano sull’etica della tecnologia: l’insieme di principi (trasparenza, equità, accountability) per progettare e governare sistemi tecnologici etici. Questo approccio è necessario, ma insufficiente. L’etica della tecnologia cerca regole universali applicabili alla tecnologia, spesso in un quadro secolare e con difficoltà a trovare un consenso etico globale. Tuttavia, anche la tecnologia più etica per design può essere usata in modo distorto o superficiale dall’uomo. Il problema ultimo non è solo nelle macchine, ma nell’uomo che le usa e nel suo orientamento fondamentale.
È qui che emerge l’urgenza di definire un peccato tecnologico e la corrispondente virtù tecnologica. Non si tratta di un’alternativa all’etica della tecnologia, ma di un complemento necessario e profondamente diverso, centrato sulla formazione morale della persona. Sono due approcci distinti alla stessa realtà complessa. In analogia con il mondo automobilistico: progettare un veicolo sicuro è importante, ma altrettanto lo è guidarlo responsabilmente. È in quest’area che si collocano il concetto di peccato tecnologico e le virtù corrispondenti.
Il peccato tecnologico può essere definito come «l’uso moralmente disordinato della tecnologia da parte della persona, che, per scelta o negligenza, viola i principi del bene comune, della giustizia, della carità o della dignità umana, danneggiando se stesso, gli altri o il creato attraverso le sue azioni tecnomediate». Si manifesta nella riduzione dell’altro a dato statistico, nella strumentalizzazione della persona, nella manipolazione informativa, nell’idolatria tecnologica che attribuisce poteri salvifici alla tecnica. È, in ultima analisi, un peccato dell’utente, che nasce nel cuore umano quando piega lo strumento a fini disordinati.
La virtù tecnologica: L’etica dell’uomo tecnologico
La virtù tecnologica, illuminata dalla tradizione tomista, rappresenta la risposta specifica della Chiesa: non una mera etica della tecnologia, ma un’etica dell’uomo tecnologico. Seguendo Tommaso d’Aquino, la virtù tecnologica è l’habitus operativo buono, la disposizione stabile dell’animo a usare gli strumenti digitali secondo retta ragione e carità, orientandosi al bene vero e alla felicità ultima (beatitudo). Non riguarda primariamente il design dell’algoritmo, ma il cuore e la conoscenza di sé di chi lo utilizza.
Questa virtù si declina in forme specifiche per l’ambiente digitale: la prudenza digitale (capacità di valutare rischi e contesti dell’uso tecnologico), la giustizia informativa (agire equo nella gestione delle informazioni), la temperanza digitale (misura nell’uso del tempo online), la fortezza cognitiva (resistenza alla pressione dell’omologazione digitale), la carità digitale (promozione del bene dell’altro nello spazio digitale), e la contemplazione analogica (capacità di preservare spazi di silenzio e presenza reale nel mondo digitale).
Prospettiva profetica: la tecnologia come via di santificazione
La Chiesa ha l’opportunità storica di offrire una risposta integrale — per usare un concetto caro a Papa Francesco. Oltre alla partecipazione alla (giusta) discussione sull’etica della tecnologia, la Chiesa può portare il suo contributo specifico e insostituibile anche nella formazione della coscienza dell’uomo digitale. Il peccato tecnologico non è un mero strumento di condanna, ma una bussola per discernere e orientarsi verso la virtù.
Riconoscere la virtù tecnologica significa valorizzare non solo l’IA ben progettata, ma l’IA bene usata. È virtuoso lo scienziato che utilizza algoritmi predittivi per salvare vite con umiltà e discernimento; l’educatore che sfrutta piattaforme digitali per favorire incontri autentici e pensiero critico, non mera trasmissione passiva; l’artista che adopera strumenti generativi come estensione, non sostituto, della propria creatività umana ispirata. In tutti questi casi, è la virtù della persona che trasforma lo strumento in via di bene.
Definire il peccato tecnologico e la virtù tecnologica non è un astratto esercizio accademico. È una necessità pastorale per un umanesimo digitale autentico. Mentre l’etica della tecnologia si preoccupa di regolare gli strumenti, la virtù tecnologica forma l’artigiano che li maneggia, orientando il suo cuore al bene.
In un’epoca di pervasività tecnologica, la Chiesa è chiamata a offrire criteri di discernimento per l’agire umano nel digitale, radicati nella tradizione delle virtù e nella saggezza di Tommaso d’Aquino. Proprio come il peccato ecologico insegnò che rispettare l’ambiente è onorare Dio, il peccato tecnologico può rivelare che l’uso virtuoso della tecnologia, frutto di una coscienza ben educata, costituisce una forma alta di collaborazione con l’opera creatrice divina.
In questa prospettiva, le virtù teologali non solo illuminano l’agire tecnologico, ma trasfigurano l’ambiente digitale rendendolo anticipo del Regno. L’uso virtuoso della tecnologia, animato dalla fede, dalla speranza e dalla carità, diviene segno profetico di una umanità riconciliata, capace di cooperare alla grazia anche attraverso strumenti artificiali.
La fede riconosce nella tecnica non un rivale di Dio, ma una possibilità di collaborazione con la sua provvidenza; la speranza sostiene l’impegno quotidiano nella costruzione di relazioni giuste e inclusive, intravedendo in ogni gesto virtuoso un frammento dell’eternità; la carità, infine, trasforma la rete in uno spazio di comunione, dove anche il codice e l’algoritmo possono servire l’incontro e la misericordia.
Così, la tecnologia abitata dalle virtù non è più solo oggetto di regolazione, ma spazio sacramentale, luogo storico in cui già ora si rende visibile — in modo parziale ma reale — la logica del Regno. Ogni atto virtuoso nell’ambiente digitale diventa allora una scintilla di eternità, un segno che anticipa la comunione definitiva alla quale l’umanità è chiamata.
È tempo di abbandonare la difensiva e assumere un ruolo profetico: indicare come la tecnologia, guidata dalle virtù, possa diventare via di santificazione e servizio al prossimo.
settimananews.it/chiesa/una-bussola-morale-era-digitale/