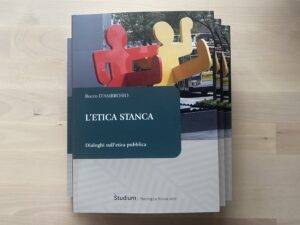Il dazio è “un’imposta indiretta che si applica alle merci che vengono importate o esportate da un Paese” (Treccani online). Il presidente Trump, ormai da mesi, con stile contradittorio e inaffidabile, monopolizza i media con annunci su probabili dazi statunitensi per merci estere. La vicenda ha diversi risvolti, anche di tipo etico, su cui mi permetto qualche nota strettamente personale.
Il primo rilievo etico è quello sulla legittimità di tali imposizioni. Negli USA, stando alla Costituzione, solo il Congresso può imporre dazi. Tuttavia, due leggi deleghe (Trade Expansion Act del 1962 e il Trade Act del 1974) permettono al presidente in carica di imporre dazi. La domanda etica e giuridica è se Trump sta esercitando il suo potere nell’ambito dei due Act citati oppure sta abusando e sostituendosi al Congresso. La decisione della Us Court of International Trade, che riteneva “illegali” i dazi, è restata valida solo per poche ore, fino a quando la Corte di appello ha deciso di accogliere il ricorso dell’amministrazione che chiedeva una pausa della sentenza. Se la valutazione giudiziaria è ancora in divenire; l’aspetto etico presenta molti elementi chiari: un presidente che trascura di considerare lo spirito del mandato costituzionale e non dialoga costruttivamente con gli altri poteri dello stato è già di fatto in una situazione molto prossima a determinare un impeachment, cioè la messa in stato di accusa per crimini commessi.
Il secondo rilievo etico ha che fare con le analisi trumpiane. Se si legge la lettera inviata da Trump alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (il cui testo si può leggere qui in originale e qui tradotto) lo stile e la sostanza sono: io, Trump, ho fatto questa analisi storico-economica (gli USA vittima di enormi dazi), ho deciso di applicare questi dazi e se non seguite quanto dico pagherete le conseguenze. Molti commentatori hanno già evidenziato come la vicenda dazi (e non solo) è un mix di ignoranza di elementari nozioni storiche, economiche, politiche e di relazioni internazionali, nonché del mercato globale. All’ignoranza si unisce la presunzione e l’arroganza di imporre la propria visione senza il minimo rispetto degli altri, siano essi cittadini, giudici, politici, capi di stato, operatori economici e finanziari, autorità nazionali e internazionali. Trump sembra somigliare molto a quei populisti, nostrani e stranieri, che sono, in tempi e modi diversi, ambigui, combattivi, assertivi, narcisistici, ipocriti, rassicuranti, decisionisti, disprezzanti della Costituzione, offensivi della religione e, spesso, corrotti e mafiosi.
Il terzo rilievo etico riguarda gli effetti della politica dei dazi. Weber ci ha insegnato che l’etica della responsabilità è “rispondere delle (prevedibili) conseguenze del proprio agire. (…). L’uomo dell’etica della responsabilità non si sente autorizzato a scaricare sugli altri le conseguenze del suo operare, nella misura in cui egli le poteva prevedere”. Un gran numero di esperti politici ed economisti non fa altro che dimostrare quanto la politica dei dazi sia pericolosa in quanto può favorire la recessione nazionale e globale, l’aumento della conflittualità sociale e tra gli stati, come della sfiducia nei leader politici ed economici. Ovviamente, come Weber insegna, i populisti di turno, una volta che le previsioni negative purtroppo si avvereranno, non faranno altro che scaricare la colpa su chi non la pensa e agisce come loro.
Il quarto rilievo riguardo l’impatto culturale di questo modo populista di far politica. I populisti – grazie a Dio – non sono eterni, come ognuno di noi non lo è. Tuttavia, i danni che procurano alle persone e alle istituzioni, sopravvivono alle loro esperienze di potere. Mi riferiscono ai danni culturali, che sono anche etici, perché incidono negativamente sul nostro modo di stare al mondo, di relazionarci con gli altri, di rispettare la Costituzione, difendere e promuovere la dignità e il bene dei singoli come dei gruppi, tutelare la libertà di espressione, di stampa e credo religioso. In sintesi, determinano una cultura che è negazione di quei principi etici che sono il fondamento delle nostre democrazie.
I dazi rientrano in quel processo politico e culturale, che Aldo Moro definiva allettamento, ovvero l’invito lusinghiero fatto da elementi quali “l’ordine piatto e facile, il compromesso con la propria coscienza morale, il quale abbandoni nelle mani di altri la cura delle cose che son nostre e debbono esserci care quanto la nostra vita. È l’allettamento dell’assolutismo, comunque atteggiato, che pronunzia il suo sorridente e invitante Io mi sobbarco. E può avere esso anche l’aria di salvare qualche cosa nel momento e può anche riuscire a salvarla in effetti, ma rende impossibile, con il facile successo iniziale, quello che più facilmente preme: la rieducazione politica e morale del popolo italiano. La formula allettante dell’assolutismo va dunque respinta, ancorché prometta l’immediato successo…”.
Rocco D’Ambrosio [presbitero, docente di filosofia politica, Pontificia Università Gregoriana, Roma; presidente di Cercasi un fine APS]