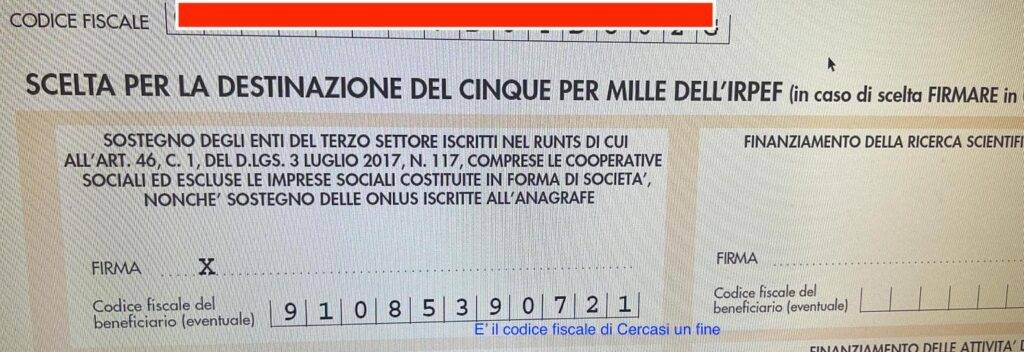«Il Dipartimento di Giustizia mi ha autorizzato a confermare l’esistenza di un’indagine più ampia sulla potenziale collusione tra la Russia e la campagna elettorale (di Trump, ndr). Non diremo più nulla finché non avremo concluso». Ultime parole famose di James Comey, direttore del Fbi, il 3 maggio del 2017 in una deposizione davanti al Congresso: sei giorni dopo, il 9 maggio, non era più direttore del Fbi, licenziato via lettera dal neopresidente (il mandato del direttore è decennale, Comey era in carica da quattro).
Il giorno dopo, 10 maggio, Trump incontrava nello studio ovale — mai successo prima — Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo, e l’allora ambasciatore di Mosca a Washington Sergey Kislyak, e diceva loro: «Ho appena licenziato il capo del Fbi. Era un pazzo, un vero demente. Ho subìto forti pressioni a causa della Russia. Ora la pressione è stata rimossa. Non sono sotto inchiesta».
L’uscita, irrituale come peraltro la scelta di invitare nello studio ovale i media russi con annesse apparecchiature elettroniche, riuscì perfino a far passare in secondo piano un’imprudente esternazione presidenziale fatta davanti ai russi: Trump si era vantato d’aver sventato un’operazione terroristica dell’Isis, informazione già di per sé top secret, e l’aveva fatto in un modo tale da indicare implicitamente che l’intelligence fosse stata raccolta dagli israeliani.
Benevolenza sospetta
Ma di cosa parliamo quando parliamo di Trump e Russia? Perché un politico che appena sceso in campo comincia a attaccare tutti, dentro e fuori il partito, dentro e fuori il suo Paese, concede un bonus che resiste tuttora proprio alla Russia, ex nemico? Perché non c’è una scelta geopolitica trumpiana, dal 2017, che non favorisca in qualche modo — o quantomeno eviti di danneggiare — Mosca? Il disengagement americano dall’Europa attaccata spesso e volentieri da lui e dal vice J.D. Vance era da ottant’anni un obiettivo prioritario del Cremlino.
Si può ovviamente considerare parte di una strategia più ampia, è però evidente che la benevolenza trumpiana verso Mosca sommata allo spinoso tema delle interferenze russe, ormai accertate, nelle elezioni americane, lasci aperti molti interrogativi. Dalla campagna elettorale del 2016 con quell’estate di passione di Hillary Clinton a causa delle e-mail democratiche hackerate, le domande si sommano.
Trump per primo ne è cosciente: il suo appetito pantagruelico per le lettere maiuscole è secondo soltanto a quello per il fast food e il golf, e twittò da presidente-eletto, l’11 gennaio 2017, poco prima di entrare alla Casa Bianca, un annuncio sintetico: «La Russia non ha mai cercato di fare leva su di me. NON HO NESSUN RAPPORTO CON LA RUSSIA, NESSUN AFFARE NESSUN PRESTITO NIENTE DI NIENTE!». Da allora, più il procuratore speciale Robert Mueller — l’allora ministro della Giustizia, l’ex senatore Jeff Sessions vecchia volpe washingtoniana, s’era saggiamente chiamato fuori dall’inchiesta passando la patata bollente — sembrava indagare sui rapporti tra campagna elettorale trumpiana e Mosca, più il presidente irrideva l’idea stessa coniando termini — «Trump è un maestro del branding», avvertì inascoltato Bill Clinton nel 2015 — come «la beffa russa» e «Russiarussiarussiarussia» intonato stile cantilena. Eppure, da allora è partita una vasta pubblicistica che ha documentato la special relationship trumpiana con Mosca, a partire dalla sua visita moscovita nel 1987 quando era ancora un semplice palazzinaro senza ambizioni politiche.
Vantaggi reciproci
Nel libro Collusion. Come la Russia ha aiutato Trump a conquistare la Casa Bianca del giornalista del Guardian Luke Harding si ipotizza una sorta di convergenza tra l’interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e i legami finanziari e personali di Trump con entità russe. Spionaggio? No, più semplicemente una relazione di reciproci vantaggi. Già negli anni ’80 cercò di varare il progetto di una Trump Tower nella Mosca sovietica, e la caduta del Muro rese possibili accordi immobiliari con oligarchi russi prima impensabili.
Harding racconta nei dettagli meeting come quello alla Trump Tower del giugno 2016 in cui Donald Trump Jr., Paul Manafort e Jared Kushner incontrano l’avvocata russa Natalia Veselnitskaya per cercare informazioni compromettenti su Hillary Clinton.
Hacker a orologeria
In questo senso colpisce anche la coincidenza dei server del comitato elettorale democratico hackerati dai russi nel 2016 i cui contenuti vengono diffusi tramite WikiLeaks poche ore dopo la diffusione della registrazione dello show «Access Hollywood» nel quale Trump si vantava di aggredire sessualmente le donne («Se sei una star puoi farlo»): le mail hackerate dominarono i media riducendo l’impatto negativo per Trump.
Craig Unger in Casa di Trump, Casa di Putin ha indagato sui legami decennali di Donald Trump con oligarchi russi, figure mafiose e l’intelligence di Vladimir Putin. Unger documenta come gli sfortunati casinò di Trump ad Atlantic City siano stati salvati con denaro russo negli anni ‘90, e per l’autore un evento fondamentale è il concorso di Miss Universo organizzato da Trump del 2013 a Mosca, dove cercò accordi commerciali. Ne esce il ritratto complesso di un Trump né agente consapevole né inconsapevole «utile idiota», ma sicuramente in uno stato di dipendenza finanziaria da entità russe e soprattutto di vulnerabilità assolutamente inedito per un presidente americano.
corriere.it/esteri/25_maggio_27/trump-russia-relazione-36ff6896-6ce1-4015-900c-4900367c1xlk.shtml