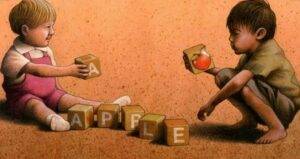La disinvoltura con cui Trump cambia le sue dichiarazioni lascia molti attoniti. Un giorno annuncia dazi draconiani, il giorno dopo li ritira. Un giorno predica la pace, il giorno successivo elogia la guerra. In realtà, nelle intemperanze del presidente americano si specchia un tratto caratteristico del tempo che viviamo.
La promessa di un mondo in cui ciascuno ha il diritto a esprimere il proprio punto di vista e dove la tecnologia fa circolare velocemente i significati ha prodotto una insostenibile ipertrofia comunicativa. Individualizzata e moltiplicata, la parola finisce in una crisi radicale. La coerenza del discorso e il riferimento alla realtà non sono più considerati presupposti necessari della comunicazione. Si può affermare qualsiasi cosa senza vincoli. In nome della libertà individuale e della moltiplicazione dei punti di vista, ogni affermazione vale quanto qualunque altra. La verità non è più una tensione verso cui tendere attraverso la pluralità delle interpretazioni, bensì un’opinione tra le tante, e vince chi ha maggior potere per affermare la propria. Col risultato che in famiglia, nelle organizzazioni, in politica la parola è sempre meno capace di essere strumento di intesa, di mediazione, di costruzione di mondi comuni. Cosi la parola perde la sua forza generativa e diventa strumento di potere o manipolazione. Viviamo in una nuova torre di babele, dove diventa sempre più difficile intendersi.
Il problema è che le società democratiche si fondano sull’uso pubblico della parola. La loro istituzione centrale — il Parlamento, cioè il luogo dove, in teoria, le diverse posizioni dovrebbero dialogare — è il simbolo più evidente di questo ideale. Che entra in crisi nel momento in cui il dibattito, la deliberazione, la possibilità di dissentire e argomentare non riconoscono più limiti, responsabilità, presupposti condivisi. Il linguaggio allora si svuota, la fiducia si corrode, la convivenza si infragilisce.
Fallimento che non si limita certo alle aule parlamentari. Ma che penetra le relazioni famigliari, organizzative, associative.
Se il linguaggio non lega più insieme la ricchezza dell’esperienza umana, le conseguenze non possono che essere gravi. Lo si vede nelle bolle autoreferenziali che si formano nella rete, nei mondi paralleli che si ignorano reciprocamente, nelle frammentazioni della sfera pubblica.
Il rimedio facile per far fronte a questa difficolta è il ricorso ad automatismi o tecnicismi. Una soluzione che oggi, con l’AI, appare straordinariamente allettante. Ma che presenta anche molti rischi. Così, per paradosso, la società della comunicazione finisce per moltiplicare sindromi autistiche: come se la saturazione simbolica del mondo generasse una forma di difesa estrema che porta a chiudersi, sottrarsi alla parola, interrompere lo scambio. Come dimostra la cronaca, laddove il dialogo fallisce restano solo l’urlo e la violenza per imporsi sull’altro, per tentare di superare il rumore di fondo, per riaffermare una presenza. Da qui nasce una domanda: può sopravvivere la democrazia quando la parola si ammala? In effetti, se le parole non valgono più nulla, se non sono più vincolate alla realtà, se non permettono di costruire un senso comune, allora la democrazia è in pericolo. Il rischio sono le nuove forme di populismo algoritmico, dove il consenso si costruisce non su idee o progetti, ma su reazioni istintive e meccanismi di identificazione affettiva.
Come si esce da questa situazione? Il comandamento biblico «non mentire» ci ricorda che la parola è legata a un vincolo: la parola ha senso solo se funge da ponte tra l’umano e la realtà. E l’interpretazione che essa rende possibile (una grande ricchezza) ha dei limiti nell’altro da noi. Senza questo ancoraggio, la parola diventa inganno, manipolazione, vuoto. Se vogliamo salvare la democrazia, dobbiamo necessariamente ripartire dalla parola, restituendole dignità, spessore, impegno. Almeno in chi occupa ruoli di responsabilità. I politici certo, ma anche i medici, gli insegnanti, i giudici, i giornalisti.
Non basta saper parlare: bisogna saper usare le parole con rispetto e attenzione. Nella tensione mai risolta verso la verità. Occorre riscoprire il potere simbolico della parola. Che, quando è autentica, non è mai banale: ma è capace di evocare, commuovere, unire. Di aprire orizzonti, di nominare l’inesprimibile, di mettere in relazione ciò che è distante. Solo una parola riconciliata con il reale può aiutarci a ritessere le trame della convivenza, a dare forma a una società meno cinica, meno superficiale, più capace di comprensione reciproca. Fino a quando esisterà una società umana il problema non potrà essere eluso: senza la parola, non c’è politica. Senza la parola, non c’è relazione. Senza la parola, non c’è futuro comune.
corriere.it/opinioni/25_luglio_03/restituire-dignita-alla-parola-7d047324-1a69-4774-a185-b14ef899dxlk.shtml