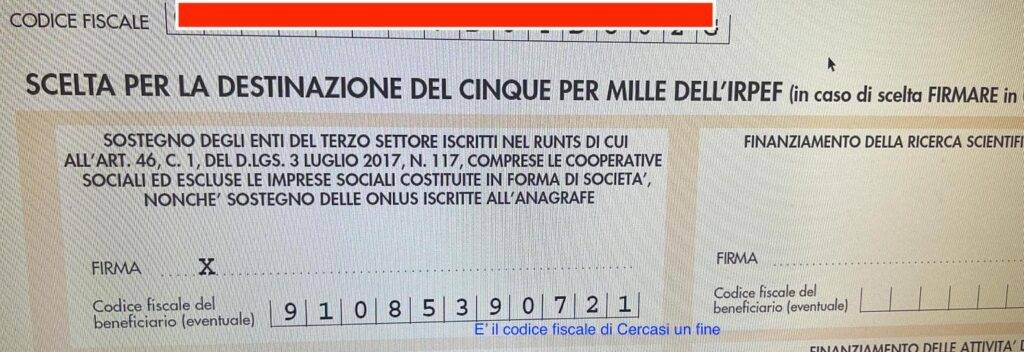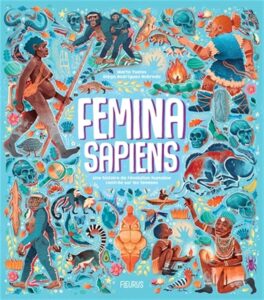Nel suo ultimo, importante libro Why Social Justice Matters (Polity Presss, 2005) Brian Barry anticipa di vent’anni il dibattito attuale intorno alla crisi delle democrazie occidentali. I dati di questa crisi sono sotto gli occhi di tutti. È di qualche giorno fa il dato emerso nel Rapporto Censis 2025 secondo cui per il 30% degli italiani i regimi autocratici sono i più adatti a governare oggi. Questa posizione fa il paio con la diffusa astensione dal voto cui abbiamo assistito anche nelle ultime elezioni regionali. L’ISTAT certifica che tra tutte le istituzioni quelle che riscontrano i livelli più bassi di fiducia sono il Parlamento Italiano, il Parlamento Europeo, il Governo e i partiti politici. Nel 1964 la percentuale di cittadini USA che dichiaravano di fidarsi del governo federale era pari al 77%. Una recente indagine del Pew Research Center mostra che oggi sono solo il 17%. Secondo la General Social Survey, la percentuale di americani che ritiene che “ci si possa fidare delle persone” è scesa stabilmente dal 46% del 1972 al 34% del 2024. Dato che si riduce ulteriormente (26%) se consideriamo i giovani tra i 18 e i 29 anni.
La democrazia in molte parti del mondo non è più vista come un ideale cui ispirarsi, in altre, dove pure è formalmente presente, viene quotidianamente svuotata di senso attraverso pratiche che di democratico hanno ben poco. Brian Barry aveva intuito vent’anni fa questa tendenza e aveva esplorato quei fattori che, come un fiume carsico, hanno indebolito in questi anni la stabilità strutturale delle nostre società.
Le società altamente diseguali non producono solo povertà, ma “patologie morali”. E’ l’essenza della sua tesi. E questo perché la disuguaglianza, quando cresce oltre una certa soglia, umilia e crea mondi separati. La disuguaglianza non distrugge soltanto redditi e opportunità, ma corrode il tessuto morale della società. Ciò che si lacera non è soltanto il patto redistributivo, ma il patto civico, la fiducia, il senso di appartenenza, la possibilità stessa di riconoscersi parte di un destino comune.
Povertà o disuguaglianza
Dove nasce l’ingiustizia, e soprattutto quali meccanismi sociali la producono e la riproducono anche quando nessuno sembra volerlo esplicitamente. Per comprenderlo occorre focalizzarsi sulla differenza che esiste tra povertà e disuguaglianza. Per alcuni, infatti, l’unica variabile economicamente e moralmente rilevante è la povertà. La disuguaglianza ne sarebbe, al massimo, un effetto collaterale, una caratteristica ineliminabile, per quanto spiacevole, di ogni economia dinamica. La questione è che per larghi strati della popolazione, dentro e fuori gli Stati Uniti, la povertà non è solo una condizione individuale ma il sintomo di istituzioni progettate e governate male. “A nord dell’enclave accademica di New York, che si estende attorno alla Columbia University – scrive Barry – si trova Harlem, dove è stato stimato che un uomo di colore nato e cresciuto in alcune zone ha meno possibilità di raggiungere i 65 anni rispetto a un bambino nato e cresciuto nelle zone rurali del Bangladesh” (p. 17). L’ingiustizia non è un concetto astratto. È un fatto epidemiologico. Anni di vita in più o in meno caratterizzano le esistenze di persone nate e cresciute in quartieri che distano tra loro un paio di fermate di metropolitana. A Napoli, tra Vomero e Sanità, Posillipo e Ponticelli, la differenza in termini di aspettativa di vita può superare i 7 anni. A Torino, quando si prende il tram e si scende dalle colline benestanti verso il quartiere operaio delle Vallette, l’aspettativa passa da 82,1 anni a 77,8. Cinque mesi di vita persi per ogni chilometro percorso.
E tuttavia molti italiani, così come molti americani, continuano a ritenere che questi dati non rivelino nulla sulla struttura istituzionale delle nostre società, ma che abbiano a che fare unicamente con i limiti morali degli abitanti di quei quartieri. “Sono molti gli americani – scrive Barry – convinti del fatto che ciò non sia in nessun modo un riflesso del modo in cui è organizzata la loro società, ma solo della degenerazione morale (e forse anche genetica) degli abitanti del ghetto” (p. 17-18).
Questa sorta di cecità davanti alle evidenze anche le più smaccate è generata dal fatto che le società strutturalmente ingiuste producono narrazioni che tendono a rendere invisibile l’ingiustizia stessa. All’interno di queste narrazioni narrazione si attribuisce alla responsabilità dei singoli ciò che invece è il prodotto di condizioni strutturali. E’ la machinery of social injustice, la macchina che riproduce lo svantaggio, come la chiama Barry. Questa macchina funziona attraverso tre leve principali. La prima è legata alla distribuzione ineguale dei vantaggi naturali e sociali (la lotteria genetica e quella familiare); la seconda opera grazie alla capacità dei più forti di manipolare le istituzioni a proprio vantaggio e la terza, invece, si muove sul piano dello story-telling, grazie al quale le differenze strutturali vengono trasformate in giudizi morali, così che chi perde neanche si ribella; semplicemente si sente in colpa.
“Self-reinforcing inequality”, la diseguaglianza che alimenta sé stessa. Una spirale in cui il potere economico diventa potere politico, che diventa potere istituzionale, che si trasforma, infine, in potere simbolico. Perché nelle nostre società “La disuguaglianza non solo si trasmette – conclude il filosofo con una certa amarezza – ma si giustifica” (p. 177).
I cuori belli qui evocherebbero il riferimento all’uguaglianza di opportunità. Il merito funziona, infatti, solo se si parte da situazioni simili. Un culto ipocrita e di facciata. “Parole vuote intorno alle virtù delle pari opportunità – le definisce Barry – ma il mantra abituale è ‘pari opportunità di diventare disuguali’ (p. viii). Le opportunità diventano così, attraverso un meccanismo semplice e perverso, la giustificazione della disuguaglianza e non il suo rimedio. I più fortunati, per nascita, ricchezza, istruzione, non si limitano, infatti, a beneficiare dei loro vantaggi ma li trasformano in norme istituzionali, in nuove regole del gioco. E chi resta indietro non solo ha meno, ma è anche trattato come se valesse di meno. E così si impone la narrazione secondo cui chi è svantaggiato è responsabile del proprio insuccesso mentre chi ha successo viene percepito come meritevole anche quando il successo deriva soprattutto dalla fortuna o dalle condizioni di partenza. La macchina dell’ingiustizia è una macchina narrativa, prima ancora che economica, è una faccenda collettiva e non solo individuale. Fatichiamo spesso a comprenderlo perché “Fino a circa un secolo e mezzo fa la giustizia era comunemente intesa come una virtù non delle società, ma degli individui” (p. 18).
Disuguaglianza come disordine morale
Le “patologie della disuguaglianza”, come le definisce Barry, non sono solo una faccenda di reddito o di opportunità, non sono una faccenda individuale ma collettiva. Scavano nel profondo, erodendo la fiducia reciproca e la responsabilità morale.
Il crollo della fiducia interpersonale e istituzionale che abbiamo descritto in apertura dell’articolo crollo rappresentano un segnale chiaro di moral rot, di “degrado morale”, come lo definisce il filosofo di Oxford. La crescente disparità economica minaccia la stessa coesione di base di una società. “La portata del degrado morale causato da questi cambiamenti è stata dimostrata chiaramente (…) la disintegrazione del legame sociale e tutti i mali che ne derivano (…) Proprio come i passeggeri di prima classe del Titanic riuscirono ad ottenere la maggior parte delle scialuppe di salvataggio, i molto ricchi sono in grado di guardare con serenità alla disintegrazione del legame sociale e a tutti i mali che ne derivano, perché possono comprarsi la via d’uscita” (p. 184). La disuguaglianza smette di essere, così, solo una variabile economica e diventa l’acido che scioglie i nostri più profondi e necessari legami sociali.
Viviamo mondi separati
Il linguaggio non è casuale e l’espressione moral rot è volutamente forte. La si potrebbe tradurre come abbiamo fatto con “degrado morale”. Ma in inglese il significato più proprio è quello di “marciume”, “putrefazione”. Termini che evocano non soltanto un decadimento ma anche la possibilità di una contaminazione, di un passaggio da un ambito all’altro, della vita. Un contagio che passa dal comportamento individuale alla qualità della politica, dalle relazioni quotidiane alle aspettative nei confronti delle istituzioni. Questo può avvenire perché la fiducia non è un bene privato e quindi la sua erosione non riguarda solo i singoli ma l’intera comunità. La fiducia è un bene relazionale, che si costruisce solo quando le vite hanno una qualche forma di prossimità, quando ci si incontra, quando i destini non divergono in direzioni opposte. La disuguaglianza rompe questa prossimità. Trasforma la società da un “noi” in una somma di “io”.
La questione della prossimità è centrale e infatti uno dei canali attraverso cui l’acido corrosivo della disuguaglianza produce i suoi effetti nefasti è proprio la costruzione di “architetture di separazione”: quartieri, scuole, vite segregate. Il caso dei ghetti urbani americani documenta come scuole degradate e assenza di lavori dignitosi possano generare una spirale cumulativa di svantaggio. “La povertà e il basso livello di istruzione dei genitori, le molteplici patologie sociali del ghetto, unite a scuole scadenti, producono risultati scolastici disastrosi. A Chicago, ad esempio, metà delle scuole superiori della città si colloca nell’ultimo 1% dell’American College Test e due terzi degli studenti dei ghetti della città non riescono a diplomarsi,” (p. 95).
Le scuole non sono un semplice servizio, sono il primo laboratorio del futuro. Se qui si creano separazioni la vita sarà fatta per tanti di sentieri divergenti. Di vincitori e vinti. Per questo non basta alleviare la povertà, occorre ridurre la disuguaglianza. Solo la prossimità sociale, infatti, consente l’esistenza di un orizzonte comune. La povertà isola, la disuguaglianza divide.
La secessione dei ricchi
Circa dieci anni dopo la pubblicazione di Why Social Justice Matters di Brian Barry, Michael Sandel da alle stampe Democracy’s Discontent (appena riedito in un’edizione aggiornata per “tempi perigliosi”). La diagnosi del filosofo di Harvard riecheggia in maniera precisa la posizione del collega britannico. La disuguaglianza genera vite parallele, separate e rende, così, impossibile una cittadinanza condivisa. “La nuova disuguaglianza dà origine (…) a modi di vivere sempre più separati. I professionisti benestanti si ritirano gradualmente dalla vita pubblica in ‘enclave omogenee’ dove hanno pochi contatti con chi è meno fortunato di loro. Mentre i parchi pubblici e i campi da gioco si deteriorano, si moltiplicano i centri benessere privati e i circoli di golf, di tennis e di pattinaggio accessibili unicamente ai soci paganti. Mentre i figli dei ricchi si iscrivono a scuole private o a scuole relativamente omogenee nei sobborghi residenziali, le scuole pubbliche della città vengono lasciate ai poveri” (p. 230). Sandel esplicita ciò che in Barry è ancora implicito: la secessione dei ricchi è una secessione morale prima ancora che territoriale. Non è solo una separazione di spazi, è una separazione di responsabilità. E quando il destino non è più condiviso, il fondamento stesso della giustizia sociale si dissolve.
Senza fiducia non c’è democrazia
La relazione che Barry rintraccia tra disuguaglianza e crollo strutturale della fiducia e fondamentale perché aiuta a comprendere perché una società diseguale non è solo ingiusta ma anche ingovernabile. Ne è convinto anche Sandel. “La secessione dei ricchi – scrive – erode la virtù civica [e] una società di estremi manca dello ‘spirito di amicizia’ che l’autogoverno richiede” (p. 244). Per questo una società diseguale non ha solo un problema redistributivo, ma rappresenta un fallimento democratico. In una recente intervista ha affermato “Una nuova politica del bene comune richiederebbe di ripensare l’infrastruttura civica della vita comune per costruire istituzioni che favoriscano la mescolanza tra le classi sociali, dagli impianti sportivi ai parchi pubblici e alle aree ricreative, dai municipi alle piscine comunali, dalle biblioteche pubbliche ai trasporti pubblici. È attraverso l’incontro, che favorisce il mescolarsi di persone provenienti da contesti sociali diversi, che impariamo a gestire e ad accettare le nostre differenze. Ed è così che arriviamo a preoccuparci del bene comune. Se non vediamo e non interagiamo con persone di classi sociali diverse, è molto difficile arrivare a preoccuparci per loro o a riconoscere ciò che ci unisce. Per questo una parte importante di una nuova politica del bene comune è il tentativo deliberato di creare luoghi pubblici e spazi comuni, istituzioni che fanno incontrare le classi sociali, che riuniscono le persone e abbattono l’isolamento” (“Comunità disgregate. Intervista a Michael Sandel”. Pandora Rivista, 18 Novembre 2025). Se gli spazi comuni scompaiono, la democrazia si spegne.
Senza comunanza, incontro, relazione avremo società sempre più diseguali incapaci di trattare i cittadini da eguali. Avremo sempre più società di vincitori e vinti. Società incompatibili con una vita autenticamente democratica. “In sostanza – conclude Barry – la patologia sociale di una società altamente diseguale consiste nell’effetto distruttivo che la disuguaglianza ha sulla solidarietà sociale: la consapevolezza che coloro che vivono insieme condividono un destino comune e dovrebbero lavorare insieme. Il disprezzo per gli interessi degli altri diventa la norma” (2005, p. 154).
Una società diseguale può anche essere ricca, dinamica, competitiva. Ma non può essere democratica, perché la democrazia è fatta di prossimità: di vite che si sfiorano, di luoghi condivisi, di occasioni in cui la differenza non diventa distanza ma dialogo. Quando la distanza cresce oltre una certa soglia, quella prossimità evapora. E con essa evapora lo spazio morale in cui ciascuno riconosce all’altro la dignità di un pari, di un concittadino. La ricerca della giustizia sociale è necessaria, dunque, non perché tutti debbano essere uguali, ma per permette a tutti di sentirsi ugualmente parte della stessa società. Non solo di abitarla, ma di abitarla insieme.
La questione centrale non riguarda, dunque, tanto la scelta del livello ottimale, più alto o più basso, di redistribuzione. La questione centrale ha a che fare con la scelta di immaginare un futuro fatto di isole separate, indifferenti, incomunicabili o un altro in cui tornare a pensare che vivere insieme significhi, davvero, condividere lo stesso destino. Consci del fatto che la democrazia muore quando smettiamo di dare valore all’incontro con l’altro, al suo destino quanto al nostro.
ilsole24ore.com/art/quando-disuguaglianza-uccide-democrazie-AIpkN6H