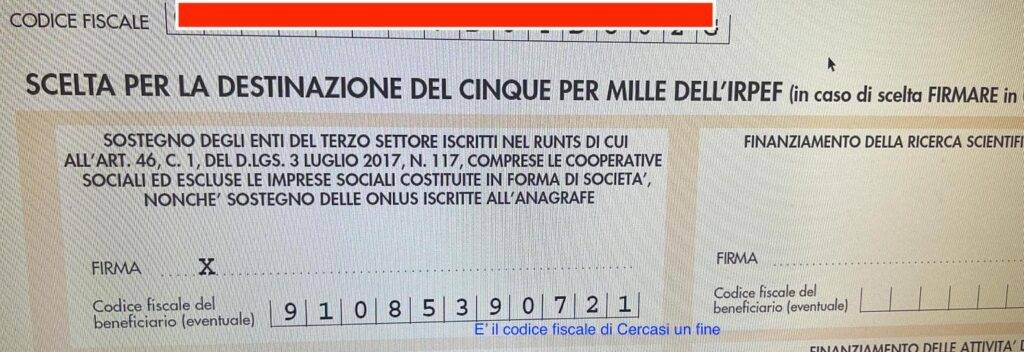Nel mondo di ieri non provavano ad arruolare il Padreterno. Sulla stessa poltrona di ministro delle Finanze ora occupata da un invasato religioso come Bezalel Smotrich, sedeva un socialista di buonsenso: Pinhas Sapir, guru dell’economia israeliana. Nel 1967, a guerra dei Sei Giorni appena vinta, Sapir avvertì Moshe Dayan: «Se continuiamo a tenere in pugno i Territori, prima o poi i Territori terranno in pugno noi».
Dayan, ministro della Difesa, non ne faceva una questione escatologica. Da vecchio generale, considerava, però, la Cisgiordania strappata ai giordani, Gaza presa all’Egitto e le altre fresche conquiste territoriali (Golan, Sinai, Gerusalemme est) una ragione di sicurezza oltre che un monito: i nemici dovevano percepire la nazione con la Stella di David come un «cane pazzo», troppo pericoloso per essere importunato. Non ascoltò le sagge parole di Sapir. E da lì cominciò per Israele quella che potremmo chiamare la maledizione dei Territori.
L’episodio, raccontato da Anna Momigliano nel suo Fondato sulla sabbia, si pone quale fulcro delle contraddizioni che hanno minato nell’ultimo mezzo secolo il sogno di una grande democrazia laica, l’unica in un quadrante geopolitico dominato da monarchie assolute, dittature e feroci teocrazie che da sempre fanno strame delle libertà civili e dei diritti umani. Se, dopo ventuno mesi di devastazioni a Gaza, Netanyahu e i suoi ministri estremisti stanno riducendo il Paese a uno Stato-paria; se lo sciagurato bombardamento della chiesa cattolica della Sacra Famiglia ha riaperto una frattura profonda col Vaticano; se le immagini dei bimbi gazawi ridotti a scheletri hanno indotto 28 nazioni, inclusa l’Italia, a rivolgere un appello «ultimativo» a Israele, beh, molto discende da quel passato lontano.
Il Sinai fu reso all’Egitto con gli accordi di pace del 1978-79, le alture del Golan e Gerusalemme est vennero invece annesse formalmente: il che implicava per i palestinesi la possibilità di diventare cittadini israeliani. Ma Gaza e la Cisgiordania restarono in un limbo giuridico: un’annessione avrebbe creato un forte contraccolpo demografico e, in prospettiva, un serio rischio identitario e politico. Dunque, si procrastinò l’occupazione militare: tramutando la democrazia israeliana in «legno storto», secondo la politologa liberale Dahlia Scheindlin, accorta analista dello scontro tra religione e stato di diritto in corso nel suo Paese.
Intendiamoci. Le parole a caldo con cui il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, «contestualizzò» nell’occupazione il 7 ottobre («non è caduto nel vuoto») restano ambigue nella forma, perché ammiccano al giustificazionismo, e sbagliate nella sostanza: perché Hamas, con gli ayatollah iraniani alle spalle, avrebbe compiuto il massacro a prescindere, obbedendo a un islamismo integralista che predica lo sterminio di tutti gli ebrei. Ma è indiscutibile che l’occupazione abbia snaturato Israele e umiliato generazioni di palestinesi. Anche perché in questi decenni centinaia di migliaia di israeliani mossi dal nazionalismo religioso verso Erétz Yisra’él, il Grande Israele promesso dalla Bibbia, si sono spinti a colonizzare i Territori, impiantando con la forza insediamenti, villaggi, avamposti, in una convivenza impossibile con gli arabi.
Gaza nel 2005 venne restituita ai palestinesi dall’ex falco Sharon che mandò l’esercito a sgomberare le colonie degli ultraortodossi: «Non è un segno di debolezza ma di forza, i gazawi vivono nella disperazione». Quella libertà fu però usata al peggio. Dalla Striscia, sottoposta poi a quasi un ventennio di dittatura messianica di Hamas, sono partiti i miliziani assassini del 7 ottobre. La reazione di Israele, prima di sconfinare nella disumanità contro due milioni di civili, aveva un fondamento razionale e condivisibile: colpire gli aggressori, anche se costoro si nascondevano in mezzo al loro stesso popolo.
Ma se oggi Gaza è una piaga aperta nell’onore degli israeliani, con una carestia indotta che ogni giorno ferisce tutti noi, la Cisgiordania appare una malattia politica diventata cronica. Lì l’occupazione non è mai finita, vige un doppio regime giuridico (uno per gli ebrei e uno per i palestinesi), 500 mila coloni (con ventidue nuove colonie appena approvate dal governo) considerano quelle terre ebraicamente Giudea e Samaria, ogni ipotesi di Stato palestinese pare pura utopia.
Netanyahu ha avuto almeno due occasioni per dichiarare vittoria e chiudere la guerra: l’uccisione di Yahya Sinwar, mente del pogrom, e il successo nell’attacco ai siti nucleari iraniani. Il New York Times, con una durissima inchiesta, gli imputa di averla prolungata per tornaconto personale, per tenersi buoni i ministri ultraortodossi e salvarsi dalle accuse di corruzione che lo inseguono, in vista delle elezioni del 2026. È innegabile che questi ventuno mesi sono serviti, oltre che a decimare Hamas, anche a disarmare Hezbollah in Libano, abbattere Assad in Siria, ridimensionare di molto gli ayatollah a Teheran. Il prezzo pagato dalla democrazia israeliana è tuttavia incalcolabile. Anche una tregua avrebbe basi fragili. Circolano progetti folli quasi quanto la Riviera di Trump, tutti ispirati dalla destra ultraortodossa dei coloni: rinchiudere seicentomila palestinesi a Rafah, creare in Cisgiordania otto emirati, piccole città-Stato, evacuare Gaza. Entrambe le parti pagano un terribile gap di secolarismo. Trent’anni fa, ai negoziati di Oslo, sedevano i laici: i laburisti israeliani e l’Olp di Arafat. La maledizione dei Territori ha finito per confondere religione e politica, offuscando la razionalità. Se pensi cha sia Dio a chiederti di buttare a mare il tuo vicino, puoi aver sbagliato vicino o sbagliato Dio: ma, quasi di certo, sei sbagliato tu.
corriere.it/opinioni/25_luglio_24/medio-oriente-quel-sogno-laico-sbiadito-c10d1abf-9f20-4731-b89c-de29e11eaxlk.shtml?refresh_ce