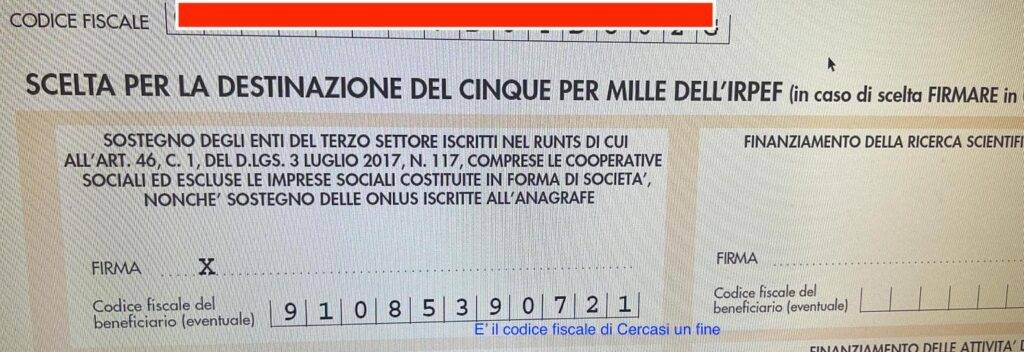Nel cuore della Striscia di Gaza, una tragedia umanitaria si consuma con la lentezza crudele della fame. Da troppo tempo in quel luogo diventato l’inferno in terra i bambini muoiono a occhi aperti, le madri stringono corpi ormai senza vita, e i padri scavano tombe a mani nude. Eppure, il mondo guarda altrove. L’orrore è reale, ma la risposta internazionale è un sussurro, un vago fastidio nella routine dell’attività diplomatica. Com’è possibile? La risposta non sta solo nelle ragioni della geopolitica o nella diplomazia, ma anche nella nostra psicologia, nel modo in cui il nostro cervello reagisce a simili tragedie e produce una verità sconcertante: più aumenta il numero delle vittime, meno ci curiamo di loro.
Lo psicologo americano Paul Slovic chiama questo fenomeno “pshychic numbing”, una vera e propria anestesia psichica che desensibilizza il nostro senso morale. Il termine descrive quel meccanismo per cui la nostra empatia si spegne davanti alla massa del dolore. «Uno è una tragedia, un milione è una statistica», diceva Stalin – e la psicologia sperimentale dà conferma della sua intuizione. A Gaza, ogni fotografia di un bambino denutrito dovrebbe spezzare il cuore dell’umanità. Eppure, le immagini si accavallano, si moltiplicano, diventano “troppo”. Siamo entrati a pieno titolo in quella che Robert Lifton e Greg Mitchell definiscono l’età della desensibilizzazione: una nuova era dove la sofferenza delle moltitudini è diventata rumore di fondo e l’anestesia collettiva ci fornisce un rifugio e un alibi.
Alla desensibilizzazione psichica si aggiunge un secondo fenomeno che ne amplifica l’effetto. Si tratta della cosiddetta “pseudoinefficacia”. Vedere un solo bambino affamato ci commuove; vederne mille ci fa sentire impotenti. È la tragica “aritmetica della compassione”, come scrive Daniel Västfjäll: più cresce la tragedia, più ci sentiamo piccoli e inutili, e invece di reagire con coraggio e impegno, scegliamo di girarci dall’altra parte per scappare dal senso di impotenza.
Ma la nostra psicologia non può essere una giustificazione o ancor peggio una scusa. Perché c’è anche la scelta politica. Sempre Slovic parla al riguardo di un “effetto prominenza” che si verifica quando le scelte degli Stati sullo scacchiere internazionale sono dominate da ciò che è più “visibile” e conveniente per i leader che quegli Stati li governano e che, per questo, sono pronti e ben disposti a lasciare da parte ciò che sarebbe moralmente più urgente. Ecco, Gaza e la sua tragedia non è prominente. Non genera voti, né profitti, a meno di raderla totalmente al suolo, di deportare i suoi due milioni di abitanti e di costruirci resort di lusso, sia ben inteso. È grazie all’“effetto prominenza” che l’indifferenza diventa una strategia calcolata prontamente mascherata da prudenza diplomatica.
Il risultato? Un assedio che affama deliberatamente un popolo, trasformando il pane in arma. Secondo il diritto internazionale, la fame come strumento bellico è un crimine. Ma dove sono le sanzioni? Dove sono le risoluzioni Onu capaci di agire, non solo di “condannare”? L’Occidente ha fatto del “mai più” un mantra, ma ora tace, pavido, mentre si consuma una delle più gravi crisi morali del nostro tempo. Gaza non ha bisogno di lacrime. Ha bisogno di voce. Di indignazione. Di una rottura netta con l’indifferenza. Perché ogni bambino lasciato morire di fame per calcolo politico rappresenta il fallimento più atroce di ogni valore su cui la nostra civiltà si fonda. E nessuna scusa psicologica potrà mai giustificare il silenzio di chi avrebbe potuto parlare e ha scelto di non farlo.
avvenire.it/opinioni/pagine/l-inferno-sulla-terra-il-silenzio-delle-nazioni