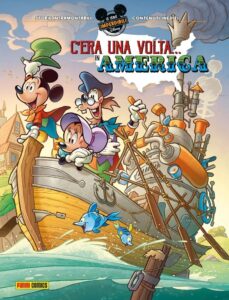L’etica pratica di Peter Singer riporta la filosofia morale nel suo terreno d’origine, quello in cui le idee si misurano con le sfide e i dilemmi della vita concreta. La sua filosofia, in questa prospettiva, interroga l’economia – la scienza triste dell’uso efficiente delle risorse – per formulare una domanda semplice e radicale: quanta sofferenza possiamo eliminare con i mezzi che abbiamo a disposizione? Il presupposto a tale domanda è che se possiamo fare del bene a qualcuno e possiamo farlo a un costo sostenibile, rimanere indifferenti è moralmente inaccettabile. È questa l’impostazione che sta alla base dell’“altruismo efficace”, un’etica della responsabilità calcolata, fondata sull’evidenza e sulla ragione. Non basta voler essere buoni; occorre esserlo nel modo più efficace possibile. Ne nasce una morale dal rigore geometrico, che misura la virtù non dalle intenzioni, ma dalle azioni e dai loro effetti. È una sfida diretta al sentimentalismo del nostro tempo, a quella bontà di superficie che si esaurisce spesso nella commozione o nel gesto simbolico. Quello di Singer non è un rifiuto della compassione, tutt’altro. È un esercizio di affinamento. Sottopone l’emozione a un principio di disciplina morale e la libera dall’ipocrisia. Perché “la compassione, se non è guidata dalla ragione, è cieca e spesso inefficace” (p. 82), scrive chiaramente in The Most Good You Can Do (Yale University Press, 2015).
Il suo è un invito a riconsiderare le basi utilitaristiche dell’etica e a immaginare la giustizia non come distribuzione di diritti, opportunità o risorse, ma come massimizzazione del benessere collettivo. È un’etica che non si limita a promuovere gesti individuali di altruismo, ma che propone un nuovo criterio di razionalità pubblica – un’economia morale dell’impatto – dove il valore di un’azione si misura in base a quanto essa contribuisce alla riduzione della sofferenza complessiva degli esseri senzienti. Singer ci pone in questo modo davanti ad una domanda scomoda ma urgente: se sappiamo come ridurre il male nel mondo, se possiamo farlo senza sacrifici insostenibili, con quale diritto scegliamo di non farlo?
Storie di un’etica possibile
Il punto di partenza dell’argomentazione di Singer è un esperimento mentale. Immaginate di camminare sul bordo di uno stagno e di vedere all’improvviso un bambino che rischia di annegare. Per salvarlo dovreste entrare nell’acqua e tirarlo fuori; questo significherebbe sporcarvi i vestiti e le scarpe. Sareste comunque disposti a farlo per salvare la vita al bambino? Non conosco nessuno che si rifiuterebbe di provarci. Si tratta di un’intuizione morale troppo ovvia, dice Singer, per ignorarla. Ma se è così ovvio che salvare il bambino è un dovere ineludibile, perché non applichiamo lo stesso principio ai bambini che muoiono ogni giorno di malaria o di fame dall’altra parte del mondo. Potremmo salvare anche loro, spesso pagando un prezzo molto inferiore a quello che dovremmo pagare per far lavare l’abito e le scarpe dopo un eventuale tuffo nello stagno. Ecco che allora il nostro comportamento quotidiano contraddice la logica morale che diciamo di accettare.
L’idea di “altruismo efficace” (effective altruism), allora, non è altro che una forma di etica che applica la razionalità scientifica alla compassione. Singer lo definisce così: “Gli altruisti efficaci sono coloro che usano l’evidenza e la ragione per capire come poter fare il massimo bene possibile agli altri e che agiscono di conseguenza” (p. 7). Non basta voler aiutare, bisogna farlo in modo che il bene prodotto sia massimo, rispetto ai mezzi impiegati.
La sua argomentazione è narrativa, fatta di storie di persone comuni che hanno superato l’ipocrisia del sentimentalismo e che incarnano compiutamente la logica dell’altruismo efficace. C’è Matt Wage, laureato a Princeton, che rinuncia a una carriera accademica per andare a lavorare nella finanza. Il suo obiettivo è guadagnare il più possibile per poter devolvere la metà del proprio reddito alle cause umanitarie più efficaci. Matt Wage – scrive Singer – “Capì che guadagnando e donando avrebbe potuto fare molto di più che lavorando direttamente per un’organizzazione benefica” (p. 5). C’è poi Julia Wise, che insieme al marito Jeff Kaufman vive con estrema semplicità per poter donare gran parte del proprio reddito. I Kaufman hanno deciso che una spesa annua di $36.000 sarebbe stata sufficiente per coprire i loro bisogni. Tutto il resto viene donato per la lotta contro la povertà estrema e le malattie prevenibili. “Per Julia – scrive Singer – donare non è un sacrificio, è uno stile di vita. Trova gioia nel sapere di poter aiutare gli altri” (p. 27). Uno dei punti più interessanti del racconto è che quella di Julia non viene presentata come una figura ascetica o disincarnata. Singer ne parla con grande attenzione psicologica, mostrando come la pratica del dono, lungi dall’essere scontata, abbia costretto Julia a trovare un equilibrio con la vita personale e con il desiderio, per esempio, di avere una famiglia. In un passaggio particolarmente toccante, Singer riporta la riflessione di Julia sulla difficoltà di conciliare la maternità con l’imperativo etico a donare: “Quando ero incinta, ho capito che avrei dovuto donare di meno. Avrei dovuto pensare non solo a ciò di cui hanno bisogno gli altri, ma anche a ciò di cui ha bisogno mia figlia, e a ciò di cui ho bisogno io per prendermi cura di lei” (p. 29).
Questa confessione, nella lettura che ne dà Singer, non rappresenta un cedimento, ma la prova che l’altruismo efficace non richiede l’annullamento personale, bensì la ricerca di un equilibrio tra razionalità morale e cura concreta delle relazioni. Julia Wise incarna una forma di altruismo “sostenibile”. Non un eroismo sovrumano, ma la disciplinata continuità di un gesto quotidiano. Singer la presenta come un esempio di come la felicità personale e la responsabilità globale possano coesistere. “Persone come Julia e Jeff – scrive il filosofo – mostrano che vivere eticamente, lungi dal rendere la vita più difficile, la rende più significativa” (p. 31). L’altruismo efficace viene incarnato nella sua forma più umana e convincente; non come un calcolo freddo, ma come una “razionalità gentile”. Una vita moralmente coerente non necessariamente deve implicare rinunce e sacrifici. Si tratta, piuttosto, di un modo concreto di ampliare il proprio senso di appartenenza al mondo. Per Singer, Julia e il marito rappresentano la prova vivente che la felicità non deriva dal consumo, ma dal contributo: una forma concreta di giustizia morale resa possibile da scelte ordinarie.
La giustizia come riduzione della sofferenza
Questi e molti altri esempi che Singer presenta nel suo libro servono a mostrare che l’etica dell’altruismo efficace non è una forma eroica di ascetismo, inarrivabile ai più, ma un modo alternativo di vivere normalmente, un modo che non implica necessariamente la rinuncia, e che punta tutto sull’efficacia. Perché il vero altruista non si limita a essere buono, ma cerca, piuttosto, di essere utile.
L’altruismo efficace, come tutto l’approccio di Singer, si fonda, aggiornandolo, sull’utilitarismo di Jeremy Bentham e John Stuart Mill secondo cui una società giusta è quella che punta alla “massima felicità per il numero più grande”. Singer adatta questa visione alla scala globale dell’economia contemporanea, nella quale – sostiene – il nostro potere di incidere sul benessere altrui è immenso. Un individuo con un reddito medio in un Paese ricco può salvare decine di vite in un Paese in via di sviluppo, se sceglie le giuste cause. Il criterio non è la prossimità geografica, ma l’impatto: una vita in Uganda vale quanto una vita a Londra o Milano. “Dal punto di vista dell’universo – scrive ancora il filosofo citando Sidgwick – la sofferenza di ciascuno conta esattamente allo stesso modo” (p. 97). È un cosmopolitismo morale il suo che dissolve i confini tradizionali della giustizia. Il confine tra “noi” e “loro” sparisce perché ciò che ci unisce tutti e ci fa tutti uguali è la comune capacità di provare sofferenza e di essere felici. “Non possiamo aspettarci che tutti siano santi, ma possiamo aspettarci che tutti facciano qualcosa di significativo” (p. 68), scrive ancora Singer. E fare qualcosa di significativo, in questa prospettiva, significa ottimizzare l’impatto. Per questo occorre scegliere bene sia la causa per la quale donare, sia l’organizzazione attraverso cui farlo. Per questo occorrono dati verificabili che mostrino il rapporto tra costo sostenuto e vite salvate. Ogni dollaro deve produrre il massimo di benessere complessivo. Questa visione porta Singer a proporre una forma di giustizia distributiva utilitaristica: in un mondo di risorse limitate, è moralmente giusto allocarle dove generano il più grande beneficio per il maggior numero di persone. Non è un’economia del merito, ma dell’urgenza: la priorità non è chi “merita” aiuto, ma chi può trarne il massimo vantaggio. Il principio di efficienza è l’unico che possa reggere una moralità globale. L’empatia selettiva, quella che ci fa donare a una causa solo perché ci colpisce o magari ci tocca da vicino, è un lusso psicologico che non dovremmo permetterci. L’altruismo efficace non riguarda solo le scelte individuali, ma disegna una visione complessiva della società giusta.
Singer non parla di carità, ma di giustizia globale: la riduzione della sofferenza come criterio oggettivo di progresso umano. Una società giusta non è quella che proclama valori universali, ma quella che ottiene concretamente più benessere e meno sofferenza per tutti. Si tratta di una visione la cui forza sta nella semplicità: se ogni vita conta allo stesso modo, allora ogni decisione economica è una decisione morale. Il prezzo di un caffè, un investimento, un voto politico. Tutto può essere valutato in termini di vite migliorate o perdute.
L’efficienza morale come nuova frontiera della politica
Singer è ben consapevole che questa razionalità morale può sembrare disumana. “Non possiamo vivere ogni istante come se fossimo sempre davanti al bambino che annega” – ammette (p. 121). Tuttavia, la visione utilitaristica della giustizia che ne deriva è anche una provocazione per le democrazie liberali. Se la moralità è una questione di calcolo razionale, che posto resta per i valori, le culture, le differenze? Singer non offre risposte definitive, ma suggerisce che la politica, per essere giusta, debba incorporare criteri di efficacia morale, misurando l’impatto delle decisioni pubbliche sulla qualità della vita reale. È una prospettiva in virtù della quale dovremmo guardare le nostre vite non per quanto possediamo, ma per quanto bene potremmo fare con ciò che possediamo. È una morale che disorienta, perché non concede rifugio nel sentimentalismo e tanto meno lascia spazio all’ipocrisia autoassolutoria. Ma proprio per questo è anche una delle poche proposte di giustizia all’altezza della globalizzazione: una ragione compassionevole, una solidarietà misurata e concreta. In un tempo che ha eletto l’efficienza economica a suo idolo, Singer ci ricorda che la vera efficienza è morale: trasformare risorse in benessere, conoscenza in equità, ricchezza in vite salvate.
Certo, neanche la versione moderna dell’utilitarismo di Singer sfugge alla critica che John Rawls muove all’utilitarismo classico: nella sua lucida razionalità esso finisce, infatti, per trattare le persone come mezzi e non come fini in sé. Se, infatti, l’obiettivo è la massimizzazione della somma delle utilità individuali, quando la privazione di alcuni produce un beneficio proporzionalmente maggiore per altri, allora tale privazione – di reddito, di opportunità, perfino di diritti e libertà – è da considerarsi legittima. E una teoria della giustizia che genera ingiustizia anche se per pochi, necessariamente cade in una contraddizione difficilmente risolvibile.
Ciò non toglie che Peter Singer con la sua idea di altruismo efficace ponga una sfida formidabile al senso comune, al sentimentalismo, alla pietà pelosa, di chi si scandalizza a parole ma poi non muove un dito per ridurre le sofferenze altrui, anche quando potrebbe farlo facilmente e in modo economico. Forse il messaggio più radicale che ne emerge è che l’efficienza, valore cardine dell’economia moderna, deve essere riscattata moralmente. Non basta produrre o crescere: bisogna sapere a vantaggio di chi. L’unica efficienza che può salvarci è quella che trasforma la ricchezza in giustizia, il calcolo in compassione, la ragione in cura del mondo.
https://www.ilsole24ore.com/art/l-altruismo-efficace-e-l-idea-giustizia-AHl2ruLD?refresh_ce