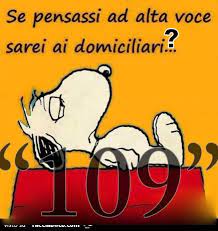Le scienze umane sono diventate il modo in cui la società finge di pensarsi. Hanno assunto il linguaggio delle scienze esatte per sentirsi credibili, e così hanno perso la loro funzione originaria: interrogare la vita invece di catalogarla. La crisi culturale non è un problema di contenuti ma di sguardo. Si è trasformato il pensiero in una procedura, l’intuizione in un algoritmo di ricerca, la riflessione in un formato editoriale. La filosofia cerca dati, la psicologia compila questionari, la sociologia riduce l’umano a ciò che si può misurare. Tutto il resto è scartato come residuo non replicabile. Byung-Chul Han ha descritto questa condizione come la società della prestazione: ogni sapere deve giustificarsi attraverso la produttività, persino quello che nasce per mettere in discussione l’idea stessa di prestazione. L’accademia non pensa, produce. Pubblica, cita, contabilizza. Il pensiero viene valutato in base all’impatto, non alla verità. La conoscenza è diventata un’economia della visibilità. L’università non è più un luogo di formazione, ma una catena di montaggio cognitiva dove ogni deviazione costa tempo, e ogni tempo non quantificato è considerato fallimento.
Edgar Morin lo aveva previsto da decenni: un sapere che non sa più connettere diventa un sapere che non sa più capire. La frammentazione metodologica ha dissolto la possibilità di una visione complessa dell’uomo. Ogni disciplina scava la propria fossa epistemologica, orgogliosa del metodo che la separa dal resto. Ciò che doveva unire, separa. Ciò che doveva chiarire, semplifica fino a distorcere. Pensiamo attraverso moduli preimpostati, categorie a scelta multipla, call for paper e protocolli di conformità. Il pensiero è diventato un format replicabile, e la sua prima vittima è l’esperienza. Le scienze umane, nate per attraversare la contraddizione, si sono ridotte a confermarla. Sono diventate la zona franca dove il sistema si autolegittima. Citano se stesse per non guardare ciò che è vivo. La loro funzione è cambiata: non spiegano il mondo, lo assolvono. E nel momento in cui lo assolvono, lo perpetuano. Il sapere oggi non deve più comprendere, deve tranquillizzare. Ogni incertezza viene trattata come errore di protocollo, ogni deviazione come anomalia statistica. Anche il dubbio, un tempo motore della conoscenza, è stato normalizzato: si può dubitare, ma entro i limiti consentiti dal metodo. Si può criticare, ma solo ciò che è già stato approvato come oggetto di critica. La verità oggi non si falsifica: si certifica. L’autore si fa revisore, il revisore si fa garante, e tutti firmano per non perdere il posto al tavolo. La peer review è diventata una forma di cortesia reciproca: un sistema di lodi incrociate che garantisce che nulla di vivo passi il filtro. I paper vengono approvati da indirizzi fantasma, recensiti da colleghi compiacenti o da autori che si valutano da soli sotto falso nome. Il pensiero viene filtrato finché non rischia più nulla. Non serve censurarlo: basta normalizzarlo.
Anche la libertà accademica ha un prezzo. Chi non pubblica non mangia, chi non si conforma non pubblica. Negli Stati Uniti il modello è ormai perfetto. Le università, diventate imprese, selezionano i ricercatori non per ciò che pensano ma per quanto producono. Pubblicazioni, citazioni, ranking. Ogni idea è una valuta, ogni deviazione una perdita di valore. I giovani studiosi che non provengono da famiglie ricche sopravvivono con borse di studio che chiedono in cambio docilità. Gli altri si indebitano per decenni. Il debito funziona come una forma di controllo: trasforma la ricerca in sopravvivenza. Chi deve restituire centomila dollari non può permettersi di essere scomodo. L’Europa ha importato quel modello con entusiasmo, come sempre in ritardo di un’epoca e convinta di essere al passo. Anche le scienze umane sono entrate nella logica della produttività misurabile. Non si chiede più cosa un testo dice, ma quante volte è stato citato. La qualità non è un valore, è una statistica. Filosofi e sociologi si comportano come startupper di concetti: devono attrarre fondi, convincere le commissioni, dimostrare efficienza. L’intuizione è diventata sospetta, la lentezza un difetto. Si pensa per bandi, non per urgenza.
La pressione a pubblicare ha creato una nuova forma di povertà cognitiva: si scrive per restare visibili, non per dire qualcosa. Gli articoli vengono moltiplicati per accumulare punti, le idee ridotte a progetti finanziabili. L’originalità non è più premiata, ma punita: rallenta il flusso. Chi osa deviare perde la carriera, chi obbedisce ottiene la tenure. È una selezione naturale dell’obbedienza. La paura di sparire ha sostituito il desiderio di capire. L’intelligenza si è fatta amministrativa. Pensare non significa più rischiare, ma compilare correttamente. La verità è diventata una questione di formattazione. Il sapere ha sostituito la realtà con la propria griglia di lettura. Non osserva il mondo: lo interpreta fino a cancellarlo. E ciò che sfugge alla griglia viene definito errore, deviazione, o, peggio, poesia. Nel mondo della ricerca e dell’informazione, il linguaggio stesso è stato addestrato all’obbedienza. Parole neutre, reversibili, sterili. Scriviamo per non offendere, pensiamo per non sbagliare. L’immaginazione è trattata come un errore di metodo, la complessità come un difetto di chiarezza. Tutto ciò che non produce consenso è archiviato come inutile. Così il linguaggio, nato per creare mondi, oggi serve a gestirli. La crisi del linguaggio precede quella del pensiero. Quando le parole diventano strumenti di conformità, la realtà diventa un vocabolario chiuso. Non si può dire ciò che non si deve pensare. E ciò che non si può dire smette di esistere.
È così che la cultura si trasforma in burocrazia: ogni idea deve presentare un modulo, ogni intuizione una referenza, ogni libertà un’autorizzazione preventiva. Le scienze umane non sono vittime del sistema, ne sono il sintomo. Sono la sua forma riflessa: producono teoria come il mercato produce merci. La loro neutralità è la più sofisticata delle ideologie, perché non si dichiara. La paura di sbagliare ha sostituito il coraggio di pensare. La prudenza si è fatta valore morale, e l’inerzia intellettuale, virtù accademica. Un tempo il sapere serviva a mettere in crisi il potere. Oggi serve a proteggerlo. Il pensiero non è più rivoluzionario, ma preventivo. Analizza prima di esistere, si giustifica prima di affermarsi. Ogni nuova idea è sottoposta a un test di compatibilità con ciò che già è. Il sistema non vieta di pensare: sterilizza il pensiero prima che possa generare conseguenze. La verità non è più qualcosa da cercare, ma qualcosa da mantenere. La filosofia, in fondo, non è morta: si è iscritta a un corso di aggiornamento. La crisi culturale non è la fine del pensiero: è la sua normalizzazione. Il mondo non ha smesso di produrre idee; ha solo imparato a farlo senza rischio. Il pensiero che non rischia non pensa più: obbedisce.
dissipatio.it/la-crisi-culturale-e-una-forma-dordine/