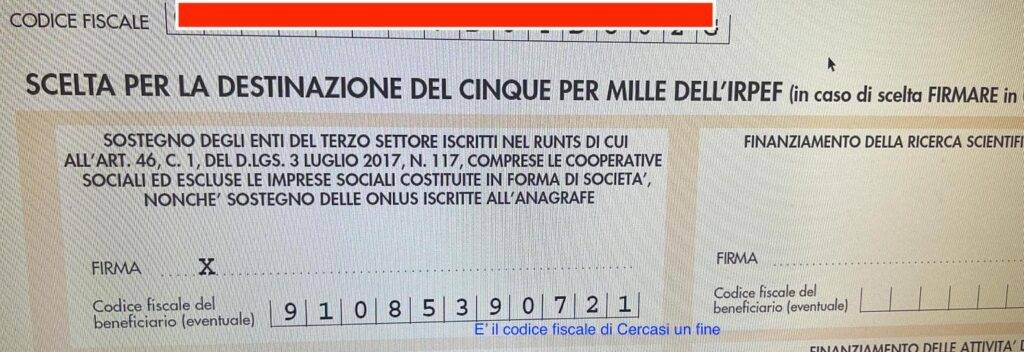Per l’ex Ilva è arrivato il giorno del giudizio. L’ennesimo. La vicenda della crisi dell’impianto siderurgico più grande d’Europa ha le sue radici nella mancata conciliazione tra esigenze produttive, occupazionali (impiega 10.500 dipendenti, per non parlare dell’indotto) e ambientali. Il quartiere tarantino di Tamburi, dove ai davanzali delle finestre e sugli stenditoi si forma uno strato di polvere rossa che chi scrive ha visto coi suoi occhi e che in passato ha visto crescere rispetto alla media tumori anche infantili, ne è un esempio. Uno dei momenti salienti è l’incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sul futuro di questo gigante malato che da mesi necessita di un’iniezione di liquidità e di una prospettiva di sviluppo aziendale che guardi alla riconversione degli stabilimenti. Ma già prima dell’incontro con le parti sociali, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si era presentato al Senato per un’informativa. «C’è l’urgenza di un intervento drastico che segni una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi 10 anni», aveva detto. «Nulla di quello che era stato programmato e concordato è stato realizzato. Nulla è stato mantenuto in merito agli impegni occupazionali e al rilancio industriale».
Attualmente la gestione di Acciaierie d’Italia (così è stato ribattezzato l’impianto) è in mano in quanto azionista di maggioranza, alla ArcelorMittal, del magnate indiano Lakshmi Nivas Mittal, salito tra l’altro all’onore delle cronache per aver organizzato per la figlia un matrimonio di tre giorni a Barcellona costato 50 milioni di sterline. L’azienda l’aveva comprato all’asta nel 2018, assumendosi il difficile compito di risanare una società compromessa da anni di indagini per danni ambientali. Il risanamento però non è mai avvenuto. E così, alla fine del 2020 lo Stato aveva quindi deciso di intraprendere un percorso per diventarne il proprietario. Nel dicembre di quell’anno era stato approvato un accordo per il rilancio: lo Stato sarebbe arrivato a detenere il 60 per cento del capitale. Ma quel piano non è mai andato in porto.
E così arriviamo alle ultime vicende. Le Acciaierie continuano ad andare in perdita e sono da tempo in crisi di liquidità. Per salvare la produzione e mantenere i posti di lavoro serve oltre un miliardo di euro, un 24esimo dell’ultima manovra economica. Ma la multinazionale franco indiana, che ne possiede il 68 per cento, non vuole più investirci; la parte restante è dello Stato, che è disposta a metterci gran parte dei soldi per rilanciarla a patto di prenderne il controllo e diventare socio di maggioranza come nei piani del 2020.
L’ipotesi più probabile è che l’ex Ilva finisca temporaneamente sotto amministrazione straordinaria, una procedura che le permetterebbe di restare operativa concordando con il tribunale civile un piano di risanamento che tuteli i creditori e i dipendenti. Ma la faccenda non è così semplice perché lo Stato da solo non può rilanciare un settore complesso e strategico come quello dell’acciaio. Serve un socio privato dotato di know how in grado di competere con i concorrenti mondiali. Da tempo al ministero dell’Economia si stanno cercando investitori, ma senza riuscirci. In pratica lo Stato vuole rientrare nell’ex Ilva come padrone, rovesciando le parti, l’Arcelor Mittal invece vuole recuperare i soldi investiti e andarsene per sempre, senza rimanere socio di minoranza e quindi senza continuare a mettere soldi nelle acciaierie tarantine. La multinazionale del magnate indiano sostiene anche che a fronte di due miliardi di euro lo Stato ha versato solo 350 milioni. E dunque, prima di arrivare al commissariamento, vedremo le parti in causa approdare in tribunale con un contenzioso giuridico che potrebbe costare allo Stato centinaia di milioni di euro. Sullo sfondo il problema di assicurare l’obiettivo paradigmatico dell’ex Ilva: quello di conciliare salute, produttività e lavoro.
www.famigliacristiana.it/articolo/il-governo-alla-prova-dell-ex-ilva.aspx