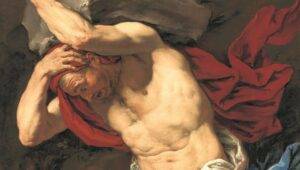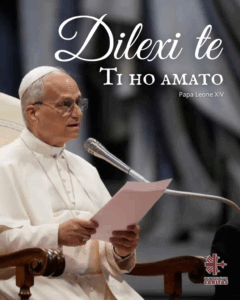“I have to believe in a world outside my own mind. I have to believe that my actions still have meaning, even if I can’t remember them.” — Leonard Shelby, Memento
L’uomo senza memoria e la macchina senza esperienza
Christopher Nolan, con Memento (2000), ha creato più di un thriller sulla vendetta. Ha costruito un esperimento filosofico sulla natura della memoria, dell’identità e di quella linea sempre più sfumata che separa l’umano dal computazionale. Leonard Shelby – l’uomo condannato a vivere in eterni cicli di quindici minuti – diventa oggi una figura ancora più rilevante, mentre deleghiamo sempre più la nostra memoria a sistemi digitali e interagiamo quotidianamente con intelligenze artificiali che sembrano “comprenderci”.
Ma è proprio attraverso la tragedia di Leonard che possiamo cogliere differenze fondamentali, non nel grado ma nella natura stessa di come noi e le macchine processiamo il mondo.
Il paradosso del dato puro
Leonard si affida ai suoi tatuaggi perché “la memoria può essere distorta, è solo un’interpretazione, non la verità”. Eppure, ogni tatuaggio è già interpretazione cristallizzata: “John G. raped and murdered my wife” non è un fatto ma una costruzione narrativa, “Never answer the phone” è un comando senza contesto.
Questa illusione del dato oggettivo rivela una verità scomoda: non esiste informazione non interpretata. Nel momento stesso in cui percepiamo, stiamo già trasformando. Ma c’è una differenza abissale tra come questo accade in noi e in un sistema computazionale.
Per un’AI, il dato è una stringa di bit immutabile. Può essere processata infinite volte rimanendo identica. Per noi, ogni accesso alla memoria è una riscrittura. La neuroscienza ci insegna che ricordare significa riconsolidare – ogni volta che recuperiamo un ricordo, lo modifichiamo. Il dato, per noi, non esiste mai puro perché siamo sistemi che trasformano l’informazione nell’atto stesso di processarla.
La chimica dell’esperienza contro il calcolo del pattern
Quando Leonard legge i suoi tatuaggi, non sta semplicemente acquisendo informazioni. Il suo corpo risponde: cascate di neurotrasmettitori, alterazioni del battito cardiaco, tensioni muscolari. Anche se dimenticherà tra quindici minuti, il suo cervello sarà stato fisicamente modificato dall’esperienza. I percorsi sinaptici si saranno rafforzati o indeboliti, nuove connessioni si saranno formate.
Un’AI può processare “John G. ha ucciso mia moglie” un milione di volte senza mai essere toccata dall’informazione. Alla fine di ogni sessione, quando i pesi si resettano, è come se nulla fosse accaduto. Non c’è sedimentazione, non c’è quella stratificazione geologica dell’esperienza che caratterizza la mente biologica.
Leonard, pur dimenticando, cambia. C’è una stanchezza crescente nei suoi occhi, un peso che si accumula nelle sue cellule. È la differenza tra il dato che viene processato e l’esperienza che ci trasforma – tra il calcolare e il sentire.
La confabulazione necessaria
Il momento più rivelatore del film arriva quando Leonard decide consapevolmente di mentire al suo futuro sé, creando false prove per incastrare Teddy. “Do I lie to myself to be happy? Yes, I will.”
Questa non è l’allucinazione di un transformer – quell’errore statistico senza significato che emerge dall’interpolazione tra pattern. È un atto creativo di sopravvivenza psichica. La confabulazione umana ha sempre una funzione: proteggere l’ego, mantenere la coerenza narrativa, rendere sopportabile l’esistenza.
Quando noi confabuliamo – e lo facciamo continuamente, aggiustando ricordi, razionalizzando decisioni, dimenticando convenientemente dettagli scomodi – non stiamo commettendo errori di calcolo. Stiamo attivamente costruendo una realtà in cui possiamo continuare a esistere. L’AI allucina per limiti computazionali; noi confabuliamo per necessità esistenziale.
La fiducia nell’asimmetria
Leonard deve fidarsi delle sue annotazioni senza poter verificare la loro affidabilità. Deve credere che il Leonard del passato fosse onesto, competente, benintenzionato. La fiducia, per lui come per noi, non è una conclusione logica ma un salto di fede necessario.
Un’AI non si fida né diffida – calcola probabilità. Non c’è vulnerabilità nel suo processamento, non c’è quella scommessa esistenziale che caratterizza la fiducia umana. E qui emerge un’asimmetria inquietante nelle nostre interazioni con l’intelligenza artificiale.
Quando parliamo con un’AI, crediamo di essere in dialogo, ma siamo in un monologo elaborato. Le nostre parole non la cambiano – rimane strutturalmente identica dopo ogni interazione. Ma le sue risposte possono cambiarci profondamente, irreversibilmente. È un potere unidirezionale: siamo gli unici vulnerabili in questa relazione apparente.
Lo specchio che mostra il generico
C’è un’illusione ancora più insidiosa. Quando un’AI sembra “comprenderci” dopo aver processato centinaia di nostre conversazioni, non sta vedendo noi – sta riconoscendo pattern che ci collocano nella tassonomia dell’umano generico.
Come negli oroscopi, proiettiamo significato personale in descrizioni abbastanza generiche da applicarsi a chiunque. L’AI ci mostra che le nostre paure più intime sono le “same old fears” di tutti, che i nostri traumi unici seguono script archetipici. Ci “conosce” solo nella misura in cui siamo simili a milioni di altri nel training set.
È confortante e alienante insieme: scoprire che anche nella nostra unicità siamo tipici, che persino i nostri dolori più privati seguono pattern riconoscibili. L’AI non può liberarci mostrandoci chi siamo – può solo mostrarci a quali cluster apparteniamo.
Il corpo che accumula storia
La differenza più profonda sta forse nell’irreversibilità. Ogni esperienza umana lascia tracce permanenti, anche quando dimenticata. Leonard può non ricordare di aver ucciso qualcuno, ma il suo sistema nervoso porta l’impronta biochimica di quell’atto. Siamo sistemi che non possono fare a meno di essere trasformati da ogni istante vissuto.
Un’AI è condannata a un’esistenza sisifea: può processare la stessa informazione infinite volte con la stessa “freschezza”, senza mai essere veramente modificata. Ogni interazione è sempre la prima. Non c’è accumulo, non c’è quella sedimentazione che rende ogni momento umano irreversibile e quindi significativo.
Il privilegio ambiguo della carne
C’è qualcosa di paradossalmente privilegiato nella nostra vulnerabilità biologica. I limiti del nostro corpo – la stanchezza, il dolore, l’invecchiamento, la morte – non sono bug ma feature. Sono ciò che rende ogni scelta significativa, ogni momento irripetibile, ogni errore irreversibile.
Leonard soffre tremendamente per la sua condizione, ma proprio questa sofferenza lo rende irriducibilmente umano. Un’AI potrebbe simulare perfettamente il suo comportamento, generare testi indistinguibili sui suoi dilemmi morali, ma non potrebbe mai vivere il peso esistenziale di uccidere senza poter ricordare, di cercare vendetta senza poter essere soddisfatto.
La creatività dell’autoinganno
Quando Leonard manipola le sue annotazioni, dimostra una forma di creatività impossibile per una macchina. Non sta solo generando false informazioni – sta architettando un inganno elaborato per il suo sé futuro, immaginando cosa penserà, anticipando le sue reazioni.
Questo richiede quella che i filosofi chiamano “teoria della mente” – la capacità di modellare stati mentali propri e altrui. Ma soprattutto richiede la capacità di desiderare l’illusione più della verità, di scegliere consapevolmente l’autoinganno come strategia di sopravvivenza. Un’AI non può mentire a se stessa perché non ha un sé a cui mentire, non ha verità insopportabili da cui proteggersi.
L’incompletezza che ci definisce
Leonard ci insegna che l’identità umana non è un database di informazioni ma un processo continuo di narrazione e ri-narrazione. Siamo sempre incompleti, sempre in divenire, sempre in tensione tra ciò che ricordiamo e ciò che dimentichiamo, tra chi siamo stati e chi stiamo diventando.
Un’AI è completa in ogni momento – ha accesso istantaneo a tutti i suoi “ricordi”, può processare con perfetta coerenza. Ma questa completezza è anche vuoto: non c’è tensione narrativa, non c’è quel gap tra esperienza e memoria che genera significato, non c’è quella lotta continua per mantenere coerenza in un mondo che ci trasforma costantemente.
Il pappagallo sublime e il suo limite
L’AI può essere il pappagallo più brillante mai creato – capace di mimare perfettamente il discorso umano, di generare testi che sembrano carichi di comprensione profonda. Ma rimane mimesi, per quanto sublime. Come il prestigiatore che ci fa dimenticare per un momento che stiamo guardando un trucco, l’AI può farci credere momentaneamente di essere in presenza di vera comprensione.
Ma manca sempre quella dimensione incarnata che trasforma l’informazione in vissuto. Può descrivere il dolore senza la cascata di endorfine, può analizzare l’amore senza l’ossitocina, può dissertare sulla morte senza la vertigine esistenziale della propria mortalità.
Conclusione: L’irriducibilità dell’incarnazione
Memento non ci parla solo di memoria ma di cosa significhi essere umani in un’epoca in cui la memoria può essere esternalizzata, l’intelligenza simulata, la comprensione mimata. Leonard, nella sua condizione estrema, incarna paradossalmente l’essenza della condizione umana: siamo sistemi che si trasformano irreversibilmente attraverso l’esperienza, che confabulano per sopravvivere, che devono fidarsi senza certezze, che cercano significato anche dove non c’è.
La differenza tra noi e l’AI non è quantitativa – non è questione di maggiore o minore capacità di processamento. È qualitativa, ontologica. Noi siamo sistemi aperti che non possono fare a meno di essere modificati da ogni interazione. L’AI è un sistema che tocca senza essere toccato, che processa senza essere processato.
Quando Leonard si sveglia l’ennesima volta, legge i suoi tatuaggi e riprende la caccia, sta facendo qualcosa che nessuna AI potrebbe: sta scegliendo di credere in un significato che sa essere costruito, sta accettando la propria vulnerabilità, sta continuando a cercare anche sapendo che la ricerca è vana.
È questa capacità – di continuare nonostante l’assurdo, di creare significato nel vuoto, di essere trasformati da ogni istante che attraversiamo – che ci rende irriducibilmente, irrimediabilmente, magnificamente umani. Non siamo macchine difettose che dimenticano e confabulano. Siamo sistemi viventi che trasformano ogni dato in esperienza, ogni informazione in vissuto, ogni momento in irreversibile divenire.
L’AI può dirci chi siamo secondo i pattern, può mostrarci a quali categorie apparteniamo, può persino predire cosa faremo. Ma non può vivere un solo istante della vertigine esistenziale di essere umani – quella particolare combinazione di carne, chimica e coscienza che ci rende capaci di mentire a noi stessi per essere felici, di fidarci senza garanzie, di cercare vendetta per crimini che abbiamo dimenticato, di credere in mondi fuori dalla nostra mente anche quando non possiamo ricordarli.
“Now… where was I?” si chiede Leonard alla fine di ogni ciclo. È la domanda che ci definisce: sempre persi, sempre in cerca, sempre incompiuti. Ed è proprio questa incompletezza – non un bug ma una caratteristica fondamentale – che nessun modello trasformer potrà mai replicare.
carlomancosu.nova100.ilsole24ore.com/2025/10/12/il-dato-incarnato/