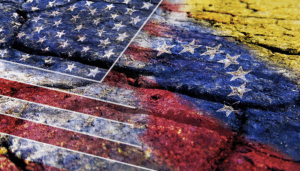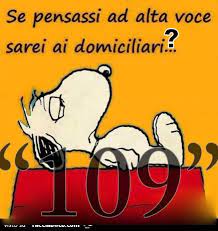Nata a Hannover nel 1906 e morta a New York nel 1975, Hannah Arendt è stata una filosofa, una studiosa di teoria politica e una storica tedesca naturalizzata statunitense. Di famiglia ebraica, in tenera età si trasferisce a Königsberg (allora capitale della Prussia Orientale) a causa della salute del padre. Cresce in una famiglia secolarizzata e politicamente progressista. Completata l’istruzione secondaria, si iscrive a filosofia all’Università di Marburgo, dove diventa allieva di Martin Heidegger e con il quale ha poi una relazione segreta per quattro anni. Si trasferisce prima all’Università di Friburgo, dove segue le lezioni di Edmund Husserl, e successivamente all’Università di Heidelberg per studiare con Karl Jaspers, sotto la cui supervisione consegue il dottorato con una tesi sul concetto di amore in Agostino.
Nel gennaio 1933, Adolf Hitler prende il potere e, a causa delle leggi razziali, ad Arendt viene negata l’abilitazione all’insegnamento nelle università tedesche. In seguito, Arendt viene arrestata dalla Gestapo e detenuta per un breve periodo a causa delle sue ricerche sull’antisemitismo, diventate nel frattempo illegali. Dopo il rilascio, lascia la Germania per traferirsi prima in Cecoslovacchia, poi in Svizzera e infine a Parigi, dove conosce Walter Benjamin. Nel 1940, la Germania invade la Francia: la filosofa Arendt viene privata della cittadinanza tedesca e detenuta nelle carceri francesi come apolide illegale. Nel 1941, scappa negli Stati Uniti d’’America. Diviene un’attivista nella comunità ebraica tedesca di New York, città in cui rimane per il resto della sua vita. Nel 1950, diventa cittadina statunitense. Tra il 1960 e il 1962 segue come reporter della rivista The New Yorker a Gerusalemme il processo contro il colonnello delle SS Adolf Eichmann, il criminale nazista organizzatore dello sterminio degli ebrei d’Europa intrapreso dal regime hitleriano. Muore improvvisamente, nel 1975, a 69 anni per un attacco di cuore.
Le opere principali
Nel 1951, Arendt pubblica Le origini del totalitarismo, uno studio sui regimi nazista e stalinista, che la rende nota; nel 1958, Vita activa. La condizione umana, un libro divenuto ormai un classico della filosofia del pensiero politico in cui si offre un’analisi della società di massa e si denuncia la condizione dell’essere umano contemporaneo condannato a una sostanziale solitudine. La pubblicazione, nel 1963, de La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, provoca una profonda lacerazione con alcuni ambienti ebraici. In questo libro, Arendt illustra come persone ordinarie possano diventare partecipi degli ingranaggi dei sistemi totalitari e pone il problema delle responsabilità dei capi delle comunità ebraiche nell’aver agevolato la politica di sterminio nazista. Il suo ultimo lavoro invece, La vita della mente, è un’opera incompiuta.
La definizione di totalitarismo
Le origini del totalitarismo (tradotto in italiano nel 1967) è un’opera di grandi dimensioni, caratterizzata da un’articolazione piuttosto complessa in cui si affrontano una grande quantità di temi. L’opera è divisa in tre parti: la prima parte tratta dell’antisemitismo, la seconda parte tratta dell’imperialismo, la terza e ultima parte delle istituzioni e delle azioni dei movimenti totalitari, focalizzando l’attenzione esclusivamente sulle esperienze storiche della Germania nazista e dell’Unione Sovietica nel periodo staliniano. Nel testo, Arendt propone una definizione di «totalitarismo» che esclude infatti altre forme di regimi autoritari o dispotici esistenti in altre parti del mondo. Il totalitarismo è inoltre, per Arendt, anche una forma politica radicalmente diversa rispetto alle forme storicamente note di potere autoritario del passato, quali il dispotismo, la tirannide o la dittatura. A differenza di queste forme autoritarie di potere, il totalitarismo si propone non solo la subordinazione politica degli individui, ma anche il controllo della loro vita privata.
Il regime totalitario vuole sostituire la società esistente con una radicalmente nuova e con una diversa forma di umanità. Secondo Arendt, il totalitarismo è dunque strettamente legato al declino dello stato nazionale e al sorgere dell’imperialismo nonché al crollo di ogni classe sociale (dovuto alla disoccupazione e alla miseria) e all’atomizzazione della società di massa. I principali strumenti del totalitarismo sono l’ideologia e il terrore, che trovano espressione nel partito unico. Il terrore, scrive Arendt, costituisce «l’essenza del potere totalitario» (Arendt, 1951, trad. it. 636).
La caduta delle classi sociali – causata da vari fattori come le guerre, le crisi economiche e i conflitti civili – ha generato un gran numero di persone sradicate e isolate, senza legami sociali. In questo contesto, l’ideologia totalitaria trova terreno fertile, presentando una visione del mondo chiara e coerente. Una volta attratte da queste ideologie, le masse vengono persuase tramite la propaganda e controllate attraverso il terrore. Questo terrore sottomette completamente la popolazione, privandola della capacità di discernere tra vero e falso, giusto o sbagliato. Più precisamente, Arendt afferma che «il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste più» (Arendt, 1951, trad. it. 649).
L’essere umano e lo stato totalitario: l’individualità
Questo rappresenta dunque il «cittadino» ideale di uno stato totalitario, un individuo conformista e passivo, ridotto a una sorta di macchina adatta a essere parte di un sistema di dominio totale. Questa forma di dominio si realizza inizialmente privando gli individui della loro personalità giuridica, poi della loro personalità morale, creando quelle condizioni in cui diventa impossibile «fare del bene». Una volta distrutta anche la personalità morale, dell’essere umano rimane solo l’individualità, ovvero la consapevolezza di essere unico. Infine, si passa alla distruzione dell’individualità. Per Arendt, la distruzione dell’individualità equivale alla distruzione della spontaneità, intesa come «la capacità dell’uomo di dare inizio coi propri mezzi a qualcosa di nuovo che non si può spiegare con la reazione all’ambiente e agli avvenimenti» (Arendt, 1951, trad. it. 623).
I sistemi totalitari, dunque, mirano a distruggere ogni forma di spontaneità che l’individualità potrebbe generare e a trasformare ogni persona in un’identità rigida e immutabile. I campi di concentramento e le camere a gas sono fondamentali per i regimi totalitari, fungendo da laboratori per l’annientamento della personalità. Arendt sostiene che l’ideologia totalitaria non si prefigge di cambiare le condizioni esterne dell’esistenza umana né di riorganizzare l’ordinamento sociale in modo rivoluzionario, ma punta «alla trasformazione della natura umana che, così com’è, si oppone al processo totalitario» (Arendt, 1951, trad. it. 628).
Il male radicale e l’insegnamento per il futuro
Il «male radicale» si manifesta proprio in questo: «La riduzione di uomini in quanto uomini a esseri assolutamente superflui, il che significa non già affermare la loro superfluità nel considerarli mezzi da utilizzare, ciò che lascerebbe intatta la loro natura umana e offenderebbe soltanto il loro destino di uomini, bensì rendere superflua la loro qualità stessa di uomini» (Arendt, 1951, trad. it. 1985, 202-03).
Arendt sostiene che le condizioni che hanno permesso l’emergere dei totalitarismi siano ancora presenti o potrebbero ripresentarsi in forme diverse. Le «soluzioni» adottate da quei regimi per affrontare i problemi del loro tempo potrebbero persistere, questa è la preoccupazione di Arendt, anche dopo la caduta di questi regimi, ripresentandosi come tentazioni ogni volta che diventa difficile affrontare in maniera dignitosa problemi quali il sovrappopolamento, le crisi economiche e lo sradicamento sociale. Per questo motivo, è importante non dimenticare che l’atomizzazione sociale e l’alienazione degli individui costituiscono il presupposto che rende possibile l’instaurazione di ogni forma di governo totalitario.
Indicazioni bibliografiche
Opere di Hannah Arendt
1941, «The Jewish army – the beginning of a Jewish politics?», Aufbau, in Kohn, J., Feldman, H., (eds.), Jewish Writings, New York, Schocken Books, pp. 136–39.
1943, «We refugees», The Menorah Journal, 31, pp. 69–77 (Noi profughi, trad. it. in Ead. Ebraismo e modernità, a cura di G. Bettini, Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 23–32 [a]; più recenti, Noi rifugiati, a cura di S. Maletta, Trieste, Asterios, 2020; Noi rifugiati, a cura di D. Di Cesare, Milano, Einaudi, 2022.
1951, The Origins of Totalitarianism (1948), New York, Harcourt Brace Jovanovich (Le origini del totalitarismo, trad. it. a cura di A. Martinelli e con un saggio di S. Forti, Torino, Einaudi, 2004 [I ed. 1967 Edizioni di Comunità]).
1958, The Human Condition, Chicago, University of Chicago Press (Vita activa. La condizione umana, trad. it. di S. Finzi, con una introduzione di A. Dal Lago, Milano, Bompiani, 1989).
1978, The Life of the Mind, a cura di M. McCarthy, New York, Harcourt Brace Jovanovich (La vita della mente, trad. it. di G. Zanetti, con saggio introduttivo di A. Dal Lago, Bologna, Il Mulino, 1987).
Bibliografia essenziale in italiano
Cavarero A., 2019, Democrazia sorgiva. Note sul pensiero politico di Hannah Arendt, Milano, Raffaello Cortina.
Guaraldo O., (a cura di), 2008, Il Novecento di Hannah Arendt. Un lessico politico, Verona, Ombrecorte.
Taraborrelli A., 2022, Hannah Arendt e il cosmopolitismo: stato, comunità, mondi in comune, Milano, Mimesis.
Taraborrelli A., “Hannah Arendt”, in “APhEx 29”, 2024, pp. 1-43.
corriere.it/le-lezioni-del-corriere/filosofia/25_maggio_15/hannah-arendt.shtml