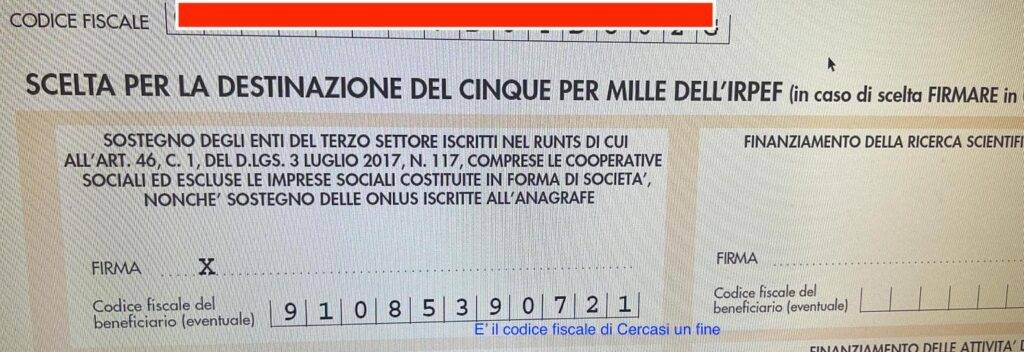Arrivati a questo punto dovremmo avere il coraggio di lasciarci sopraffare. Smettere di difenderci, almeno individualmente, dall’abominio storico di una popolazione senza vie di scampo, che non sopravvive più fra le macerie dei bombardamenti, senza cibo né requisiti minimi di dignità.
Anche tentare questa descrizione di Gaza è strano, riduttivo. Perché siamo oltre la possibilità di rappresentazione, fuori dalla portata massima delle parole. Nelle ultime settimane perfino gli operatori delle Ong che lavorano nella Striscia, quei pochi, sembrano ormai a corto di frasi. Spesso non lanciano più allarmi. Ricorrono a espressioni iperboliche invece, «mai visto prima», «senza precedenti», «oltre». Come se il trauma e la spossatezza li avessero ammutoliti o non trovassero termini di paragone adeguati nell’immaginario comune. Legami possibili con la nostra quotidianità.
Noi, da qui, pensiamo a loro lì, alla popolazione palestinese intrappolata, e non ci siamo mai sentiti a tal punto irrilevanti. Cosa ci farà questo nel lungo termine, cosa farà alla nostra civiltà e in particolare alle nuove generazioni, è tutto da scoprire.
Molte persone che conosco, anche colleghe e colleghi, invitano ad alzare la voce su Gaza, a «farsi sentire». Non è che non stia accadendo e non è che non sia accaduto. Ma andrebbe guardato con altrettanta fermezza il bilancio, fino a qui, dell’essersi «fatti sentire». Il modo in cui il dissenso ha prodotto effetti reali o, al contrario, è stato riassorbito a ogni passo.
Prima e durante le elezioni, ad esempio, c’erano i disordini nei campus americani e in misura ridotta nelle nostre università. Sono stati energici e hanno creato quel minimo d’instabilità utile a livello internazionale. Ma sono anche stati, già mentre si svolgevano, un esempio di come ogni mobilitazione su Gaza lontano da Gaza venisse istantaneamente ridotta a simulacro. Trasformata dalla politica e dai media nell’oggetto stesso della controversia. Sganciata da ciò che denunciava e quindi, in definitiva, disinnescata. È successo in seguito con la nave di Greta Thunberg, con i manifestanti al valico di Rafah eccetera.
Purtroppo la «cosa in sé» è da tempo inguardabile. E la monotonia tragica dei filmati che ci raggiungono dalla Striscia rende necessario variare di continuo il dibattito, spostandolo ora su una polemica accessoria ora su un’altra. L’occupazione militare israeliana si è accompagnata dal principio alla neutralizzazione di ogni dissenso. Le critiche sono state fatte apparire oziose, se non addirittura sospette. Tanto, nella vera Gaza, non poteva e non può metterci piede nessuno.
C’è dell’altro. Osservando come si è evoluta la mobilitazione per la Palestina in ventidue mesi, in Europa e negli Stati Uniti, si ha l’impressione di una consequenzialità recisa fra il sentimento collettivo e l’iniziativa politica. Neppure la decisione improvvisa di Macron di riconoscere lo stato palestinese appare legata a un intensificarsi della pressione popolare sul tema. Ha il merito di essere quanto meno un’azione, l’attestazione da parte di un capo di stato della sofferenza che viene prodotta anche in questo preciso momento e che in questo preciso momento andrebbe fermata. Ma sembra provenire da una misura colma interiore, personale, tutta sua.
Altrettanto personali, per non dire capricciose, sono le esternazioni di Trump (anche sull’Ucraina se è per questo). Mentre da noi non si registra da parte del governo nessuna necessità anche solo di accogliere lo sgomento diffuso su Gaza, nessuna proporzionalità nei toni, nessuna misurazione recente del polso dell’elettorato. Sebbene il polso, con una carestia indotta che fa da sottofondo alla nostra estate, sia decisamente cambiato.
La crisi profonda non è solo della rappresentazione, quindi, ma anche della rappresentatività. Il potere esecutivo — in questo tempo di invasioni senza fine, di occupazioni sfrenate, di fame e sete usate come armi in sfregio a ogni regola — è diventato lontano e incomprensibile. Anzi, non sembra più riconoscere fra i suoi obblighi impliciti quello di essere prossimo e compreso. E così, davanti all’eccidio, noi restiamo non solo privi di parole ma anche di chi dovrebbe averle per noi.
corriere.it/opinioni/25_luglio_26/gaza-parole-a-perdere-davanti-all-abominio-c609fa91-8734-460a-a5b5-d018f358dxlk.shtml