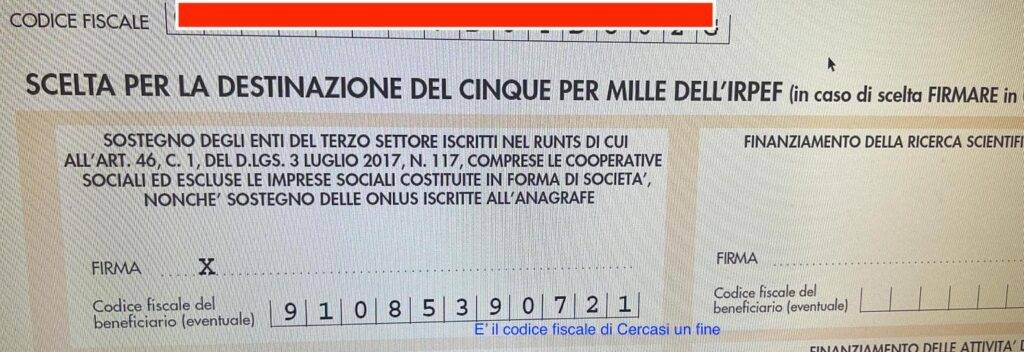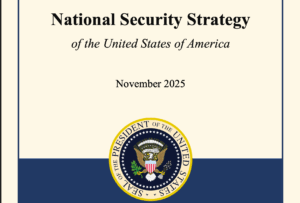Nel 1985, a Bagnoli, i cancelli dell’acciaieria Italsider si chiusero per sempre. Fino a pochi anni prima, l’impianto fumava giorno e notte, illuminando di rosso il cielo di Napoli ovest; migliaia di operai entravano e uscivano a turno, scandendo il tempo della città. Poi arrivò il lento smantellamento: reparti svuotati, macchinari venduti, officine ridotte a scheletri metallici. All’inizio fu uno shock: prime pagine sui quotidiani, interviste ai sindacalisti, delegazioni di ministri in giacca e cravatta davanti alle telecamere.
Ma col passare dei mesi, il clamore svanì. I quartieri intorno rimasero senza lavoro, i bar si svuotarono, le famiglie sopravvivevano con sussidi e lavoretti in nero. La disoccupazione restava alta, i salari bassi, la rassegnazione sempre più radicata. La crisi non era più emergenza: era diventata la normalità.
Nel 1992, a Prato, il ronzio dei telai cominciò a spegnersi. Per decenni, la città aveva vissuto del tessile: capannoni pieni di filati, tintorie che profumavano di lana bagnata, camion che partivano ogni giorno carichi di tessuti diretti in mezza Europa. Poi arrivò la concorrenza straniera, i margini si assottigliarono, e uno dopo l’altro i cancelli delle fabbriche si chiusero.
All’inizio fu un lutto collettivo: assemblee affollate nelle piazze, servizi televisivi, promesse di piani di rilancio. I sindaci chiedevano interventi urgenti, i politici venivano a stringere mani e a parlare di “vocazione produttiva da difendere”.
Poi il silenzio. I capannoni vuoti divennero scheletri di lamiera, l’erba crebbe nelle crepe dell’asfalto, e molti ex operai trovarono impieghi saltuari o emigrarono. La crisi non faceva più notizia. Era diventata il sottofondo della vita quotidiana.
Nel 1994, a Sesto San Giovanni, l’ultimo altoforno della Falck venne spento. Per quasi un secolo, quella città alle porte di Milano era stata “la Stalingrado d’Italia”: acciaio, sindacati, lotte operaie. Le ciminiere erano il suo orizzonte, il fumo la sua aria quotidiana. Poi, nel giro di pochi anni, arrivò lo smantellamento: capannoni svuotati, binari arrugginiti, interi reparti smontati pezzo per pezzo.
All’inizio c’erano cortei ogni settimana, i giornali aprivano con titoli a tutta pagina, i leader di partito salivano sui palchi improvvisati davanti ai cancelli promettendo riconversioni e investimenti. Poi la voce collettiva si abbassò. Le fabbriche dismesse rimasero come ferite aperte nel tessuto urbano, trasformandosi lentamente in scheletri di mattoni e cemento. La disoccupazione restava alta, ma non c’erano più flash dei fotografi: la crisi si era sedimentata, diventando parte del paesaggio.
Perché quello che capita è che se le diseguaglianze crescono rapidamente alterando la percezione dei cittadini allora la sinistra se ne accorge e si mobilita, ma se le differenze tra ricchi e poveri sono lì, stabili da tempo, per quanto inaccettabili, allora la sinistra si adatta e tace. La destra, naturalmente, per suo conto, tace sempre e comunque.
È questo, in breve, il risultato di un ampio studio che Alexander Horn, Martin Haselmayer e Jonathan Klüser hanno appena pubblicato sull’American Political Science Review (“Why Inequalities Persist: Parties’ (Non)Responses to Economic Inequality, 1970–2020”). Uno studio, quello dei tre politologi, basato su una nuova raccolta di dati ottenuta dall’analisi di 850 mila dichiarazioni politiche estratte da 965 programmi elettorali in dodici Paesi OCSE, tra il 1970 al 2020. Il risultato principale è piuttosto sconcertante. Nelle parole degli autori “I partiti di sinistra reagiscono all’aumento della disuguaglianza (…) ma non ai livelli (elevati) di disuguaglianza”. Questa è la ragione per cui “La disuguaglianza non si autocorregge”.
Il primo passaggio necessario per comprendere le reazioni dei vari partiti ai mutamenti del quadro economico è quello di differenziare semanticamente l’idea di “uguaglianza” da quella di “redistribuzione”. Affermare che “crediamo nella parità di diritti per tutte le persone, indipendentemente dall’origine” non è come dire “vogliamo tassare i patrimoni sopra una certa soglia per finanziare la sanità pubblica”. Dire “rispettiamo le differenze culturali” non equivale a dire “aumentiamo le tasse per i redditi sopra il milione di euro”. Le prime sono dichiarazioni sui diritti, le seconde sono impegni a redistribuire la ricchezza da chi ha di più verso chi ha meno.
Nei grandi dataset utilizzati finora per studiare il fenomeno, frasi di questo tipo finivano in maniera indistinta nello stesso “contenitore”, quello della “sinistra economica”. I risultati, quindi, mostravano partiti apparentemente sempre attenti alla disuguaglianza, ma in realtà con il tempo questa attenzione ha cambiato oggetto: dalla dimensione del reddito a quella dei diritti civili. Il nuovo dataset elaborato da Horn, Haselmayer e Klüser, al contrario, identifica con cura i diversi aspetti del tema “uguaglianza”: l’aspetto economico, innanzitutto, legato alla redistribuzione di reddito e ricchezza, poi la questione delle pari opportunità che si sostanziano nell’ambito dell’accesso ai servizi, all’istruzione, alla mobilità e, infine, la dimensione dei diritti civili, con la lotta alle discriminazioni di genere, razza e orientamento sessuale. Per costruire la loro base di dati gli autori hanno analizzato cinquant’anni di programmi elettorali presentati in 12 paesi dell’OCSE, li hanno filtrati attraverso un algoritmo per individuare le sezioni pertinenti e poi hanno affidato la classificazione a centinaia di individui, attraverso un processo di “crowdcoding” su una piattaforma online specializzata.
Da i dati “puliti” in questo modo emerge un primo risultato interessante: la correlazione esistente tra uguaglianza economica e pari diritti è bassissima. Si tratta, cioè, di linee che non si muovono insieme, e che anzi spesso divergono. L’attenzione dedicata al primo aspetto non implica una pari attenzione per il secondo aspetto e viceversa.
Per quanto riguarda l’evoluzione storica dei programmi elettorali, dall’analisi emerge un quadro chiaro: l’attenzione all’uguaglianza economica era alta negli anni ’70; crolla negli anni ’80 e ’90, nell’era della “terza via” di Giddens, Tony Blair e Bill Clinton. È questo il momento cruciale nel quale i partiti di sinistra accettano la logica di mercato – liberalizzazioni, privatizzazioni, deregolamentazione – e, contemporaneamente, attenuano l’attenzione alla redistribuzione. Una tendenza che si invertirà solo dopo la crisi finanziaria del 2008 che porterà nuovamente il tema della giustizia economica se non al centro, almeno tra i temi del dibattito politico. Nel frattempo, l’attenzione ai diritti civili, per fortuna, cresce stabilmente. Emerge in maniera chiara come, per decenni la sinistra, ha spostato l’asse dei propri programmi dalle politiche per la giustizia economica verso i diritti civili e che la confusione semantica tra queste due sfere di intervento ha contribuito ad una narrazione inaccurata e a tratti falsa della lotta della sinistra alle disuguaglianze.
Per quanto riguarda gli aspetti economici c’è un altro fattore che ha alimentato questa narrazione ambigua: la differenza tra il “livello” della diseguaglianza, quanta diseguaglianza, cioè, c’è oggi e le sue “variazioni”, cioè, come si è modificato il livello. Anche il modo in cui la diseguaglianza viene misurata non è neutrale. Il tradizionale indice di Gini è una misura utile e sintetica ma rischia di nascondere espetti importanti del fenomeno. Per questo sarebbe necessario considerare anche i rapporti tra i redditi dei diversi strati sociali: il reddito del novantesimo percentile rispetto a quello del decimo, per esempio, o la quota di reddito del cinquanta percento più povero della popolazione o la quota di ricchezza detenuta dall’un percento più ricco. La differenza è cruciale: mentre l’indice di Gini è sintetico e poco informativo, questi rapporti raccontano storie più dettagliate: quanto i ricchi si allontanano dal ceto medio e quanto il ceto medio si allontana dai poveri.
E allora scopriamo che quando la distanza tra i più ricchi e i più poveri aumenta considerevolmente, il tema dell’uguaglianza economica si fa spazio nei programmi elettorali della sinistra. E a destra? A destra proprio non succede nulla. La questione sembra non riguardarli. Questo risultato, in fondo, non è particolarmente sorprendente. Ce lo si poteva aspettare. La cosa realmente sorprendente, invece, è che quando la disuguaglianza è alta ma stabile, cioè è un dato acquisito all’interno di un certo paese, allora anche la sinistra si paralizza. Quando una società è diseguale, anche fortemente diseguale, ma da molto tempo, la destra come sempre se ne disinteressa, ma anche a sinistra volge lo sguardo altrove.
Cosa c’è dietro a questa insensibilità? Horn, Haselmayer e Klüser individuano tre meccanismi che agiscono di concerto. Il primo ha a che fare con la “visibilità”. I media, e con loro l’opinione pubblica, amano la novità. Un livello alto ma stabile di disuguaglianza diventa rumore di fondo. E senza attenzione mediatica, si fatica a costruire il consenso e per questo i partiti hanno meno incentivi a occuparsene. Il secondo meccanismo è legato al tema della “mobilitazione”. La disuguaglianza scoraggia la partecipazione politica ed elettorale tra coloro che hanno redditi più bassi. In contesti già molto diseguali, i partiti di sinistra faticano a mobilitare il proprio elettorato naturale. Quando invece il divario cresce rapidamente, la minaccia viene percepita in maniera più chiara e questo può riaccendere l’impegno. Il terzo aspetto riguarda quello che gli scienziati comportamentali chiamano “status quo bias”. Le persone per ragioni varie tendono a giustificare l’ordine esistente. Se la disuguaglianza è alta da anni, diventa “normale”. In una società abituata a grandi divari, persino la percezione di giustizia si adatta. Dietro a tale atteggiamento ci sono fattori potenti come l’influenza della crescente retorica meritocratica, la cosiddetta “credenza in un mondo giusto” (just world belief) e la “fallacia del senno di poi” (hindsight bias). Solo cambiamenti repentini rendono evidente l’ingiustizia e riescono a scalfire queste percezioni.
I dati mettono in luce un altro fatto interessante. I partiti di sinistra cono particolarmente sensibili ai cambiamenti del “denominatore”. Ciò significa che ci si accorge maggiormente della crescita delle disuguaglianze quando peggiora la condizione della parte bassa della distribuzione rispetto a quando, invece, cresce la ricchezza di chi è già molto ricco.
Con un atteggiamento di questo tipo il risultato aggregato è che, anche quando la sinistra adotta politiche redistributive e inclusive di contrasto alle disuguaglianze, queste continueranno ad aumentare, più o meno velocemente, ma certamente non si ridurranno. In altri termini i partiti di sinistra si oppongono agli aumenti di disuguaglianza, ma non operano per ridurre i livelli già alti. Il meccanismo gira solo in un senso: si può fermare il peggioramento, ma raramente si torna indietro.
Quali sono le implicazioni operative che emergono da questi dati? La prima ci dice che se davvero vogliamo contrastare un’ingiustificata crescita delle disuguaglianze le dobbiamo renderle visibili anche quando la distribuzione del reddito non cambia. Occorre una narrazione capace di veicolare il messaggio secondo cui lo status quo non è di per sé buono. La persistenza di una situazione di disuguaglianza non è uno sfondo neutro ma produce “costi” quotidiani, in termini di accesso alla casa, alle cure all’istruzione e presenta il rischio di una rottura generazionale. Tutti questi fattori, a loro volta, rappresentano una minaccia per la coesione sociale, per la partecipazione politica, ma anche per lo stesso sistema economico e per la tenuta dei sistemi democratici.
La seconda implicazione è quella che suggerisce di agire sul “denominatore”. Bisogna elevare la condizione di chi sta peggio attraverso una lotta per l’innalzamento dei salari più bassi, il finanziamento di un welfare inclusivo, l’istruzione pubblica di qualità.
Occorrono proposte politiche credibili e concrete, rivendicate con forza e determinazione. perché l’errore più pericoloso è credere che un’ingiustizia smetta di essere tale solo perché ci siamo abituati a conviverci. Le disuguaglianze non si dissolvono, restano lì, come una crepa nel muro che tutti fingono di non vedere, finché un giorno la casa crolla. Se non impariamo a riconoscere i segni della loro persistenza, a renderli visibili anche quando non fanno rumore, la frattura diventerà irreversibile. Perché il tempo, da solo, non cura. Il tempo, quando manca il coraggio, normalizza e consolida.
hilsole24ore.com/art/davanti-disuguaglianze-destra-e-sorda-e-sinistra-e-miope-AH3wVMDC?refresh_ce