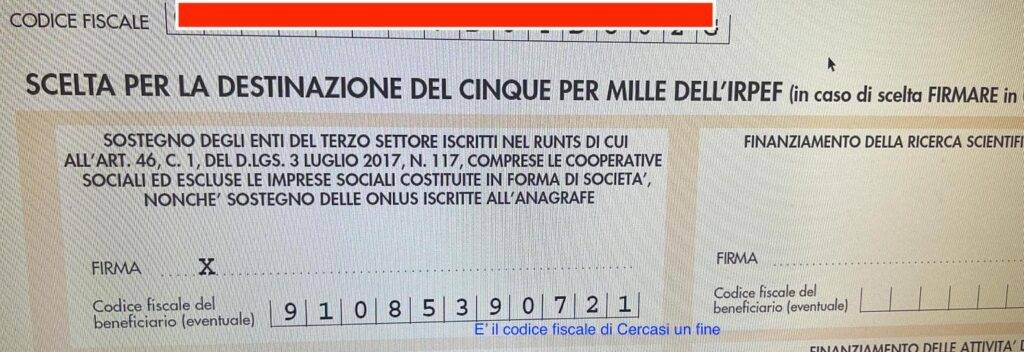«Un hotel per vivere, lavorare e connettersi», si legge nella homepage di The Social Hub (Tsh), «uno spazio per tutti».
Le strutture del gruppo olandese Tsh nascono nel 2006 come The Student Hotel, residenze universitarie private. Il 2012 segna una svolta decisiva: il format si riposiziona e adotta il nuovo nome, The Social Hub. La novità è che non si rivolge più solo a studenti internazionali e fuori sede, ma anche nomadi digitali, trasfertisti, lavoratori e lavoratrici da remoto e turisti. Da campus universitario privato, Tsh evolve così in un vero e proprio campus urbano, un modello esportato in 19 città europee e pensato come enclave per persone di passaggio. Diversificando il target, la società riesce a cogliere le opportunità offerte dalle fluttuazioni della domanda durante tutto l’anno.
Questo modello di ospitalità ibrida permette di far convivere al suo interno hotel, soggiorni prolungati, coworking – frequentati durante tutto l’anno anche da residenti locali – aree eventi, palestra, negozi di ristorazione e altri spazi comuni. Questa sovrapposizione funzionale trasforma ogni metro quadrato in una risorsa multiuso che può generare ricavi da diverse fonti contemporaneamente.
Questo modello sta conoscendo un forte boom in molte città italiane. Le operazioni sono promosse soprattutto da società estere e fondi internazionali, che si presentano alle amministrazioni locali come una possibile risposta al problema abitativo di studenti e giovani professionisti. In realtà, queste strutture si rivolgono a una minoranza economicamente privilegiata e mantengono una forte vocazione turistica. Di fatto, lasciano irrisolto il bisogno abitativo della maggior parte degli studenti, dei lavoratori e delle lavoratrici che non possono permettersi canoni compresi tra 800 e gli oltre 2.000 euro al mese e, inoltre, contribuiscono ad alzare il prezzo medio delle stanze in affitto nelle aree circostanti, producendo quindi un effetto di «elitizzazione» della mobilità ben oltre le proprie mura.
Il format ha più a che fare con la finanziarizzazione dell’abitare e l’estrazione di profitto dalla mobilità piuttosto che con una soluzione abitativa sostenibile. Accanto a grandi complessi particolarmente visibili come The Social Hub – con sedi attive a Bologna, Firenze, Roma e in arrivo a Torino – stanno aprendo in molte città italiane altre strutture di questo tipo quali Camplus, Joivy-DoveVivo, aparto e altre ancora.
Oltre a queste proliferano forme meno visibili ma altrettanto impattanti: come per le piattaforme di intermediazione di affitti brevi, infatti, sono nati siti specializzati in offerta a medio termine, cioè di qualche settimana o mese. Questa offerta diffusa – stanze e appartamenti in diversi quartieri – si mimetizza nella città esistente. A una minor visibilità si accompagnano però effetti evidenti, soprattutto nei quartieri più gentrificati, in cui diversi edifici, all’apparenza semplici condomini residenziali, nascondono decine di coliving.
Questi modelli di abitare, tanto quelli incarnati dai grandi complessi di coliving quanto quelli più diffusi e mimetizzati nelle piattaforme digitali, si rendono attraenti attraverso uno specifico linguaggio che gioca un ruolo centrale nel legittimare la loro presenza in città e nel mascherare gli effetti sociali che producono.
Community non è comunità
Società e investitori che gestiscono studentati privati e hotel ibridi propongono pacchetti in abbonamento che includono piccole unità abitative a prezzi molto alti, giustificati con servizi «all-inclusive» come pulizia, palestra, sala studio, lavanderia, e altro ancora. Ma ciò che vendono è anche la «comunità». «Uno spazio di relazione, scoperta e scambio di idee», promette Camplus, che affitta alloggi a studenti e turisti in 17 città italiane. «Il tuo hub locale per entrare in contatto con la nostra comunità», recita The Social Hub. «Più di un semplice alloggio: una vivace comunità studentesca», assicura aparto, piattaforma di Hines che gestisce strutture ibride in varie città europee.
L’abitare diventa così pratica di consumo, in cui il prezzo non copre solo lo spazio fisico ma anche socialità e accesso a reti di scambio. Ne beneficia chi può permettersi costi elevati e gode del privilegio della mobilità: spesso persone provenienti da paesi con potere d’acquisto più alto, che con pochi clic prenotano una stanza e si garantiscono un appoggio immediato, in attesa – forse – di trovare casa nel mercato tradizionale. Allo stesso tempo, questo modello attrae chi cerca di sfuggire alla solitudine urbana, in contesti in cui lo spazio pubblico e le occasioni di relazione sono sempre più filtrati dal mercato. In questi hub, la socialità è confezionata e programmata come servizio: una comunità, chiamata community, accessibile tramite il pacchetto all-inclusive, un bene immateriale per cui si paga.
La risignificazione è totale: la chiave di casa diventa badge, la comunità si dissolve in una «community» mediata da app, e il sociale viene riscritto in un linguaggio che lo neutralizza, trasformandolo in prodotto acquistabile.
Finanziarizzazione e disuguaglianze abitative
Tutto questo avviene in un contesto, tanto in Italia come in buona parte d’Europa e del Nord Globale, in cui l’abitare è sempre più inaccessibile. Tra le cause dell’inasprimento di questa situazione – considerando che la casa è da sempre al centro della lotta di classe – vi sono fattori legati sia al mercato abitativo sia alla struttura socio-economica: la stagnazione dei salari in Italia negli ultimi vent’anni e l’aumento dei prezzi delle case. Una delle cause principali dell’esplosione dei costi abitativi è la deregolamentazione e privatizzazione degli ultimi quarant’anni.
Questo è il risultato della crescente finanziarizzazione dell’abitare, cioè il processo attraverso cui attori e logiche della finanza entrano al centro della regolazione della casa, trasformandola da bene d’uso e infrastruttura di welfare in un asset su cui far circolare capitali alla ricerca di rendimenti. Anche l’affitto diventa una frontiera centrale di questa trasformazione: interi pacchetti di appartamenti e contratti vengono comprati e gestiti da fondi e società finanziarie. Questo si traduce in meno tutele e più fragilità: canoni che salgono, contratti sempre più brevi e proprietari lontani, difficili da conoscere e da contestare (per un approfondimento sul tema si può leggere Abitare in affitto. Le nuove frontiere dell’estrattivismo immobiliare).
Come ricorda Tim White, il settore finanziario ha contribuito direttamente all’aumento dei prezzi: dopo la crisi del 2008 il mercato abitativo si è concentrato nelle mani di grandi istituzioni finanziarie; nel 2023 circa 1,7 trilioni di dollari in immobili residenziali erano controllati da investitori istituzionali (ossia banche, multinazionali, hedge fund, fondi immobiliari, fondi sovrani, società di private equity e altri intermediari finanziari). Se si considera la casa come investimento, in assenza di regolazioni stringenti, si è portati a volerne trarre la maggiore profittabilità e questo è possibile tramite affitti a breve e medio termine.
Oltre al noto boom della ricettività turistica diffusa, da qualche anno i report dell’Agenzia delle Entrate registrano l’ascesa dei contratti transitori (1-18 mesi), più remunerativi dei contratti 3+2 e 4+4. La durata ridotta consente di aggiustare i termini della locazione a favore dei proprietari, avendo copertura legale per liberarsi più facilmente degli inquilini indesiderati e rialzare i canoni. Il risultato sono città sempre più inaccessibili, dove è difficile trovare affitti stabili persino a prezzi molto alti, in funzione dei profitti attesi dalla messa a valore degli immobili.
Questa non è solo una questione tra privati, tra conduttori e locatari, ma è anche un grosso tema di gestione urbana neoliberale, in cui l’intera città è sempre più dipendente dai capitali finanziari. Questo porta a moltiplicare incentivi e deroghe urbanistiche, dando copertura legale e operando anche in termini di normalizzazione e accettazione sociale di operazioni di finanziarizzazione di grandi spazi urbani, che diventano quindi mezzi di produzione di profitto privato più che servizio alla comunità. La facilitazione dell’abitare a medio termine, tramite concessioni e incentivi alla costruzione di interi edifici, ne è un esempio lampante.
In Italia l’espansione degli student housing accelera, con sostegno politico locale e co-finanziamenti pubblici. I fondi del Pnrr ne sono l’esempio più evidente: sono stati stanziati 960 milioni di euro per 60.000 nuovi posti letto per studenti da produrre entro il 2026, aprendo il settore ai privati di mercato. Con il Decreto 481/2024 il Ministero dell’Università non si limita a cofinanziare le opere, ma si impegna nella copertura di costi di gestione dei primi tre anni, riconoscendo per ogni posto letto quasi 20.000 eur. La profittabilità deriva anche dalla possibilità di gestire le strutture in forma mista, cioè sia a studenti che a turisti e, dopo 12 anni, cadono i vincoli funzionali sulla destinazione d’uso. Ne deriva un modello in cui il privato investe e gestisce con maggiore sicurezza, mentre Stato e Comuni offrono deroghe, facilitazioni procedurali e incentivi fiscali, assumendosi una quota consistente del rischio senza governare davvero l’impatto sui territori e sull’accessibilità abitativa.
Infrastrutture misteriose, disuguaglianze prevedibili
Quando spuntano infrastrutture come The Social Hub parte delle persone residenti inizialmente gioiscono perché vedono aree abbandonate trovare finalmente una destinazione. La percezione positiva è anche frutto dal marketing di queste strutture, che promettono alloggi a prezzi calmierati, oltre a innovazione, cosmopolitismo e, di fatto, l’arrivo di persone «desiderabili». Ma dietro le retoriche della rigenerazione urbana resta la domanda su chi ci guadagni davvero. Dietro l’apparente inclusività dello slogan «uno spazio per tutti» si nascondono barriere economiche e filtri di classe. Le tariffe partono da circa 800 euro al mese per le convenzioni con le università e superano i 2.000 per chi non è studente. Parliamo di stanze oltre gli 80 euro al metro quadrato al mese, mentre in pieno centro a Roma, Firenze o Milano – tra le città più care d’Italia – i canoni si aggirano intorno ai 20 euro al metro quadrato, un prezzo già di per sé altissimo. Oltre all’effetto diretto sull’accessibilità per studenti fuori sede, l’arrivo di queste strutture spinge ulteriormente verso l’alto i prezzi delle case del mercato ordinario.
Queste strutture hanno poi un impatto urbano più ampio. Guardando ad alcuni di questi edifici, come il The Social Hub di Roma, viene in mente una nave da crociera ancorata in città. Innanzitutto per la forma, ma anche perché di fatto è sia un microcosmo autosufficiente (come una città verticale), che un dispositivo che immette quotidianamente flussi consistenti di persone sul territorio. Come una crociera, «sputa» grandi quantità di corpi nel quartiere, attirando taxi, generando traffico e invadendo spazi pubblici, con la promessa di effetti economici positivi, ma ancora tutti da provare. Il guadagno auspicato dagli esercizi commerciali è limitato, in quanto l’enclave ha dentro molto di quello che serve: caffè gratis al coworking, bar glamour in cui socializzare con gente «come noi», addirittura la palestra. Chi vi alloggia è spinto a mangiare, bere, lavorare e socializzare all’interno, dove ogni servizio è integrato nel pacchetto, sentendosi al sicuro. Come nel turismo crocieristico, l’esterno si fa carico dei costi – traffico, affollamento, pressione sugli spazi pubblici, aumento dei prezzi – mentre la quota principale dei benefici economici viene internalizzata dalla struttura e dagli attori finanziari che la possiedono. Il quartiere perde così spazio pubblico, verde urbano e altri servizi realmente accessibili all’intera comunità residente, trasformandosi progressivamente in un luogo pensato soprattutto per attirare popolazioni temporanee.
Ci domandiamo, quindi, che tipo di relazione instaurano queste forme di abitare con il quartiere? Quali trasformazioni producono nella vita sociale e negli equilibri urbani? Sono questioni che richiedono analisi più approfondite e che andranno monitorate con attenzione nel prossimo futuro. Le amministrazioni locali, in particolare, dovranno valutare con attenzione questi progetti, ascoltare i reali bisogni della popolazione, per evitare che intere aree pubbliche vengano progressivamente fagocitate da grandi società immobiliari e fondi di investimento.
*Chiara Davoli è sociologa e attualmente assegnista di ricerca presso l’Università di Urbino. È co-autrice insieme a Stefano Portelli di Abitare in affitto. Le nuove frontiere della speculazione immobiliare. Barbara Brollo lavora come assegnista di ricerca in geografia economico-politica all’università Sapienza di Roma. È autrice di Soggetti, effetti e pratiche urbane delle popolazioni temporanee.
jacobinitalia.it/chi-abita-la-citta/