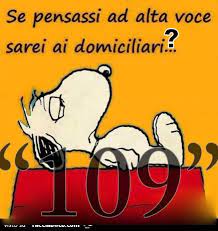“Cos’è la liberté? La libertà. Che libertà? La libertà di fare tutto quello che si vuole entro i limiti della legge. Quando si può fare quello che si vuole? Quando si possiede un milione. La libertà fa ottenere a tutti un milione? No. Che cos’è una persona senza un milione? Una persona senza un milione non è uno che fa tutto quel che vuole, è uno a cui fanno tutto quel che vogliono”. Così scriveva Fëdor Dostoevskij nel 1862, di ritorno dal suo primo viaggio in Europa. In poche righe lo scrittore russo aveva colto una contraddizione destinata a segnare tutto il pensiero politico moderno: la promessa della libertà universale e la realtà di una libertà distribuita secondo la ricchezza. Quella battuta, che allora suonava come una provocazione morale, oggi torna come una diagnosi storica riguardo al rapporto oramai logoro fra capitalismo e democrazia, che investe pienamente il problema della crisi del liberalismo e della libertà.
Un rapporto mai pacifico
Il legame tra capitalismo e democrazia non è mai stato semplice, né lineare. Da un lato è stata l’ascesa della borghesia a produrre – in modo per nulla immediato o privo di frizioni – l’istituzionalizzazione non solo dello stato di diritto, ma del principio democratico della rappresentazione politica. Dall’altro, la storia delle democrazie è anche la storia lunga e tormentata delle lotte per l’espansione di quelle libertà: contro l’esclusione dal voto, contro la disuguaglianza, contro lo sfruttamento.
L’età dell’oro di questo equilibrio – i cosiddetti “trenta gloriosi” del Secondo dopoguerra – aveva trovato una formula apparentemente stabile: capitalismo regolato, welfare state, crescita diffusa. Un compromesso fragile, ma efficace, in cui la politica regolava i mercati e non il contrario. Anche questa volta, però, quel modello non era né universale né privo di contraddizioni: si reggeva su gerarchie e disuguaglianze globali neocoloniali, di genere e culturali. Aveva, cioè, un aspetto inglorioso. Non tutti beneficiavano della promessa democratica del benessere, ma l’idea di un “capitalismo incastonato nella società” (embedded), per riprendere Karl Polanyi, sembrava davvero rendere possibile un rapporto proficuo, per quanto perfettibile, tra capitalismo e democrazia. Certo, da uno sguardo marxista esso appariva come la cloroformizzazione delle lotte per la vera emancipazione universale, mentre dal punto di vista neoliberale si trattava dell’anticamera del totalitarismo collettivista: per i neoliberali per salvare il capitalismo bisognava limitare di molto la democrazia. Come noto, sono i secondi ad aver vinto la battaglia delle idee, che ha seppellito gli ideali del liberalismo sociale e della socialdemocrazia.
La rottura neoliberale
Per i neoliberali, il liberalismo sociale e socialdemocratico era una forma di socialismo illiberale e irrazionale, al quale bisognava opporsi. Solo la libertà economica pienamente dispiegata nel mercato produceva una società libera, ossia una società dove la cooperazione si costruiva spontaneamente senza coercizione, per mezzo della competizione economica; essa sola era la garanzia della libertà politica. Lo Stato-benessere era infatti irrazionale sul piano economico, ma anche “ingovernabile” su quello politico: sia perché costantemente attraversato da lotte sociali che lo rendevano debole, incapace di verticalità e preda dei conflitti fra gruppi, sovraccarico di domande; sia perché i politici governavano per essere rieletti, non in base a principi razionali. I neoliberali attaccavano, quindi, non solo l’interventismo economico, ma anche la sovranità popolare: volevano uno Stato minimo e forte al contempo.
Già nel 1980 Norberto Bobbio aveva registrato questo cambiamento: se storicamente il liberalismo aveva attaccato lo Stato socialista “ora viene attaccata la democrazia puramente e semplicemente”, perciò “l’insidia è grave”. “Non è in gioco soltanto lo Stato-benessere, ovvero il grande compromesso storico fra il movimento operaio e il capitalismo maturo, ma la stessa democrazia, ovvero l’altro grande compromesso storico precedente fra il tradizionale privilegio della proprietà e il mondo del lavoro organizzato, da cui nasce direttamente o indirettamente la democrazia moderna (attraverso il suffragio universale, la formazione dei partiti di massa e così via),” scriveva nel saggio Liberalismo vecchio e nuovo.
Dagli anni Ottanta il diversificato paradigma neoliberale si è affermato. Così dal “capitalismo incastonato” si è passati a un “capitalismo messo al riparo” (encased) dalla democrazia, come ha scritto Quinn Slobodian. I neoliberali volevano un mondo diseguale, ma privo di guerra perché regolato da un mercato globale che avrebbe promosso il “doux commerce”: per fare questo cercavano un modo di limitare la democrazia, ma senza mai poterla eliminare del tutto.
E oggi? A che punto siamo oggi, mentre la guerra imperversa? Cosa resta delle conquiste democratiche e sociali? Dopo aver messo in discussione il welfare state e la sovranità popolare, il neoliberalismo è giunto a mettere in discussione tutti gli altri limiti alla libertà del capitale, compresi i diritti umani e lo stato di diritto? Ma ancora si può parlare di neoliberalismo? È possibile ripensare il nesso fra capitalismo, liberalismo e democrazia?
Cos’è la libertà?
Dalla democrazia alla neo-oligarchia finanziaria e transnazionale
Da modello universale (poiché imperiale) l’Occidente si è ormai “provincializzato” e con esso la democrazia liberale, sostiene il filosofo Carlo Galli nel suo contributo, che apre il dossier: “The West is The Rest”. Modello politico minoritario al di fuori del mondo euro-atlantico, al suo interno appare oramai in declino. Anni di neoliberalismo hanno infatti prodotto società “post-democratiche” o, meglio, “neo-oligarchiche”, il cui volto è fatto di “liberismo in crisi, populismi subalterni, società informi e divise, emergenzialismi, neo-autoritarismi, società e Stato digitalizzati, in cui il soggetto è non controllore ma controllato”. Tuttavia, la diagnosi non è solo pessimismo; Galli insiste sul ruolo dell’organizzazione collettiva e dell’elaborazione teorica: “senza movimento dal basso non c’è speranza di mutamento” ma “perché ci sia azione ci deve essere pensiero, idea”.
L’altra faccia del dominio neo-oligarchico è un regime di storicità presentista, che impedisce l’immaginazione e la progettazione del futuro: è questa dimensione temporale che la filosofa Marina Calloni indaga nella sua analisi. Con la fine della socialdemocrazia è venuta meno “una delle più forti immagini simboliche del patto sociale novecentesco: la tripartizione del tempo. Otto ore di lavoro, otto ore di riposo, otto ore di vita per affetti e svago”, mentre il tempo di lavoro e di vita si fondono assieme nel capitalismo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Nell’economia digitale e transnazionale di oggi, d’altronde, si contribuisce a produrre valore anche solo comunicando da uno smartphone. Opporsi a questa nuova forma del dominio richiede quindi di riappropriarsi del tempo, agendo su una scala spaziale che non potrà essere localista, bensì transnazionale, come lo sono i poteri politici, tecnologici ed economici che oggi controllano il mondo.
Questi ultimi non si comprenderebbero senza analizzare il processo di finanziarizzazione dell’economia avvenuta negli ultimi trenta, quarant’anni. Per lo storico Alessandro Volpi, esso “si è tradotto nella creazione di un monopolio concentrato ora nelle mani dei grandi fondi americani – le cosiddette ‘Big Three’ (BlackRock, Vanguard, State Street) – che gestiscono il risparmio globale”. È stata la politica a rendere possibile il loro immenso potere, a cui oggi essa stessa è sottomessa. In questo quadro, Donald Trump costituisce una discontinuità e una continuità: da un lato, il presidente statunitense rifiuta questa sottomissione, dall’altro sa che questo rifiuto non è possibile fino in fondo, dal momento che dalle Big Three dipende buona parte del debito statunitense, e quindi dei servizi a cui possono accedere i cittadini, oramai ridotti risparmiatori, senza una vera libertà politica. Si tratta di un processo globale, che oggi sembra investire pienamente anche l’Europa.
Il problema europeo
D’altronde l’Europa è “stretta in una morsa fra Stati Uniti e Cina”, incapace di agire come potenza autonoma, divisa da interessi nazionali, eppure condannata all’integrazione se vuole sopravvivere, come sostiene l’economista Michele Salvati nell’intervista qui pubblicata. L’unica via per l’Unione Europea è quella di una vera federazione, con una politica economica e internazionale comune. Una proposta che spaventa molti, per il rischio di un’ulteriore deriva tecnocratica e neoliberale, ma che Salvati considera inevitabile: “quale sarebbe l’alternativa? Lo status quo di tante piccole politiche nazionali, o la rinuncia dell’Europa a contare nel nuovo ordine mondiale?”. Si tratta dell’unica possibilità anche per salvare quel che resta della democrazia liberale in Europa, già svuotata da anni di politiche neoliberali, nonché per rifuggire il compimento di una svolta autocratica, che oggi ha investito molti Paesi occidentali, in primis gli Stati Uniti. Non è però detta l’ultima parola nemmeno per la democrazia a stelle e strisce, che forse potrebbe riprendersi.
La condizione perché ciò accada sembra essere non solo che Trump vada a casa, ma anche che il Partito Democratico statunitense riesca davvero ad avviare delle politiche adeguate alle sfide dei tempi. Per l’economista Emanuele Felice, questo tentativo era stato già fatto con la “Bidenomics”. L’ex presidente americano Joe Biden è infatti intervenuto sull’indebitamento, sulla transizione climatica e sul sostegno ai redditi più bassi ma, scrive Felice, “non ha avuto la forza di introdurre la seconda gamba necessaria: una riforma fiscale progressiva, capace di colpire le rendite e redistribuire ricchezza”. È lo stesso limite che affligge l’Europa: l’incapacità di affrontare la disuguaglianza, le discriminazioni e lo sfruttamento con nuove politiche sociali redistributive e inclusive. Eppure, proprio da lì potrebbe passare un nuovo patto democratico. Felice invita allora a “normalizzare l’eccezione” del Pnrr – il Piano nazionale di ripresa e resilienza – trasformando la spinta espansiva e redistributiva della risposta europea alla pandemia in una politica strutturale che sappia affrontare i problemi collettivi.
Post-liberalismo o recupero del liberalismo politico?
Il liberalismo ha sempre tenuto fuori dal proprio orizzonte di senso i problemi collettivi “sociali” e “planetari”, perché l’individuo è il suo principio d’ordine, sostiene la filosofa Wendy Brown nell’intervista pubblicata in questo dossier. Per questa ragione, il “liberalismo è esausto” e occorre ripensare la democrazia in ottica “post-liberale” e “riparativa”. La “riparazione” non implica l’idea di un “risarcimento”, piuttosto ha a che fare con una “ricucitura”: deve “riparare” la separazione fra l’essere umano e la società e dalla natura, che anni di neoliberalismo hanno prodotto, assieme al nichilismo e al particolarismo identitario. Per realizzarla lo Stato è ancora necessario: “gli Stati sono cruciali per mettere in atto le decisioni, per organizzare e applicare regolamenti, restrizioni e limiti. Credo che la questione che ci troviamo ad affrontare oggi sia come mantenere gli Stati subordinati alla democrazia, invece di considerarli icone democratiche. Penso che il compito che abbiamo davanti sia capire come separare gli Stati da essa”.
Se per Brown, dopo anni di neoliberalismo, l’alternativa non potrà che avere principi “post-liberali”, per la filosofa Lea Ypi bisogna restituire alla libertà il suo significato politico, quindi recuperare i contenuti politici e morali della tradizione liberale, contro il neoliberalismo e la svolta autoritaria. La libertà non è assenza di vincoli, ma partecipazione alla costruzione del mondo comune. Essa è principalmente “freedom from fear”: libertà dalla paura del dominio, dello sfruttamento, della povertà o della morte evitabile. Così pensata, allora, è una forma di potere di autodeterminazione, che per essere davvero tale deve essere universale e democratica. Per salvare questa libertà democratica occorre lottare: analizzare e denunciare in modo persistente le contraddizioni del presente e rifiutare l’ideologia conservatrice dell’autoregolazione, tale per cui il potere è impersonale e diffuso, quasi come se fosse inevitabile.
Il meglio della tradizione liberale è stata in fondo la lotta per la presa del potere dei senza potere, che nella storia si è poi istituzionalizzata nella democrazia: è questa lotta che ancora oggi deve essere caparbiamente riaffermata. La domanda dostoevskiana “che cos’è la libertà?” è ancora oggi un campo di battaglia.
reset.it/articolo/capitalismo-e-democrazia-unintroduzione