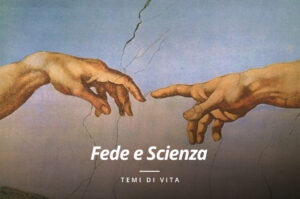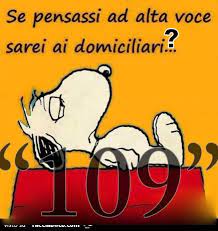Mi interesso da tempo alla questione della fede nella sua dimensione antropologica, in particolare al tema della fiducia di base (basic trust) intesa come esperienza incoativa di fede. Affronto tale questione consapevole del fatto che diversi filosofi separano radicalmente fede e ragione, fede/teologia e filosofia, fede e scienza. È ben nota l’affermazione di Baruch Spinoza secondo cui «tra fede o teologia e filosofia non c’è commercio, né parentela; nessuno che conosca lo scopo e il fondamento di queste due discipline, che sono completamente diverse, può ignorarlo. Lo scopo della filosofia è unicamente la verità; quello della fede, unicamente l’obbedienza e la pietà».
Un giudizio così severo è naturalmente respinto dai teologi; ciò che qui mi interessa è verificare se e in quale misura esso sia rifiutato anche in ambito filosofico e scientifico. Tra le letture che ho recentemente ripreso, vi è il ricco quarto volume della Teologia della Rivelazione, dedicato a Fede, Tradizione, Religioni. Avevo già intervistato il prof. Giuseppe Tanzella-Nitti sul mio canale YouTube (Trovi qui: la prima e la seconda puntata dedicate alla sua opera) e avevamo discusso diversi temi di teologia fondamentale ispirati ai suoi quattro volumi. In questa #1pagina1libro desidero soffermarmi su un punto specifico del pensiero del prof. Tanzella-Nitti, il quale proviene dal mondo scientifico (laureato in astronomia all’Università di Bologna, già ricercatore CNR presso l’Istituto di Radioastronomia di Bologna e successivamente astronomo all’Osservatorio Astronomico di Torino).
La fede, certo, non deriva da una deduzione astratta né da una mera constatazione empirica. Con grande onestà intellettuale, l’autore osserva che «la fede non è scienza, ma senza fede non c’è scienza, né conoscenza». Vi è inoltre una differenza sostanziale tra la fede teologica — risposta all’autocomunicazione di Dio — e la fede nelle sue forme filosofiche, che non è risposta a una parola accolta da un “Altro”, ma «risposta a una parola ascoltata nella propria coscienza, dischiusa dal volto dell’altro, nascosta nelle pieghe della realtà». Tale fede filosofica concerne soprattutto l’ambito morale e può divenire principio di prassi. Tanzella-Nitti osserva che «la “fede filosofica” può assumere, con Kant, i risvolti di una fede nell’imperativo categorico avvertito dalla coscienza, mentre in Blondel è fede nell’esistenza di un fine verso cui l’azione umana tende e dal quale è sostenuta».
La fede filosofica
Ma in che senso l’attività filosofica può essere associata a una «fede filosofica»? L’autore spiega che ogni attività conoscitiva è generata da un’affermazione, almeno implicita, di senso. Ora, affermare un senso significa credere in un senso: è un assentire a una verità presente — in forma manifesta o latente — nella realtà. Conoscere è acconsentire al reale, è impegnarsi per il reale; tale impegno costituisce un autentico atto di fede. La filosofia, essendo la pazienza dell’interrogare, presuppone una fiducia implicita nella sensatezza del reale: un atto di fede che non viene meno neppure di fronte a «un’affermazione irreversibile di assurdità e di nonsenso». La filosofia nasce da una ricerca di senso e dalla fede che tale ricerca, per quanto oscura e ostacolata, rimanga nondimeno sensata. Qui risiede ciò che l’autore definisce «la dimensione fiduciale del conoscere», che caratterizza l’approccio filosofico: l’essenza del gesto filosofico consiste nel domandare, e nel farlo confidando nella capacità veritativa della conoscenza umana e nella conoscibilità stessa del reale.
In una pagina significativa del De docta ignorantia (1440), Nicolò Cusano ricorda che la fede è l’inizio della conoscenza: «I nostri antichi hanno tutti concordemente sostenuto che la fede è l’inizio della conoscenza. In ogni disciplina si presuppongono principi primi, che si apprendono soltanto mediante la fede e dai quali si trae la capacità di intendere le cose da trattare con dimostrazione. Chi vuole ascendere a una dottrina è necessario che creda a quei principi senza i quali non può ascendere. […] Dove non c’è una fede sana, non c’è neppure una vera comprensione».
La fede scientifica
Ma la fede può svolgere un ruolo anche nella conoscenza scientifica? È questo l’aspetto forse più interessante dell’analisi dell’autore, poiché la domanda è tutt’altro che banale. La scienza — e molti scienziati — si definisce conoscenza oggettiva, impersonale e pienamente comunicabile. Ma l’introduzione di una dimensione fiduciale, anche minima, non comprometterebbe lo statuto di oggettività e la pretesa di universalità e verificabilità?
Analizzando la fenomenologia del lavoro scientifico, Tanzella-Nitti mostra che anche la scienza presenta la medesima «struttura fiduciale e personalista» che si riscontra in altre forme del conoscere. La scienza, infatti, non muove dal nulla: essa presuppone un’affermazione di senso e manifesta una dimensione fiduciale espressa nel ruolo della scuola, della tradizione, dell’autorità. «Nessun ricercatore è un verso sciolto», nota l’autore, «ma parte di una specifica comunità scientifica […] caratterizzata da un proprio approccio metodologico, da una propria interpretazione del reale e da una propria visione delle cose».
Alcuni scienziati parlano esplicitamente di “fede scientifica”, riferita alle premesse filosofiche della scienza, alla stabilità non ambigua del reale, all’ordine e all’intelligibilità della natura. L’autore cita tra gli altri Einstein, Polanyi e Planck. Mi limito qui a riportare due affermazioni particolarmente eloquenti.
Albert Einstein osservava: «La scienza può essere creata soltanto da chi sia totalmente vocato alla verità e alla comprensione. Questa fonte emotiva, tuttavia, scaturisce dalla sfera della religione. Ad essa appartiene anche la fede nella possibilità che le regole valide per il mondo dell’esistenza siano razionali, cioè comprensibili per la ragione. Non riesco a concepire uno scienziato genuino che difetti di tale fede profonda».
Max Planck, dal canto suo, ricordava che ciò che fa avanzare la scienza non è soltanto il dato empirico, ma anche la forma mentis plasmata dalle convinzioni personali, che costituiscono «premesse extra-scientifiche» del lavoro scientifico — in un certo senso una vera e propria «fede». Nelle sue parole: «Chi ha veramente collaborato a costruire una scienza sa per propria esperienza interiore che sulla soglia della scienza sta una guida apparentemente invisibile: la fede che guarda innanzi. Non c’è principio che abbia recato maggior danno, per l’equivoco a cui si presta, che quello dell’assenza di premesse nella scienza. Le fondamenta di ogni scienza sono fondate dal materiale che l’esperienza fornisce, è vero; ma è altrettanto certo che il materiale da solo non basta, come non basta la sua elaborazione logica, a fare».
In fondo, come conclude giustamente Giuseppe Tanzella-Nitti, «la “fede scientifica” si esprime anche, e forse soprattutto, nel modo in cui lo scienziato si pone di fronte al reale. Egli presta fiducia alla realtà fisica e alle sue leggi, al dinamismo insito nei fenomeni della materia e della vita, persuaso che, in ultima analisi, il “reale non ci inganna”».
theologhia.com/2025/11/anche-la-scienza-ha-bisogno-della-fede.html