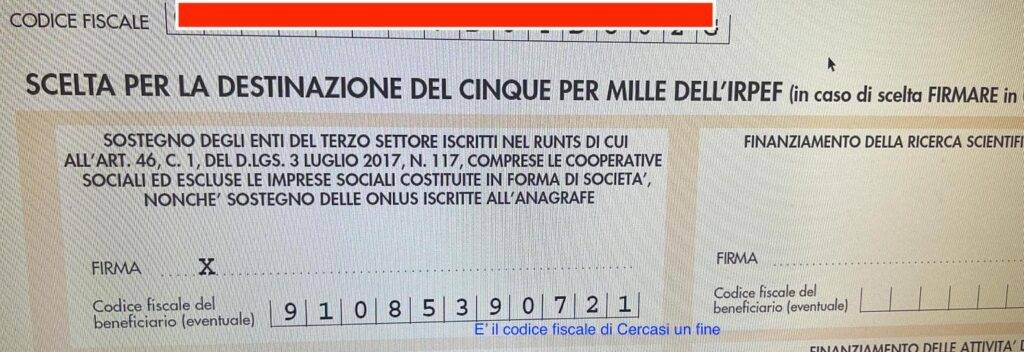Viviamo in un’epoca torbida, confusa, inquietante. Le molteplici crisi che attraversiamo da tempo – sanitaria, ambientale, economica, sociale, generazionale, geopolotica – ci lasciano irrequieti e incapaci di gestire il carico emotivo che costantemente comportano, tanto che sempre più spesso ci ritroviamo a far finta che vada tutto bene, a fingere di non aver paura. È forse questo il sentimento predominante del nostro tempo. Pur essendo uno stimolo naturale, un’emozione ancestrale, sviluppata in tempi lontanissimi come risposta immediata di fronte a pericoli contingenti, capace di spingerci a metterci in salvo e quindi anche positiva, la paura provoca tensione, un senso di offuscamento della realtà, ci spinge a chiuderci in noi stessi. È in questo meccanismo che si insinua l’uso che, in tutto il mondo, ne fa certa politica per metterci gli uni contro gli altri, deteriorare le libertà e limitare i diritti. Guardando al lungo – abbastanza lungo – periodo, i progressi evidenti sotto molti aspetti sono innegabili ma, arrivati al settantacinquesimo anniversario dell’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, non si può certo dire che siamo giunti all’appuntamento a testa alta.
Quando il 10 dicembre 1948, l’Assemblea generale dell’Onu riunita al Palais de Chaillot, nel cuore di Parigi, approvò la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Seconda guerra mondiale era terminata da poco, ma l’orrore della Shoah e il timore delle bombe nucleari era ancora vivo nei ricordi di tutti. I lavori si aprirono nel 1947 e la prima stesura del testo venne presentata pochi mesi prima del suo voto, a settembre. A presiedere l’incontro è Eleanor Roosevelt, ex first lady americana e attivista politica. Composta da un preambolo e trenta articoli, quarantotto Stati si impegnano a difendere un principio fondamentale fino ad allora rinnegato dai vari dittatori del Novecento: ogni uomo, donna o bambino è titolare di una serie di diritti universali inalienabili, che nessuno Stato può negare. Si riponeva la propria fede in valori universali, capaci di tutelare la libertà e la dignità di tutti gli esseri umani.
Soprattutto, la Dichiarazione, basandosi sul concetto di interdipendenza dei diritti umani e affiancando quindi a quelli civili e politici anche quelli economici, sociali e culturali – come il diritto all’istruzione, al lavoro, a una remunerazione equa, alla sicurezza sociale, a migrare, la libertà di espressione –, riconosceva che non esiste una gerarchia né eccezioni geografiche. Appartengono a ognuno, in ogni dove. Inoltre, l’idea semplice e rivoluzionaria alla sua base è che i diritti non sono concessi né vanno guadagnati, ma sono intrinseci a ogni persona. Dopo l’approvazione della Dichiarazione, al Segretario generale fu chiesto di pubblicarne e distribuirne il testo non solo nelle cinque lingue ufficiali dell’Onu – cinese, francese, inglese, russo e spagnolo – ma anche in quante altre fosse possibile per garantirne la massima diffusione. In apertura, l’articolo uno: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
Sapevamo già, a metà Novecento, e sappiamo oggi, quanto al di là di ogni impegno nazionale i diritti umani siano costantemente a rischio e che la loro difesa non può essere un lavoro individuale, ma un processo collettivo da non considerare mai concluso. Secondo il Democracy Index 2022, infatti, solo l’8% della popolazione mondiale vive in una cosiddetta “democrazia perfetta”. L’Italia rientra tra quelle “imperfette”, occupando la 34esima posizione globale e perdendo tre posti rispetto all’anno precedente. In generale, il punteggio complessivo di 5,29 su 10 rappresenta una stagnazione rispetto al processo di recessione democratica a cui stiamo assistendo dal 2016 a questa parte: l’effetto positivo del ritorno a una sorta di nuova normalità è stato annullato dagli sviluppi negativi che si sono susseguiti a livello globale.
In Afghanistan, le recenti modifiche alle leggi matrimoniali del Paese sono un concreto esempio di come i talebani stiano privando le donne dei loro diritti, insieme ad aver limitato fortemente il loro accesso all’istruzione e al lavoro, averle bandite dai parchi pubblici, aver vietato i contraccettivi e imposto un abbigliamento ultraconservatore. In Iran, le proteste si susseguono dallo scorso autunno, dalla morte della giovane Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia per aver indossato male il velo, con una risposta popolare così ampia che viene ancora portata avanti al grido di “donna, vita, libertà”. A Hong Kong, divisa tra un passato coloniale e un presente di repressione, la democrazia continua a essere sotto processo con la legge sulla sicurezza nazionale della città, che ha portato all’arresto di decine di attivisti e alla chiusura di varie testate giornalistiche.
Alle porte dell’Europa, l’invasione russa dell’Ucraina prosegue ormai da più di un anno, mostrando quanto molte delle illusioni consolidatesi nel cosiddetto occidente dopo la fine della guerra fredda fossero destinate a infrangersi. Ad accomunare chi lotta in tutto il mondo sono soprattutto due cose: la resistenza contro l’oppressione e il desiderio di libertà.
Poi, mentre una parte del mondo discute dell’opportunità di aggiornare i diritti umani fondamentali, un’altra, quella dei sovranisti e dell’estrema destra, in tutto il mondo mette in discussione anche quelli più basilari, come il diritto alla vita, alla libertà e alla scelta, o il diritto all’aborto, sacrificati sull’altare di una sovranità non meglio definita se non dalla necessità di mascherare l’assenza di contenuti dietro la presunta difesa di un’appartenenza comune e che trova nell’Altro, nel “diverso”, un capro espiatorio. Basta guardare agli Stati Uniti e all’Europa, dove il 2022 è stato rispettivamente l’anno in cui sono state presentate più leggi anti-trans e il periodo più violento dell’ultimo decennio per la comunità LGBTQ+.
Le prime vittime del giro di vite sui diritti sono poi i migranti: coloro che, a causa delle conseguenze di una globalizzazione gestita male e di un cambiamento climatico praticamente ignorato, della guerra, delle persecuzioni o delle iniquità, lasciano la loro casa per trovare asilo altrove. L’ultima tragedia, avvenuta al largo della Calabria pochi giorni fa, è il sintomo di quanto sia pericoloso criminalizzare le ong che salvano vite in mare, fare propaganda sulla pelle dei migranti e gridare ai confini chiusi. La responsabilità sta anche nell’assenza di una solida politica europea in materia: come dimostrano i fatti, lo scaricabarile tra i governi non ferma le rotte di migrazione sempre nuove, ma rende solo più pericoloso attraversarle. Serve una politica comunitaria, che nel nostro Paese si sostanzi anche nel rafforzare le vie di accesso sicure e legali, senza ritrovarsi ad ascoltare slogan sugli “invasori” o “i taxi di mare” per alimentare l’idea di un nemico comune. Come spiegano Roberto Saviano ed Elodie nella nuova stagione di Basement Café by Lavazza, incentrata proprio sulle celebrazioni dei 75 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani, “La natura stessa suggerisce che soltanto la collaborazione permette la creazione. L’integrazione nasce soprattutto da un atteggiamento politico di apertura”.
La paura, si diceva, è il sentimento del nostro tempo. Di ogni tempo, quando utilizzata per deteriorare le libertà e limitare i diritti. Tra tutti i suoi contrari che i dizionari riportano più frequentemente – il coraggio, l’audacia, la calma, la serenità, la tranquillità –, ne manca uno da cui, invece, dovremmo lasciarci ispirare: la speranza, intesa non solo nel suo portato affettivo e psicologico, ma come vero e proprio atto orientativo. “L’importante è imparare a sperare. Il lavoro della speranza non è rinunciatario perché di per sé desidera aver successo invece che fallire”, scriveva lo scrittore e filosofo tedesco Ernst Bloch. “Lo sperare, superiore all’aver paura, non è né passivo come questo sentimento né, anzi meno che mai, bloccato nel nulla. L’affetto dello sperare si espande, allarga gli uomini invece di restringerli, non si sazia mai di sapere che cosa internamente li fa tendere a uno scopo e che cosa all’esterno può essere loro alleato”. Un principio che riguarda tanto il piano della ricerca individuale quanto quello della Storia, e che si apre al concetto di utopia, cioè un luogo che non esiste ancora ma che potrebbe, e che per Bosch abbraccia ogni aspetto, non solo politico e sociale, sostanziandosi non tanto in un banale ottimismo quanto nella lotta, nella relazione, in una collettività realizzata o potenziale.
Nel corso della nostra esistenza ci interroghiamo continuamente su noi stessi e il mondo che ci circonda, chiedendoci quali siano i nostri valori, come ci rapportiamo con gli altri, qual è il nostro posto nel più grande insieme dell’umanità. Se a oggi, 75 anni dopo l’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, a essere vulnerabili sono ancora la libertà e la dignità di ogni essere umano, evidentemente questo presente non è abbastanza – se non per noi, per molti e molte altre. Immaginare e muoversi, insieme, verso un orizzonte carico di nuove possibilità, significa partire dal rimodellare la nostra relazione con l’Altro, comprendere cosa deve essere tagliato e che cosa ricucito se vogliamo dare una possibilità al fiorire di una e più comunità globali, dove il perno dell’agire siano il rispetto, l’accoglienza delle differenze, l’apprendimento reciproco. Serve desiderare per vivere e vedere oltre la tensione del presente. Nonostante oggi il termine utopia sia utilizzato principalmente nella sua accezione negativa e limitativa, infatti, la possibilità di lasciar guidare le proprie azioni dalla speranza apre al rifiuto del qui e ora e insiste sulla potenzialità concreta di un altro mondo, permettendoci di immaginare e, soprattutto, di creare un altrove e poi. Un luogo dove la difesa dei diritti di ciascuno sia davvero una responsabilità condivisa.