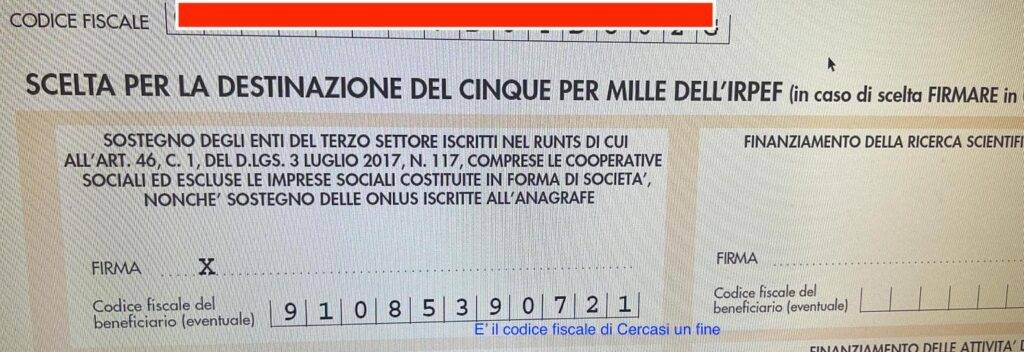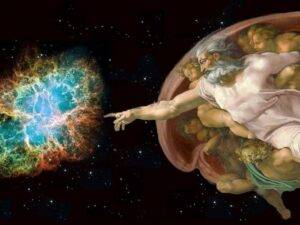Il raid israeliano sulla capitale del Qatar, Doha, per eliminare la leadership di Hamas nelle ore in cui dovevano discutere la proposta di accordo degli Stati Uniti su Gaza, ha sconvolto molte cancellerie mediorientali. Il voto all’ONU, dove gli Stati Uniti hanno fatto passare la condanna del raid, potrebbe aver cominciato a cambiare qualcosa – sebbene il colloquio tra Trump e l’emiro del Qatar sia in corso mentre scrivo. Da questo colloquio dipende molto, anche l’eventuale ripresa dei negoziati per Gaza.
Intanto ieri 142 Paesi hanno votato all’ONU la risoluzione che propone la formula dei due Stati, israeliano e palestinese, libero da Hamas che dovrebbe disarmare e liberare tutti gli ostaggi con un cessate il fuoco permanente. Contro hanno votato Israele, Stati Uniti, Argentina, Ungheria, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nuova Guinea, Paraguay e Tonga, 12 gli astenuti.
È il piano franco-saudita, un percorso che si protrarrà fino al 22 settembre, quando la Francia ed altri dovrebbero riconoscere lo Stato di Palestina. La cronaca poi procede nella tragedia, con un milione di palestinesi che resterebbero intrappolati a Gaza-city, i più perché incapaci di fuggire di nuovo.
Tutto questo è in drammatica evoluzione ora per ora, con scenari foschi e il vertice arabo-islamico in Qatar ormai alle porte, avrà luogo domenica e lunedì.
La teoria più diffusa sul mondo arabo che conta, quello del Golfo, porta a galla la necessità di chiarire la qualità dei rapporti con Trump: “se Washington non garantisce il Qatar allora non garantisce nessun altro”. Ci sarà un’inversione esplicita, a partire da regole per Israele?
Per di più questo riguarda Trump, il presidente su cui i monarchi del Golfo hanno puntato. Ma questa teoria, l’urgenza di chiarire le vere intenzioni degli Usa come garanti anche militari, non è diffusa per una loro effettiva solidarietà con il Qatar, che solo nel 2017 tentarono di strangolare economicamente con un blocco commerciale, diplomatico e di viaggio che non ha precedenti, ma perché consapevoli che il loro rapporto con Washington non è più profondo di quello del piccolo emirato qatarino.
Amico di tutti, da Netanyahu a Kamenei, da Trump ad Hamas, da Erdogan ai vertici del calcio mondiale, il Qatar è ormai un player mondiale come loro, sebbene limitato da una piccolezza terrestre che gli impone questa scelta di amicizia a tutto campo. Proprio per questo però ospita la base americana più importante in tutta la regione. Dunque se il Qatar può essere colpito anche loro devono considerarsi esposti. Qualcosa cambierà? Si vedrà, intanto credo che sia importante capire i monarchi arabi del Golfo. Impresa non facile.
Alle attente orecchie dei leader arabi del Golfo poi non sarà certo sfuggita la notizia che il gruppo khomeinista libanese Hezbollah è riuscito a ritrovare nuove vie di “approvvigionamento”: si parla di centinaia di milioni di dollari arrivati nelle sue casse. Hezbollah è stata sconfitta da Israele, ma la forza, forse, non basta.
Gli arabi devono averne dedotto che Teheran non rinuncia alla sua influenza regionale, forse usando le criptovalute, o gli spalloni che attraverso Iraq e Siria: nonostante la caduta dei regimi legati agli iraniani, si stanno ricostruendo vie di contatto e di passaggio da Teheran fino a Beirut. Il capitolo non è chiuso.
Dunque i monarchi del Golfo, comunque la si pensi su di loro, non possono permettersi di apparire ininfluenti, devono dimostrare che contano anche agli occhi delle loro opinioni pubbliche e dei vicini. Interessati sopra ogni altra cosa alla stabilità, i monarchi arabi del Golfo non sembra che possano fare altro che restare ancorati all’idea di una soluzione a due Stati.
Un cessate il fuoco, dare ai palestinesi un loro Stato e disarmare Hamas non li farebbe apparire impotenti, potrebbe sciogliere la rabbia della disperazione, contenere il possibile contagio interno ai loro Paesi e indirizzare le energie verso la ricostruzione. È la strada che propongono i sauditi.
Questa è la monarchia–guida, impegnata in un lavoro interno di una portata impressionante. Sanno benissimo che il loro regno si è fondato su un patto: la tribù dei Saud lo strinse con una piccola setta eretica, i wahhabiti: questi legittimavano religiosamente la conquista di tutta l’Arabia da parte della piccola tribù dei Saud ai danni delle altre tribù, mentre i Saud si offrivano come loro strumento per diffondere quel messaggio eretico, quello integralista, letteralista, reazionario. Le moschee edificate un po’ ovunque lo testimoniano.
Bin Salman ha rotto il patto, sta rifacendo l’apparato religioso e ha cominciato un lavoro di ricostruzione di identità centrato non più sulla fede ma sul nazionalismo: l’orizzonte trumpiano, MAGA, è fatto per lui: Make Arabia Great Again. Questa grandezza passa necessariamente per il superamento della dimensione tribale, sebbene il suo regno sia costruito proprio sul potere di una tribù, la sua i Saud, che si sono imposti con la forza sulle altre tribù arabiche; ora sono tutti sauditi, non più Rashid e altro ancora.
Bin Salman punta sul nazionalismo, “Arabia first”, perché con il nazionalismo conta di riconvertire l’economia, creare un sistema di tecnici, insomma uscire da una struttura arcaica di società e realizzare una modernizzazione a tappe forzate, comunque inserita nel paradigma tecnocratico, e lui pilota dall’alto.
È evidente che ha un disperato bisogno di stabilità, perché il petrolio può finire e per usare i soldi non come un bancomat a disposizione di altri bisogna investire in sé stessi, crescere: questo lo vedeva con la pace con Israele e la copertura militare americana. Ma la deflagrazione palestinese – che era stata pensata da molti ridotta a questione di “polizia locale” – ora gli impone di cercare una soluzione vera e che quindi non riaccenda ma lenisca i dolori e gli estremismi destabilizzanti.
La questione palestinese da un punto di vista di “sistemi di potere” è stata usata per due scopi: da una parte legittimare l’espansionismo iraniano che voleva e forse vorrebbe conquistare l’Islam (per vendicarsi degli arabi che li sconfissero islamizzandoli tanti secoli fa, il khomeinismo vorrebbe conquistare l’islam); dall’altra legittimare le legislazioni emergenziali in realtà varate per silenziare ogni dissenso interno per corruzione, repressione, voti truccati (lo slogan di Nasser, “nessuna voce sopra la voce della battaglia” aprì questa strada).
È molto interessante che giunti a questo crocevia i sovrani e i presidenti arabi si riuniscano domenica e lunedì, ma non da soli, con tutti quelli islamici. Serve un mantello. Colpisce questa frase citata dalla stampa araba e attribuita al saudita bin Salman: “serve una risposta araba, islamica e internazionale per confrontare l’aggressione e scoraggiare le pratiche criminali di Israele”.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno già convocato l’incaricato d’affari israeliano. Dunque siamo a fatti davvero nuovi. Ma prendenfosi cura dell’emergenza forse servirebbe anche un’idea alla quale ancorare la propria visione. Come i Paesi del Grande Levante (Libano, Siria, Iraq), anche i Paesi del Golfo sono diventati Paesi complessi, fanno affidamento su lavoratori e tecnici giunti da altri Paesi, confidano in investimenti.
Bin Salman vuole salutare la società arcaica, ma allora potrebbe servire cominciare a portare nella realtà l’inclusività, il pluralismo sociale, i diritti di cittadinanza per chi vuole contribuire a edificare questi nuovi “Paesi”. Ecco che progredire su questa strada con la cittadinanza renderebbe la visione coerente.
Per i palestinesi, oggi al centro di un vero ciclone, essa può arrivare solo con uno Stato sovrano accanto a Israele (che poi potrebbe sviluppare in una Confederazione forse estesa alla Giordania). Ma il discorso sarebbe rivolto a tutti, facendo i conti con la realtà del Levante in senso estensivo, terra plurale, non lo si può intendere altrimenti.
E il pluralismo può diventare una forza se si crede che sia un bene, non un male. Cambiamenti così non si fanno in un giorno, ma è possibile avviarli e alle volte le crisi lo richiedono.
È stato questo, la cittadinanza, il messaggio di fondo della Primavera: la Primavera è stata sequestrata e dirottata con bande armate dai regimi paralizzati dal terrore della democrazia. È stata un urlo per uscire dal tribalismo (che impone fedeltà claniche) e diventare cittadini.
Oggi la Primavera è la sfida culturale che i giovani arabi hanno prodotto per ricostruire sé stessi. Le tattiche, i passi realisti, servono a tutti gli Stati ma hanno bisogno di un orizzonte nel quale inserirsi all’ombra di una proposta regionale, che dunque non può che partire anche da una ridefinizione di sé e dal dramma di Gaza.
Gli arabi hanno conosciuto uno shock epocale quando l’Europa che li aveva fatti sognare li colonizzò: si divisero tra panarabisti laici, che volevano combattere gli eserciti europei per creare la grande nazione araba (assopendosi all’ombra di totalitarismi sempre più tribali e crudeli), e panislamisti, che volevano combattere i colonialisti ma respingendone lo strumento colonialista, lo Stato laico.
Le corone del Golfo hanno posto fine a questa guerra fredda araba rinunciando al panislamismo, i regimi laici sono affogati nel loro affarismo stragista (Saddam, Assad, Gheddafi). Oggi non bastano i capitali per restituire agli arabi il ruolo che gli compete. La Primavera ha indicato una strada, la cittadinanza.
Per riuscirci c’è una mappa, una Magna Charta per incamminarsi. È il Documento sulla fratellanza umana firmato ad Abu Dhabi da Francesco e il grande imam di al Azhar. È quella la base culturale che serve per ripartire e candidarsi a ricostruire il Mediterraneo, con gli altri.
settimananews.it/informazione-internazionale/il-medio-oriente-dopo-il-raid-di-israele/