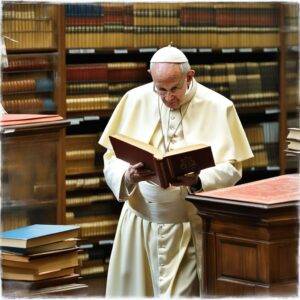Il tornado Francesco è passato e, come accade dopo le vere tempeste, la Chiesa universale si ritrova allo sbando, gli arredi cambiati di posto e molti protagonisti si chiedono come ricostruire la baracca e al “tornare come prima”, al prevedibile, al “si è sempre fatto così”. Nessuno esce indenne dalla tempesta profetica di papa Bergoglio, che ha sconvolto tutto in un’istituzione ancorata all’immobilità.
Perché questo è stato Bergoglio: un profeta. E un grande profeta, uno che profumava di puro Vangelo e, con la sua sola presenza, sconvolgeva e agitava l’atmosfera curiale ed episcopale, suscitando o sequele incondizionate o profonde diffidenze e insospettati timori.
I vescovi, soprattutto quelli rifugiati nel comfort dello status quo, camminavano con i piedi di piombo di fronte a un papa che non aveva paura di chiamare le cose con il loro nome o di condannare gli abusi di potere (incluso il clericalismo) alla stessa tavola dei principi della Chiesa.
Ora, con Leone XIV l’aria si è calmata – o almeno così sembra – e la vecchia gerarchia, soprattutto quella più conservatrice, sta timidamente rialzando la testa. “La paura è passata”, dicono nei corridoi e nelle mense episcopali. “Il peggio è passato”. I prelati, che hanno subito le stroncature di Francesco, si sentono di nuovo a loro agio e credono di intravedere una nuova opportunità per riconquistare il loro posto al sole ecclesiale, di dettare l’agenda e di ripristinare l’ordine e i privilegi perduti.
Il nuovo papa sembra loro – almeno a priori – più gestibile, prevedibile, qualcuno a cui si possa spiegare la “gravità di certe cose” senza correre il rischio di imbattersi in uno slancio di indignazione profetica da parte del papa gaucho, che non usava mezzi termini quando si trattava delle cose di Dio.
Tuttavia, il ricollocamento ecclesiastico non è e non sarà pacifico o automatico. I vescovi più progressisti provano un sordo senso di orfanezza: sono rimasti orfani di un profeta. Abituati a trovare rifugio, ispirazione e persino opportunità per andare avanti sotto l’ala protettrice di Bergoglio, ora esitano, restano in silenzio, osservando da che parte soffierà il vento curiale e quale sarà l’impulso che Leone XIV intende imprimere alla Chiesa: continuerà ad essere in uscita ed aperta a tutti, o la primavera è finita?
I moderati, sempre attenti all’equilibrio (della tiepidezza) e all’efficacia, restano in allerta, attenti ai segnali per sapere cosa aspettarsi, quale enfasi dare e come adattare il discorso al nuovo clima papale.
In fondo, tutti cercano di posizionarsi: aspettano la parola, il gesto o la nomina che stabilirà la tendenza e dirà loro se il pendolo oscillerà indietro, in avanti o rimarrà fermo. Nel frattempo, il clericalismo, questo virus così resistente che Francesco ha denunciato senza pietà, sta cercando di riorganizzarsi, di ricostruire alleanze e di tornare al suo antico splendore .
Si tratta di un male così grave e così radicato nel tessuto ecclesiale che nemmeno il profeta Francesco è riuscito a porvi fine; è stato solo temporaneamente sulla difensiva. Ora si sente con un desiderio di vendetta, pronto a riconquistare privilegi, controllo e quei giorni d’oro in cui gli abiti talari, i rocchetti di pizzo e le pianete aprivano più porte della coerenza e della radicalità evangeliche.
Leone XIV gli permetterà di scatenarsi? Questa è la domanda da un milione di dollari. Il nuovo papa procede con cautela, consapevole del vespaio che lo circonda. Sa che il clericalismo è il vero avversario di una Chiesa sinodale, missionaria ed evangelizzatrice. Sa anche che il cambiamento non si impone solo attraverso leggi e discorsi, ma attraverso la prassi, la comunità e il potere distribuito. Dalla sua fermezza – e dalla sua capacità di non lasciarsi strumentalizzare da entrambe le parti – dipenderà se il tornado di Francesco non sarà stato solo una lunga parentesi, ma un vero e proprio “kairós”, un prima e un dopo irreversibili.
Perché dopo il profeta viene il normalizzatore. Ma una Chiesa fedele allo Spirito non può permettersi di perdere l’orizzonte del Regno a causa del ritorno di vecchie abitudini. Toccherà a Leone XIV dimostrare se la calma è solo un’attesa tesa… o il preludio di una nuova Pentecoste che concluda finalmente la lotta contro questa tentazione clericale che impedisce alla Chiesa di sentire di nuovo il profumo del Vangelo.
E in tutto questo processo dove si inseriscono la Chiesa sinodale e la Chiesa laica?
Il pontificato di Francesco ha aperto in modo decisivo la strada alla sinodalità: consultazioni, assemblee, processi di ascolto e di partecipazione di tutto il Popolo di Dio – laici, donne e giovani – con una voce reale nel discernimento ecclesiale. La sinodalità ha cessato di essere uno slogan e si è tradotta in strutture, metodologie e una rinnovata teologia della corresponsabilità. Con incluso un calendario di attuazione.
Con Leone XIV si è percepito finora un impegno formale per la continuità di questo processo. C’è un’espressa volontà di mantenere canali di partecipazione più ampi e consultazioni autentiche prima delle nomine e delle grandi decisioni. Tuttavia, il clima di “normalizzazione” e il rinnovato emergere del clericalismo – favorito da settori che vedono il nuovo papa come più dialogante e meno dirompente – mettono a rischio una silenziosa inversione di tendenza dell’impulso sinodale, se non si gestisce con fermezza.
Il pericolo, come si è già vissuto dopo altri periodi riformisti, è che la sinodalità rimanga come retorica dell’inclusione, priva dell’audacia trasformante che l’ha caratterizzata sotto Francesco. Tutto dipenderà dai fatti concreti: se i laici continueranno ad avere una partecipazione effettiva o se, a poco a poco, il peso ricadrà nelle vecchie mani della gerarchia.
La Chiesa laicale: in attesa, sulla difensiva o alla riscoperta del suo protagonismo
Per la Chiesa laicale – quest’immenso “popolo santo di Dio” che sostiene la vita quotidiana delle comunità, la carità, la catechesi, la missione e la presenza pubblica – questo è un momento di incertezza, ma anche di opportunità. Dopo l’ondata di protagonismo che le è stata concessa dal pontificato di Francesco, la tentazione sarebbe quella di relegarla ancora una volta in secondo piano.
I rischi sono due: che la “normalizzazione” venga interpretata come un ritorno al clericalismo che riduce i laici a semplici assistenti dei pastori, oppure che la stanchezza e la mancanza di riconoscimento portino a una pericolosa smobilitazione in un momento di crisi di vocazioni e di mancanza di credibilità sociale della Chiesa.
Allo stesso tempo, la struttura sinodale e la recente memoria del protagonismo laicale possono trasformarsi in un fermento affinché i laici rivendichino – ed esercitino – il diritto e il dovere della corresponsabilità, anche di fronte a resistenze interne.
Il fattore decisivo: fatti, non solo parole
Il ruolo della Chiesa sinodale e laicale in questa nuova fase dipenderà in ultima analisi dalle decisioni concrete: i canali sinodali saranno mantenuti e ampliati? Si realizzerà la partecipazione del Popolo di Dio nei processi di discernimento, elezione e missione? I laici, e in particolare le donne, avranno un reale accesso a spazi decisionali? Oppure ci si muoverà verso una sottile ricentralizzazione sotto l’apparenza dell’equilibrio e della calma?
Insomma, la Chiesa sinodale e quella laicale sono a un bivio. Hanno guadagnato terreno e consapevolezza con Francesco, ma ora devono difendere il loro spazio e rivendicarlo come proprio, affinché la primavera ecclesiale non diventi un ricordo ma l’orizzonte permanente di una Chiesa veramente in uscita e in comunione. La palla è, ancora una volta, nel campo dello Spirito e del coraggio di tutto il santo popolo di Dio. E, naturalmente, nelle mani di papa Leone XIV, un papa che, in quanto missionario, è radicalmente sinodale.
Articolo pubblicato il 31.7.2025 nel Blog dell’autore in “Religión Digital” (www.religiondigital.org).
Traduzione di Lorenzo Tommaselli