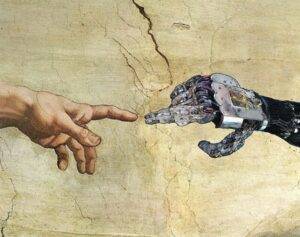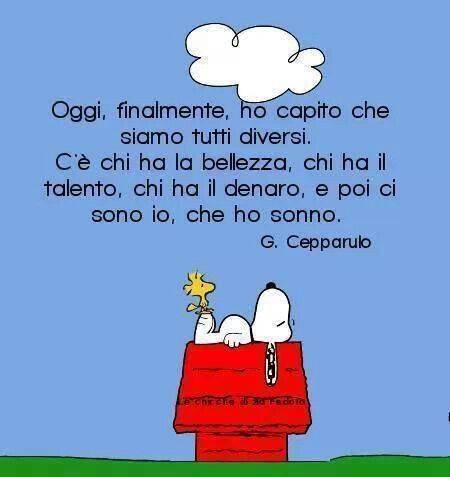Come possiamo orientare i modelli economici verso l’inclusione e la sostenibilità? È questo un interrogativo che da subito mette in luce la stretta connessione tra sistemi di produzione, salvaguardia dell’ambiente e problemi di fame e denutrizione. Questioni che, se non correttamente affrontate, possono determinare instabilità globali molto preoccupanti.
Secondo l’ultimo rapporto dal titolo “Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo”, a cura di cinque agenzie specializzate delle Nazioni Unite, nel 2023, circa 733 milioni di persone hanno sofferto la fame, equivalenti a 1 persona su 11 a livello globale. Lo stesso rapporto evidenzia che oltre 2,3 miliardi di persone nel mondo affrontano livelli moderati o gravi di insicurezza alimentare, il che significa che quasi 1 persona su 3 non ha accesso regolare a cibo nutriente e sufficiente. Dati che sono in aumento significativo e pertanto indicano l’urgenza di interventi per combattere la fame e la malnutrizione. In particolare, è l’Africa la regione con la più alta percentuale di popolazione che non ha cibo a sufficienza: circa il 20% a fronte dell’8% in Asia e del 6% in America Latina. Sono 298 milioni gli africani che hanno affrontato tale condizione nel 2023.
La fame e la denutrizione che colpiscono tante persone nel mondo sono il risultato di profonde ingiustizie e polarizzazioni che si manifestano palesemente quando parliamo di accesso al cibo che, come sappiamo, è un diritto umano fondamentale tutelato a livello internazionale da diversi trattati e istituzioni. Eppure, alcune discrepanze appaiono evidenti: se da un lato le economie avanzate si caratterizzano per sovrabbondanze, sprechi alimentari e per l’insistente ricerca di cibi biologici, dall’altro i paesi più poveri sono afflitti tanto da carenze di cibo quanto dalla diffusione di junk food. In altre parole, in molte parti del mondo, è notevole il numero di persone che non dispone di cibo sicuro, nutriente e sufficiente.
Queste povertà e insicurezze alimentari sono una chiara evidenza dei numerosi limiti del modello economico dominante e non possono essere considerate una semplice esternalità negativa di un modello che funziona bene. Sono invece un sintomo delle laceranti disuguaglianze tra paesi e all’interno dei paesi, nonché del numero crescente di donne e uomini che sono in condizioni di povertà estrema. Una condizione che non si limita alla sfera economica, ma si estende a quella sociale con ripercussioni nell’accesso, oltre che al cibo e all’acqua, anche alle cure mediche e all’educazione. L’inaccessibilità di queste risorse per molti costituisce un affronto alla dignità personale.
Si rendono dunque necessarie azioni congiunte per sviluppare un sistema agricolo e alimentare più inclusivo, sostenibile e resiliente che, sostenuto da ricerca scientifica e innovazione tecnologica, promuova un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. L’ottica è quella che studiosi ed esperti chiamano agroecologia, ossia un’agricoltura che integri principi ecologici e sociali nelle pratiche tradizionali e innovazioni scientifiche per promuovere sistemi alimentari sostenibili, così come emerso nel colloquium scientifico organizzato di recente dalle università cattoliche europee nella sede di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Parallelamente, nella lotta per contrastare fame e denutrizione, un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la positiva influenza che il libero commercio può avere nel contrasto alle povertà alimentari, così come è stato documentato in diversi studi scientifici. Se ne comprende la ragione ricordando che l’Africa è un continente che ospita il 60 percento delle terre arabili non coltivate del mondo ma, nel contempo, importa cibo per 43 miliardi di dollari all’anno. Va pertanto in questa direzione l’African Continental Free Trade Area (AfCFTA), ossia l’accordo commerciale attivo dal gennaio 2021 e promosso dall’Unione Africana per creare un mercato unico continentale per beni e servizi. La nuova area commerciale libera in Africa va vista favorevolmente poiché è previsto possa contribuire, indirettamente ma significativamente, a contrastare fame e denutrizione in Africa attraverso un aumento della produzione agricola e una riduzione di costi e prezzi di beni alimentari. Obiettivi tuttavia, quelli dell’AfCFTA, che si scontrano evidentemente con l’emergente politica dei dazi a livello globale, che, se applicata determinerebbe al contrario implicazioni negative anche in relazione all’accesso al cibo.
*Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore
ilsole24ore.com/art/un-agroecologia-battere-troppe-disuguaglianze-cibo-AHpMmaq