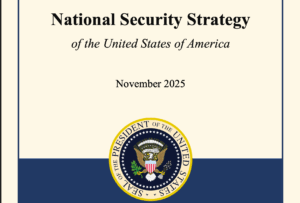Nel cuore della storia dell’Occidente, il cristianesimo ha rappresentato una svolta radicale nel modo di concepire il sacro. Secondo molti interpreti, è proprio questa tradizione religiosa ad aver compiuto la secolarizzazione del sacro: un paradosso solo apparente, se si considera che il suo fondamento è un Dio che si fa uomo. L’Incarnazione, al centro del messaggio cristiano, rompe la distanza tra divino e umano, tra trascendenza e immanenza. Non è più l’uomo che si eleva verso il sacro, ma è il sacro che discende nella carne, nella storia, nella fragilità dell’esistenza umana. Questo evento non ha solo una portata teologica, ma è il punto di partenza di un’intera civiltà.
L’Occidente, infatti, si è sviluppato a partire da questo presupposto fondamentale: la centralità della persona, la dignità della vita terrena, il valore dell’esperienza individuale e comunitaria. Senza il cristianesimo, non si comprenderebbe l’enfasi che la modernità ha posto sull’essere umano, sulla sua libertà e sulla sua responsabilità. La cultura dei diritti, il pensiero democratico, la fiducia nella storia come luogo di redenzione possibile – anche se profana – affondano le radici in quell’idea cristiana che ha fuso sacro e umano, che ha reso l’altro degno di cura perché immagine di Dio.
Per molti secoli, questo equilibrio è stato mantenuto grazie al ruolo che il cristianesimo ha svolto come religione civile. Attraverso la liturgia, la ritualità, le celebrazioni collettive e i simboli condivisi, il sacro è rimasto una dimensione viva del tessuto sociale, anche nei suoi aspetti più civili e quotidiani. I riti cristiani hanno dato forma e senso al tempo, ai passaggi della vita, ai legami comunitari. Il sacro non era solo un’esperienza individuale o mistica, ma un collante sociale, un riferimento culturale condiviso.
Oggi, tuttavia, questo ruolo si è molto ridimensionato. La religione, almeno nei Paesi occidentali, ha ridotto progressivamente la sua funzione pubblica. Il cristianesimo non è più la religione civile dell’Occidente, e con esso sembra perdersi anche la capacità di coniugare sacro e umano, rito e società. La modernità, con la sua pretesa di autonomia assoluta della ragione e dell’individuo, si è sviluppata spesso come un progetto nichilista, volto a espellere ogni riferimento al sacro o al trascendente. L’uomo, nella sua autosufficienza, finisce però per diventare misura di tutto: ma un uomo senza oltre, senza mistero, è anche un uomo esposto al rischio dell’eccesso, del delirio di onnipotenza, o al contrario della disperazione.
È in questa cornice che si possono comprendere le molte spinte fondamentaliste che attraversano oggi tutte le tradizioni religiose, compresa quella cristiana. Di fronte a una modernità che sembra svuotare ogni senso, molte culture reagiscono irrigidendosi, chiudendosi, contrapponendo il sacro come legge assoluta all’umano vissuto come decadenza. È una reazione speculare al nichilismo, e altrettanto pericolosa: perché sacrifica l’umano in nome del divino, perdendo così la novità radicale che il cristianesimo aveva portato nel mondo.
La vera sfida, oggi, è allora quella di curare l’eccesso di uomo senza negare l’umano. La Chiesa si trova di fronte a un compito inedito: mostrare che il sacro autentico non è ciò che si oppone alla vita concreta, ma ciò che la attraversa, la redime, la trasfigura. È in questa direzione che si è mosso il messaggio di papa Francesco. La sua insistenza sul volto dell’altro, sulla carne dei poveri, sull’ecologia integrale, sulla tenerezza come linguaggio divino, indica una via in cui il sacro si lascia riconoscere proprio là dove l’umano è più fragile e più vero.
Non si tratta di tornare indietro, a un passato in cui il sacro era imposto dall’alto, né di rinunciare al confronto con la modernità. Si tratta di raccogliere il cuore del Vangelo e declinarlo nell’oggi: un Dio che continua a farsi uomo, che continua ad abitare le periferie, che continua a chiamarci a una fraternità concreta, che si fa interpellare dal volto dell’altro. Il sacro, per essere credibile oggi, deve passare attraverso la carne dell’uomo, deve entrare nei suoi conflitti, nelle sue domande, nelle sue ferite. Questa è la sfida più grande della Chiesa contemporanea, ed è l’eredità più alta che Francesco lascia al mondo: un cristianesimo che non separa mai Dio dall’uomo, perché sa che è proprio lì, nell’umano, che il sacro si rivela.
avvenire.it/opinioni/pagine/la-dove-l-umano-e-piu-fragile?_